Premessa
Category Archives: saggi
Diffused Religion And Civil Society In Italy
Premessa
Quando si parla di società civile si intende mettere in evidenza l’esistenza di una realtà sociale che corrisponde all’intera società ma che tende a distinguersi da apparati pubblici o di rilevanza pubblica che pure sussistono nell’ambito della stessa società e che sono ad essa preposti con lo scopo di sovrintendervi.
E dunque lo stato è una struttura che deriva dalla società civile ma che poi è deputato a reggerne le sorti in chiave politica, legislativa, finanziaria. Anche la chiesa, come forma religiosa organizzata, si trova ad operare nella società ma in qualche modo tende a prescinderne, attraverso le sue proprie forme gerarchiche, sovente impegnate a dettare norme etiche ed indicazioni procedurali.
Vi è perciò una sostanziale ambiguità nella società civile in quanto tale: essa ha la sua autonomia ma si trova poi a dover fare i conti con altre entità da essa stessa scaturite eppure in grado di condizionarla anche pesantemente.
Il contrasto fra la società civile e lo stato, fra la società e la chiesa (o le chiese), rientra in una serie di modalità tipiche delle relazioni che si creano fra l’insieme degli individui sociali come singoli associati e le varie istituzioni presenti nella società in cui essi sono collocati.
Questa condizione ancipite comporta andamenti ad intra ed ad extra non facilmente governabili dal singolo soggetto o dai gruppi sociali e neppure dalle normative vigenti. Quando poi si tratta di operare delle scelte etiche il divario tende ad estendersi, allontanando sempre più i singoli ed i gruppi dalle istituzioni, accentuando una distanza già evidente ma poi enfatizzata da motivi contingenti.
Specialmente quando un ente come lo stato o la chiesa vuole imporre il suo punto di vista (che è poi quello espresso da una élite di soggetti individuali speciali che si trovano al governo dell’ente, provvisoriamente o in via definitiva) il conflitto con i cittadini o i fedeli si acuisce e può far luogo a forme di contestazione se non di rifiuto e rigetto.
Molte rivoluzioni, se non tutte, nascono appunto da tale divergenza di opzioni e di fatto di interessi. Gli uni tendono a mantenere il dominio dall’alto del potere attribuito ed esercitato, gli altri resistono alle imposizioni ed a diversi tentativi di etero direzione. L’esito è sovente a carattere fortemente dicotomico: l’una e l’altra parte non dialogano, restano sulle proprie posizioni, difendono la propria indipendenza e soprattutto non cercano e dunque non trovano formule d’intesa. Insomma il compromesso non sembra rientrare fra le abitudini di una società che tende a rivendicare la sua primazia storica rispetto a strutture statali e religiose e respinge ingerenze sulle sue decisioni a livello attitudinale e comportamentale.
The idea of diffused religion
Il ruolo della religione diffusa
A ben considerare, quella che da tempo è stata definita come religione diffusa, cioè come set di valori, pratiche, credenze, simboli, atteggiamenti e comportamenti non del tutto conformi al modello ufficiale della religione-di-chiesa, quasi corrisponde o almeno corrisponde in buona misura ad una parte significativa della società civile. Non si sovrappone perfettamente a quest’ultima ma certamente ne costituisce la quota statisticamente più rilevante. In altri termini la religione diffusa abbraccerebbe un ambito maggioritario della società civile e ne rappresenterebbe il trend principale in chiave di orientamento nei riguardi della chiesa. Non tutta la società civile, quindi, collima con il modello della religione diffusa, in quanto essa comprende anche la religione-di-chiesa come pure la dimensione dell’ateismo, dell’indifferenza, dell’agnosticismo. Intanto però la religione diffusa sembra interpretare le istanze portanti ed importanti come peso esercitato all’interno dell’intera società.
In particolare la religione diffusa deve comunque essere distinta dalla religione civile. In essa non si tratta di recuperare la vecchia idea di Rousseau o quella più recente di Bellah. Né l’una né l’altra si adattano al caso italiano. Il contesto della prima era settecentesco e pedagogico-filosofico, quello della seconda – pur sociologico – è tuttavia riferito al territorio statunitense con caratteristiche per nulla rinvenibili sulla penisola italica (dal concetto di popolo eletto a quello di centralità dei testi biblici). Soprattutto non è legittimo sostituire la stessa idea di religione a quella di società. Un conto è la religione un altro conto è la società, almeno sul piano dell’analisi sociologica. Insomma non è equiparabile la religione civile alla società civile, perché sono due elementi a parte. Semmai si può parlare di una religione diffusa all’interno della società civile ed eventualmente di una religione civile (da definire di volta in volta) all’interno della società civile.
D’altro canto il ruolo della religione diffusa è precipuamente di auto-difesa dei credenti non allineati, non sintonizzati sulla lunghezza d’onda del magistero ecclesiale e delle direttive della gerarchia ecclesiastica. Ovviamente non va trascurato un effetto non voluto derivante da una religione diffusa particolarmente orientata a contestare o trascurare i dettami magisteriali: una qualche propensione ad una individualizzazione accentuata del pensare e dell’agire così da allentare anche la tensione in chiave di società civile e di partecipazione attiva alla cittadinanza politica e sociale. Tale allentamento può anche essere una premessa per ulteriori andamenti, tali da favorire esiti autoritari, dovuti all’assenza di interessi di natura pubblica e comunitaria.
Invero però la religione diffusa è anche un luogo di dibattito, realizzabile fuori dell’egida ecclesiastica, in grado di promuovere relazioni amicali, creare e sviluppare opinione pubblica, difendere i diritti umani e civici, rispettare la pluralità delle posizioni ideologiche.
Invero la religione diffusa è anche un luogo di dibattito, realizzabile fuori dell’egida ecclesiastica, in grado di promuovere relazioni amicali, creare e sviluppare opinione pubblica, difendere i diritti umani e civici, rispettare la pluralità delle posizioni ideologiche.
La religione diffusa è anche parte della società religiosa che si confronta con la società politica (sia statale che partitica e sindacale) e dunque è tenuta a tenere conto di interlocutori diversi, sia all’interno del suo riferimento confessionale sia all’esterno (stato, partiti e sindacati).
Se si può dare per scontato che società civile e società politica siano intimamente correlate e reciprocamente funzionali, altrettanto è possibile dire della stessa religione diffusa che sia pure indirettamente arriva a legittimare la stessa struttura religiosa che le fa da scenario. Insomma l’intreccio è inestricabile: la religione diffusa supporta comunque la chiesa ed entrambe insieme fanno da sostegno alla società civile di cui sono parte non eliminabile. Anche l’azione del singolo soggetto ha un carattere adiuvante perché il suo rispetto delle regole in vigore arriva a rafforzare lo statu quo vigente. La sua coscienza di credente e di cittadino non vengono meno neanche di fronte a situazioni drammatiche ed anzi è proprio a fronte di queste ultime che emerge una fedeltà di fondo, che arriva a giustificare od almeno a non sanzionare anche fatti non del tutto consoni ai ruoli ricoperti ed alle responsabilità di natura religiosa o politico-statale.
Diversamente dalla religione-di-chiesa la religione diffusa non dà luogo, in linea di massima e di per sé, a forme associative che possano preludere ad ulteriori impegni a livello di società civile. Ma è indubbio che essa costituisce uno spazio privilegiato ed adeguato per riflessioni critiche ad ampio raggio riguardanti lo stato e la politica e tutta la società civile nel suo complesso. Quest’ultima trova anzi nella stessa religione diffusa una leva importante per opporsi allo stato, in quanto appunto La religione diffusa è una sorta di palestra che abitua allo spirito libero, alle osservazioni di merito, alle analisi dettagliate, alle disamine attente.
Il tutto avviene a prescindere da ordini di scuderia e pertanto in forma tendenzialmente aperta, non soggetta a linee precostituite. I valori religiosi di fondo permangono ma non diventano condizionanti ed esclusivi. Semmai una difficoltà è data dalla mancanza di luoghi e tempi deputati per l’esercizio del pubblico dibattito, per cui ci si deve sovente accontentare del dialogo estemporaneo in un bar, in un salotto, in un ambito convegnistico che è passeggero e frequentato da partecipanti che si incontrano di rado e quindi difficilmente riescono a muoversi congiuntamente per un’azione sociale rilevante all’interno della società civile.
Religione diffusa e società civile
A fronte di una certa diaspora che si può notare nelle varie forme di religione diffusa, è proprio la società che cerca di fare ordine e di offrire trame da seguire, al fine di regolare sentimenti ed orientamenti, relazioni e differenze.
Ma c’è qualcosa di peculiarmente comune che vede convergere religione diffusa e società civile: è la presenza di valori che guidano le azioni individuali in chiave sociale e con finalità di integrazione comunitaria. Tali valori sono talmente decisivi – per la definizione relativa a ciò che rappresenta la religione diffusa – cosicché è possibile ed a ragione veduta (cioè con i dati alla mano) parlare anche di religione dei valori diffusi, nel senso che essi vengono propalati e sperimentati nel quadro della socializzazione primaria e secondaria ma poi permangono a lungo e vanno a riverberarsi nella società civile, dove la credenza religiosa può anche venire meno (come di fatto accade) ma riemergono di continuo quei riferimenti etici che provengono dalla stessa religione diffusa (anche se non accompagnata dalla pratica regolare).
Il risultato che ne deriva è infine un contributo determinante alla stessa integrazione della società civile, pur con le debite differenze.
L’alleanza di maggiore rilevanza resta in ogni caso quella che lega religione diffusa e società civile nei confronti dello stato. Vi è una tacita e reciproca intesa per salvaguardare gli interessi e le istanze dei singoli attori sociali. Il che è uno straordinario servizio di promozione della stessa democrazia. Non a caso l’indebolimento della società civile comporta uno scivolamento verso forme autoritarie. E la stessa religione diffusa se non esercita più il suo peso attraverso i valori apre la strada a soluzioni totalitarie. In definitiva religione diffusa e società civile condividono il carattere etico della concezione della realtà e riducono le possibilità di sviluppo di esiti egoistici, basati sul mero interesse individuale.
Sia la religione diffusa che la società civile si avvalgono della famiglia e della sua azione socializzatrice, che avvia le nuove generazioni ad acquisire una particolare visione del mondo, un’autonomia decisionale nelle scelte etiche, una capacità critica, un orientamento consapevole nelle attività da intraprendere, nell’uso del tempo e nei consumi.
Un altro ambito che accomuna religione diffusa e società civile è quello del volontariato. Invero quest’ultimo rientra pure nelle caratteristiche della religione-di-chiesa. Ma è particolarmente sviluppato tra soggetti che non mostrando una pratica regolare ed un’osservanza stretta delle norme ecclesiastiche si dedicano tuttavia ad azioni generose, non remunerate, al servizio della comunità sociale, ovvero della società civile. Organizzazioni non governative, associazioni senza fini di lucro e reti di servizio sono tutte forme in cui si contano presenze sia di soggetti religiosamente orientati sia di altri che si impegnano per il pubblico vantaggio senza nulla chiedere in cambio.
In definitiva la tradizione civica italiana non nasce a caso ma ha le sue radici appunto nella presenza di una forma religiosa dominante, il cattolicesimo, che da vari secoli ha mostrato una specifica attenzione a questo settore.
Secolarizzazione e società civile
Per alcuni decenni gli specialisti del fenomeno religioso si sono affannati a discutere di secolarizzazione, morte di Dio, fine della religione, o – al contrario – di risveglio religioso, ritorno di Dio, espansione dell’influenza della religione. In diversi casi si è assistito a qualche ripensamento, ad un ammorbidimento dei toni, a cambi di rotta a 180 gradi. Valgano per tutti i due esempi di Sabino Samele Acquaviva (1971), già noto come teorico dell’eclissi del sacro, e di Harvey Cox (1968), profeta della città secolare. L’uno ha dovuto poi precisare che intendeva solo parlare di fine dell’uso magico del sacro (Acquaviva, Stella 1989) e l’altro, più semplicemente, di essersi sbagliato sul futuro della religione. Ma anche i fautori di una forte ripresa del ricorso alla pratica religiosa hanno poi dovuto ricredersi.
In ogni caso è mancato un serio confronto con la realtà empirica, con i risultati delle indagini scientifiche serie e rigorose, non preconcette, oppure se vi si è fatto riferimento l’approccio è stato parziale, non contestualizzato, troppo facilmente generalizzato rispetto ad una realtà di fatto assai variegata e mutevole. Ma soprattutto non sono stati fatti i conti con il peso delle radici storiche, delle culture tradizionali, della socializzazione religiosa diffusa, del peso e dell’influenza delle strutture confessionali, sovente capillari ed alquanto efficaci nella loro azione (nonostante le apparenze immediate facciano presumere il contrario).
Dopo le diverse ondate di ricerche empiriche e teorizzazioni sociologiche, che dapprima hanno sollevato un serio dubbio sulle possibilità reali di persistenza della religione e poi hanno enfatizzato un presunto risveglio religioso fondato su qualche osservazione sul campo piuttosto impressionistica e non confermata da indagini più rigorose, oggi sembra difficile negare che il fatto religioso sia ancora al centro degli interessi di larga parte della popolazione (italiana e non). E se così è, come recenti studi comprovano, non è possibile fare alcun discorso sulla società civile a prescindere dalla questione religiosa. Anzi spesso è a partire da essa che si intravedono tendenze in atto e si possono immaginare sviluppi futuri della società civile.
Ormai da qualche anno a questa parte stanno sorgendo a ripetizione problematiche che investono il punto di vista religioso quasi in ogni ambito della stessa società civile: si va dall’aborto al divorzio (temi assai dibattuti nel passato ed oggetto di appassionate dispute referendarie), all’uso delle cellule staminali, dall’eutanasia alla presenza di simboli religiosi in luoghi pubblici od aperti al pubblico, dall’insegnamento della religione cattolica nelle scuole al finanziamento degli istituti scolastici confessionali, dall’omosessualità all’uso della pillola anticoncezionale, dall’evoluzionismo al relativismo, dai rapporti con l’ebraismo a quelli con l’islam, dall’uso della lingua latina nelle liturgie al matrimonio solo civile.
Il dibattito ha luogo quasi sempre solamente fra esponenti dell’uno e dell’altro fronte, a sostegno di tesi contrapposte. E nondimeno la disputa avviene pubblicamente, all’interno dell’intera società civile (almeno potenzialmente, perché di fatto sono piuttosto gli specialisti a discettare a fondo e ad essere padroni e gestori degli argomenti da sostenere in favore o contro una certa soluzione).
Il che dimostra che la consapevolezza relativa all’esistenza di una società civile diversa dallo stato e dalla chiesa appartiene ad una cerchia ben ristretta di intellettuali, di politici preparati e di esponenti di chiesa attenti alle valenze politiche ed alle conseguenze reali di alcune prese di parola.
Per il resto quasi tutto resta nell’ombra e nel vago di una diatriba poco comprensibile, fatta di cifre malleabili e di motivazioni presentate ad arte. Alla fine quella che dovrebbe essere la protagonista vera del dibattito, esattamente la società civile nella sua ampiezza, viene di fatto esautorata, per cui solo gli specialisti restano delegati a dibattere di una questione che dovrebbe essere di comune e pubblico interesse.
Ecco dunque che su aspetti tipicamente religiosi decidono a livello legislativo solo i governanti ed i parlamentari della maggioranza in carica, mentre ben poco contribuiscono le forze sociali e la base degli elettori e dei cittadini. Ed a ciò si accompagna altresì un insieme di andamenti alterni che vedono di volta in volta questo o quel partito e questo o quel parlamentare favorire od avversare – secondo la convenienza del momento – l’opzione sostenuta ufficialmente dalla chiesa.
Vi possono essere ragioni e convinzioni personali profonde, ma non si comprende in base a quali criteri uomini della Democrazia Cristiana prima abbiano evitato di introdurre nella legislazione europea il riferimento alla religione cristiana come maggioritaria (su questa linea erano De Gasperi ed Adenauer ma anche altri) ed uomini politici oggi schierati al centro e vicini alla Chiesa Cattolica abbiano invece sostenuto il contrario, lanciando una campagna a favore dell’inserimento delle “radici cristiane” nell’ordinamento europeo.
Laicità e società civile
Di recente, la nuova parola d’ordine dell’analisi teorica e del dibattito intellettuale sembra sia divenuta la laicità, con particolare riferimento allo stato, alle istituzioni pubbliche, all’attività educativa (specialmente scolastica, a livello pubblico). In realtà non si tratta di una novità assoluta perché già in precedenza qualche studioso aveva parlato di laicizzazione piuttosto che di secolarizzazione, invero con un significato diverso da quello che attualmente è oggetto di continue diatribe.
Certamente c’è un interconnessione fra il tópos della laicità e quello del pluralismo. L’una e l’altro si ritrovano ad interloquire con la resilienza della religione che dopo la ventata pluridecennale della secolarizzazione conserva una sua solidità di base. Le ragioni del pluralismo possono essere pragmatiche, di convenienza: a fronte della persistenza delle religioni l’unica modalità di governo sembra essere quella di una permissività diffusa. Questa scelta comunque non si fa carico delle difficoltà create a quanti si aspettano di poter usufruire di maggiori spazi di autonomia e di uguaglianza ed al contrario devono lasciare posto ad altri ed in qualche modo tollerarli: l’inclusività diviene di fatto una sorta di esclusione per quanti già sono all’interno di un sistema dato. Un pluralismo più riflessivo fa appello ai valori della giustizia, della libertà, della legittimità e del dovere socio-politico per far accettare posizioni diverse dalla propria pre-esistente. Il rischio è di forzare alla libertà anche chi non è d’accordo ed ha il diritto di non esserlo. O di chiedere, pure a chi non intende ricorrervi, la cosiddetta uguaglianza di rispetto, concetto tuttora presente, come filótimo, nella cultura greca di villaggio (Cipriani, Cotesta, Kokosalakis, van Boeschoten 2002).
Gian Enrico Rusconi (2000) da lungo tempo è un intellettuale di riferimento sulla querelle della laicità, reso tale da una capacità di tenuta e di rigore che fa segnare ormai più di un quarantennio nel campo della polemica pubblica su religione e politica. Si tratta dunque di un protagonista e di un interlocutore di prim’ordine, attento, documentato e rispettoso. A suo dire la novità del tempo presente è nell’offerta di un’etica pubblica da parte delle Chiese. Ciò produce di per sé elementi di conflitto con l’approccio laico che tende ad impedire un apporto religioso alla medesima etica, insomma come se Dio non ci fosse (il noto etsi deus non daretur). Le Chiese invero non obiettano alla laicità dello stato ma si rifanno ad una cosiddetta sana laicità costruita sulla base dei loro parametri di riferimento. Da qui sorge la reazione da parte laica, che non gradisce forme di diktat provenienti da istituzioni che non siano lo stato.
L’equivoco maggiore è probabilmente nella qualificazione di dittatura del relativismo che alcuni esponenti della cosiddetta religione-di-chiesa (vecchio termine assai caro a Rusconi) vedono nelle affermazioni di parte laica, che al contrario preferisce parlare di una regolazione consensuale dei principi etici e della loro applicazione. Da un lato vi sarebbe l’autorità dei criteri di fede, dall’altro quella dei cittadini nel loro insieme, ivi compresi i credenti a vario titolo (anche diversamente, come piace dire a Rusconi).
Si sostiene che l’etica pubblica laica possa anche differire, in misura sopportabile, da quella privata. Dal canto suo l’etica pubblica religiosa appare più compatta, ma anche per essa vi sono possibili divari in ambito privato. Il discrimine maggiore poi proviene dalla diversa procedura messa in atto nelle due prospettive: in quella laica si registra la propensione a decidere caso per caso, mentre in quella religiosa varrebbe un corpus generale di principi validi per ogni questione.
Intanto il laico non accoglie l’intrusione del divino nelle scelte operative che derivano da diritti definiti attraverso procedure razionali e consensuali. E chiede perciò al soggetto religioso di adeguarsi alle regole dello stato laico. In altre parole la convergenza tra fede e ragione non trova sostegno al di fuori della religione-di-chiesa. Ma la posizione laica non legittima affatto, aggiunge Rusconi, l’assenza di qualsiasi regola morale ed anzi ne prevede altre basate su un ethos consensuale, anche se non attingibile agevolmente.
Rusconi, mentre contesta a Böckenförde (2007) la tesi di una religione cristiana in grado di assicurare le premesse normative che mancano allo stato secolare, osserva che le radici storiche cristiane possono essersi trasformate con il tempo in ragioni laiche e concorda infine con le richieste habermasiane per una rinuncia delle religioni al possesso esclusivo della verità, per un dialogo reale fra loro stesse, per un apprezzamento della scienza e per un’accettazione della supremazia laica nel campo del diritto.
Nel contempo potrebbe pure porsi l’obiettivo del ripristino degli insegnamenti teologici nelle università statali in un’ottica non confessionale ma di rigorosa ricerca scientifica a tutto campo, con la possibilità di incrementare prolifiche aperture interdisciplinari quali quelle che hanno dato luogo all’esemplare colloquiare di Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger (Ratzinger, Habermas 2005). Potrebbe essere questa una strada per far cadere pregiudizi e resistenze ma specialmente per far salire il livello qualitativo dell’approccio scientifico ai temi della laicità e della religiosità, della bioetica e del biodiritto. In tal senso è da allargare la preoccupazione manifestata da molti (ivi compreso papa Benedetto XVI) sul futuro dell’educazione in Italia.
Un’altra preoccupazione, riaffacciatasi di recente (De Rita 2008), rimanda alla confusione fra sacro e santo: il primo è dato dal nesso con il mistero divino ed il secondo dalla presenza della fede nel sociale, ossia dal ruolo sempre più attivo della Chiesa italiana sul territorio del paese, in campo sociale, in sostituzione dello stato ed in ruoli pubblici. In particolare è dalla capacità manageriale del cattolicesimo (nel muoversi agevolmente fra sacro e santo) che deriva lo spazio sempre maggiore della religione cattolica nell’arena pubblica, suscitando perciò riprese di istanze laiche individuali e statali.
Vale la pena di ricordare che già molti anni fa non la intendeva allo stesso modo Italo Mancini (1983), teologo e filosofo della religione nell’università di Urbino, il quale presago stigmatizzava la cultura della presenza del sacro (che indicava con l’iniziale maiuscola) e vedeva nel santo la vera salvezza contrapposta a quella falsa e violenta del sacro. Per lui il santo era la fede pura, separata, non assoggettabile agli interessi terreni e dunque non asservibile al sacro come suo management in termini di potere terreno da esercitare nella società. Il santo, il divino, non andrebbe confuso con l’umano di un certo tipo di sacro che vuol gareggiare con la forza laica del mondo profano. Non a caso, soggiunge Mancini, la cultura neo-ebraica ha distinto fra santo, innominabile, e sacro, immediato e manipolante. Orbene la nuova destra tende a confinare il santo entro ambiti minoritari e marginali, molto identitari, ed a valorizzare invece il sacro, vitale, attivo, operativo nella concretezza del quotidiano e del politico.
Discutere qui la fondatezza dell’una o dell’altra distinzione richiederebbe troppo spazio e molta letteratura di riferimento. Conviene appena constatare e sottolineare qualche aspetto. Innanzitutto che si chiami sacro o santo l’agire della Chiesa nella società non è senza conseguenze e senza problemi. Inoltre il ricorso alle due qualificazioni, almeno in relazione al ruolo pubblico della religione, crea altre separatezze che le definizioni non risolvono, visto che risultano intercambiabili, a seconda delle prospettive ideologiche ed intellettuali di chi le usa. Infine non va sottovalutato che criticare una superficiale confusione di termini e poi crearne un’altra non è il miglior servizio che si possa rendere alla comprensione della realtà. Per questo, metodologicamente, sembra più corretto far ricorso a due lemmi tendenzialmente meno ambigui, almeno in linea di massima: Chiesa (intesa come organizzazione storica con la sua gerarchia, le sue strutture, associazioni, movimenti e soggetti individuali credenti, praticanti, appartenenti) e religione (intesa come insieme di attività che si rifanno ad una matrice ispiratrice di tipo spirituale, metafisico; ma anche la religiosità ha caratteristiche simili). In definitiva la funzione della religione e della religiosità nella società civile italiana è tuttora evidente, ma i suoi connotati stanno cambiando. Non a caso è ormai all’orizzonte una nuova ricerca sociologica quantitativa e qualitativa ad ampio raggio (l’ultima risale al 1994-95) in grado di individuare e misurare la portata delle nuove dinamiche in atto.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, sociologa e antropologa brasiliana nel suo centesimo compleanno
Abstracts
Maria Isaura Pereira de Queiroz, a Brazilian socio-anthropologist and pupil of Roger Bastide, is well known for her ethno-anthropological studies of indigenous and popular cultures. Her research on the carnival of Salvador de Bahia, cangaceiros, peasants and messianisms remains fundamental.
Keywords: anthropology, cangaço, popular culture, carnival, peasants
María Isaura Pereira de Queiroz, socio-antropóloga brasileña y alumna de Roger Bastide, es conocida por sus estudios etno-antropológicos de las culturas indígenas y populares. Su investigación sobre el carnaval de Salvador de Bahía, los cangaceiros, los campesinos y los mesianismos sigue siendo fundamental.
Palabras clave: antropología, cangaço, cultura popular, carnaval, campesinos
La figura di Maria Isaura Pereira de Queiroz, socio-antropologa brasiliana, allieva di Roger Bastide, è ben nota per gli studi etno-antropologici sul terreno delle culture indigene e popolari. Restano fondamentali le sue ricerche sul carnevale di Salvador de Bahía, sui cangaceiros,sui contadini e sui messianismi.
Parole chiave: antropologia, cangaço, cultura popolare, carnevale, contadini
Premessa
Il 26 agosto 2018 sono trascorsi cento anni dalla nascita della sociologa e antropologa Maria Isaura Pereira de Queiroz, allieva di Roger Bastide, vincitrice del Premio Jabuti nel 1967 e del Premio Almirante Álvaro Alberto del Consiglio nazionale delle ricerche brasiliano (Cnpq/Mcti), nonché cattedratica dell’Università di São Paulo del Brasile e direttrice del Centro studi rurali e urbani.
Al termine di un mio periodo d’insegnamento presso l’Universidade de São Paulo (Usp), negli anni Novanta, mi venne fatto omaggio di un libro fotografico sul sertão, la vasta regione semiarida del Nordeste del Brasile. A donarmelo fu proprio Maria Isaura Pereira de Queiroz, che mi accennò alla singolare bellezza di quel territorio. In verità sulle prime non ne compresi sino in fondo l’importanza. Ora a distanza di tanti anni ho finalmente potuto capire in pieno la rilevanza storica, culturale ed ecologica di quella vasta zona che molti considerano come la vera culla del Brasile, il sertão appunto.
Tale considerazione da parte di molti cittadini del Nordeste ma anche di altre regioni non è solo di tipo sentimentale, tesa a ipotizzare radici mitiche, leggendarie, in un particolare contesto geografico. Ormai è accertato anche scientificamente che in effetti in quella medesima area ebbero ad abitare – molto tempo prima della “scoperta” dell’America e dello stesso inizio dell’era cristiana – i primi brasiliani, alcuni dei quali furono autori di una serie di graffiti rupestri che l’archeologa Niède Guidon (nata nel 1933) ha messo in luce e valorizzato, anche attraverso il suo insegnamento presso la parigina École des hautes etudes en sciences sociales, istituzione presso la quale pure la nostra Maria Isaura è stata dì casa per molti anni.
Il sertão dunque si può considerare quasi il luogo di nascita dell’antico homo brasiliensis (ma anche della donna). Inoltre sempre il sertão è 1’ambiente entro il quale ha origine e si diffonde il fenomeno del cangaço che tanta parte ha avuto nella storia brasiliana soprattutto negli anni dal 1870 al 1940.
1. I cangaceiros
Nella collana Anthropos diretta da Vittorio Lanternari (il noto autore di Movimenti religiosi di libertà e salvezza dei popoli oppressi) è apparsa nel 1993 la traduzione italiana di un volume di Maria Isaura Pereira de Queiroz dal titolo I cangaceiros. I banditi d’onore brasiliani (Liguori Editore, Napoli, traduzione di Laura Ferrarotti).
Direi che non si tratta di un testo accademico nel senso pieno del termine. Le note a piè di pagina sono minime, ridotte veramente all’essenziale. Il linguaggio è semplice, didascalico, persino divulgativo, usufruibile anche da un lettore non necessariamente colto, tipico frequentatore delle biblioteche municipali a consultazione rapida e con scaffali accessibili al pubblico (un modello, questo, abbastanza diffuso in Brasile, com’è facile constatare anche a Marilia, sede universitaria, dove le opere della nostra Autrice sono ben presenti).
La stringatezza del discorso non è però indice di superficialità, giacché alcuni passi proprio nella loro forma sintetica sono allusivi, hanno il carattere di una voce da enciclopedia, asciutto, breve ma ricco di contenuti, di rinvii, di sottintesi, frutto comunque di approfondimenti previi. Forse un po’ dispiacerà – a qualche studioso abituato diversamente – la mancanza di sviluppi ulteriori di idee e ipotesi appena affacciate, di interpretazioni solo avviate, di problematiche sollevate e non del tutto risolte. Il discorso resta come sospeso, vago, non definito una volta per sempre. È la prudenza tipica dello scienziato serio, rigoroso, che sa bene come in futuro possano esservi altri dati più circostanziati, meglio convincenti, probanti in misura maggiore.
Del resto non deve costituire un problema la scelta tutta isauriana di porre le ipotesi alla fine e non all’inizio del rapporto di ricerca. In realtà per lei sono i dati a parlare e a fornire piste ipotetiche. Così la sua metodologia sembra collimare con la grounded theory (la teoria a base-dati) di Strauss e Glaser, i quali espungono del tutto le ipotesi dal loro percorso d’indagine, volgendosi al solo esame delle risultanze empiriche.
Se però le ipotesi giungono solo al termine è anche vero che l’epilogo del volume della Pereira è ricco di osservazioni su molteplici aspetti, ognuno dei quali meriterebbe un capitolo monografico: dall’industrializzazione alla leadership, dall’economia del caucciù ai sistemi ereditari, dall’igiene sociale all’espansione demografica, dalla mobilità ai rapporti (e conflitti) parentali e familiari, dalla stratificazione sociale all’urbanizzazione.
Invero il nodo centrale è stabilire il carattere del banditismo impersonato dai cangaceiros. Si tratta dì un banditismo sociale?
No, risponde l’Autrice: è piuttosto un fatto di onore (offeso e da riparare, in pericolo e da difendere). E neppure c’è nulla a che vedere con il celebre Robin Hood.
Peraltro non è il caso di paragonare i cangaceiros con i cow boys. Differenze sostanziali si registrano anche in un eventuale confronto con esempi italiani: con il bandito siciliano Salvatore Giuliano, attivo nella prima metà del secolo scorso, o con Michele Pezza, detto fra’ Diavolo, vissuto tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento.
Tuttavia non mancano elementi di somiglianza fra quest’ultimo personaggio e quello di Lampião: entrambi sono sospettati di aver stretto un patto diabolico per rimanere invincibili; il primo fu a capo dei briganti calabresi nell’insurrezione del cardinal Ruffo, mentre il secondo su richiesta di padre Cicero capitanò i suoi cangaceiros contro la Coluna Prestes (un gruppo di rivoltosi dell’esercito); l’uno fu pure colonnello di Ferdinando di Borbone, l’altro fu nominato capitano dell’esercito federale brasiliano; fra’ Diavolo trovatosi in difficoltà si ritirò nella regione dell’Abruzzo, Lampião braccato ebbe a rifugiarsi in quella del Raso da Catarina; da ultimo, il brigante italiano fu preso ad Avellino e impiccato a Napoli, Lampião fu ucciso ad Angicos, dopo di che la sua testa venne trasportata a Santana do Ipanema, mostrata dinanzi alla chiesa principale del paese e poi condotta nella capitale della provincia, a Maceiò, e infine a Salvador. Fin qui le possibili affinità tra i due; è difficile trovarne ancora.
D’altra parte del tutto improponibile è il paragone tra il banditismo del cangaço con la mafia. È vero che c’è in comune il sistema dell’onore, nondimeno le diversità sono abissali, incomparabili fra loro.
L’Autrice quasi sussurra un’ipotesi: «non siamo lontani dal bandito corso». Ma limitarsi a dire questo non basta. Occorrerebbero prove più salde, ben al di là di un semplice spunto.
2. Altre interpretazioni
L’approccio di Maria Isaura al cangaço può definirsi un tipico prodotto di una sociologia della conoscenza applicata alle diverse fortune, letture, percezioni del fenomeno storico di cui sono protagonisti i banditi di onore. La sua periodizzazione di tali ricezioni appare fondata, convincente.
Anche le falsificazioni degli eventi, le idealizzazioni dei personaggi (da Antonio Silvino a Corisco) e le costruzioni sociali delle diverse leggende legate ai cangaceiros tornano utili per capire la reale portata di una dinamica storica che è durata più di due terzi di secolo.
La conclusione della socio-antropologa di São Paulo è che il cangaceiro è un fuorilegge perché agisce contro la legge, però allo stesso tempo egli è proteso verso la creazione di una nuova legge, più rispettosa dei singoli e sovvertitrice dell’ordine vigente. Ecco perché Lampião e i suoi sarebbero dei rivoluzionari. Dico “sarebbero” in quanto il fenomeno è assai più complesso di quello che possa apparire. Se esso nasce in un quadro contestativo della realtà e dell’ingiustizia, strada facendo assume altri connotati che non escludono motivazioni meno nobili, contraddittorie, incomprensibili talora (basti pensate al mutevole agire di Lampião ora generoso, ora spietato).
Colpisce particolarmente la compresenza di violenza e delitti insieme con una forte carica di religiosità: i cangaceiros hanno delle loro preghiere (in parte modificate), credono in Dio, coltivano la religione, venerano i santi, rispettano e ascoltano i sacerdoti e intanto ammazzano.
Come spiegare tutto questo?
Forse si può tentare di mettere in campo qualche spiegazione, come vedremo in seguito.
Per il momento è sufficiente considerare 1’emblematicità di questa doppia contingenza: pietà religiosa e spietatezza comportamentale. In proposito non si può fornire uno schema interpretativo omogeneo, senza sfilacciature. Occorre un sano realismo alla maniera di Maria Isaura: ognuno (cangaceiro o meno) costituisce un mondo a sé, con le sue diverse sfaccettature. E dunque Lampião può essere in pari tempo coraggioso e timoroso, rispettoso e sprezzante, tenero e sbruffone, democratico e dispotico. Infatti, per esempio, a volte egli attacca senza timore e allo scoperto, a volte se la batte in ritirata più o meno strategica.
3. Influenze
Certamente la Nostra ha subito una forte influenza da parte di Roger Bastide ma ha anche avuto la capacità di prescindere dal suo modello di riferimento, costruendone uno suo proprio, che ha offerto spunti e suggestioni ad una cospicua schiera di seguaci, specialmente donne, che costituiscono quasi una scuola.
Del tutto assente è invece la traccia di un altro antropologo francese che ha lavorato in Brasile: Claude Lévi-Strauss. Il suo strutturalismo le è apparso troppo complesso, poco interessante e – quel che più conta – inefficace sul piano scientifico.
Maria Isaura preferisce piuttosto la soluzione di un’indagine non paludata, ma non per questo meno seria.
Segnatamente la sua indagine sui cangaceiros risulta rimarchevole in quanto analizza soggetti ed eventi abbastanza singolari, poco noti e mal compresi.
È uno studio fuori del seminato solito del messianismo, ma in continuità metodologica con altri saggi della medesima Autrice.
In definitiva sì può dire che è un volume da cui molto si apprende, soprattutto se non lo si recensisce con fraintendimenti madornali (come di fatto è accaduto in qualche caso).
4. La religiosità nel cangaço
Si diceva dunque della contraddizione fra religiosità e violenza dei cangaceiros. Ma di che tipo di religiosità si tratta? Ed è forse diversa da quella dei coroneis (colonnelli) loro avversari?
La risposta non è agevole, anche perché vi è una forte carenza di documenti scritti, che rendono impossibile una ricostruzione precisa di eventi e comportamenti.
Si può altresì sostenere che la religiosità di Lampião e compagni sia solo una supposizione priva di fondamento o meglio una credenza popolare a carattere mitologico. Se anche così fosse, la natura della discussione non cambierebbe di molto, in quanto rimarrebbe comunque il dato di fatto di un sentire religioso che permea la cultura del popolo brasiliano. E dunque come non pensare che essa abbia influenzato gli stessi cangaceiros? Nondimeno, al di là della situazione concreta, non è possibile trascurare la valenza di una costruzione sociale che nasce dal basso e si diffonde a macchia d’olio sino a coinvolgere altre classi sociali e molte espressioni artistico-culturali (dalla letteratura alla scultura, dal disegno alla poesia, dalla musica alla pittura).
Ma procediamo con ordine e seguiamo la metodologia stessa di Maria Isaura, partendo cioè dai dati, punto per punto:
1 – il primo elemento concerne, non a caso, il cappello di Lampião. Su di esso risultano attaccate due medaglie d’oro con la scritta «che il Signore sia la tua guida». Si può obiettare che le medaglie non appartenessero sin dall’origine al bandito. Sia pure così. Perché allora collocarle in bella vista, se esse non hanno alcun significato per chi le mostra? Dunque se ne deve dedurre che Virgulino Ferreira ossia Lampião intendeva esplicitare anche in tal modo la sua fede religiosa;
2 – appartiene alla cultura sertaneja il ricorso a pratiche previsionali relative alle possibilità di pioggia nei mesi a venire. La sera del 12 dicembre si pongono all’aperto sei mucchi di sale (che rappresentano nell’ordine i mesi da gennaio a giugno). L’indomani il mucchio o i mucchi sciolti indicheranno il mese o i mesi durante i quali pioverà. Questa modalità divinatoria non sarà stata del tutto estranea alla prassi comportamenta1e dei cangaceiros, così legati – in termini di sopravvivenza – alle condizioni socio-ambientali del sertão;
3 – particolare rilievo assume nella cultura del cangaço il compadrío (comparatico) battesimale, ricordato anche nella festa dei fuochi di San Giovanni. Il compadre è più che un fratello: questo aspetto specifico regola molti rapporti nell’ambito del banditismo d’onore;
4 – quando il colonnello Chico Romão, alla stregua di suo nonno, attacca gli avversari esclama: «il mio pugnale è l’unghia del Padre eterno; il mio fucile è il cero con il quale rendo grazie al Signore». Ecco quindi che pure i coroneis si presentano con una loro religiosità, per quanto contraddittoria (come quella dei cangaceiros), strumentale e legittimatrice di azioni cruente;
5 – João Calangro quando ha bisogno di aiuto, nel 1879, ricorre ad un ecclesiastico, il Padre Manuel Antonio che lo aiuta a sottrarsi alla cattura;
6 – per evitare i rischi del banditismo e offrire una buona educazione scolastica, sovente i cangaceiros inviavano i loro figli presso qualche sacerdote che li salvaguardasse e li istruisse;
7 – nel 1912 Antonio Silvino chiese proprio ad un prete dì intercedere per lui presso il governo per ottenere il perdono dei suoi misfatti;
8 – nel 1922 la banda di Lampião assaltò il municipio di Belmonte al grido di «Evviva Nostra signora dei sette dolori». Forse lo fece per darsi coraggio. Nulla vietava però di scegliere un’altra espressione più laica, più neutra. Pertanto l’opzione fatta acquista una sua valenza esplicitamente religiosa;
9 – un fratello maggiore, di nome Livino (che poi morrà in uno scontro a Tenório), rimprovera Lampião, per aver ordinato una ritirata, dicendogli: «la tua vera vocazione è quella del beato. Abbandona il fucile, va’ a cantare la novena in chiesa. Non hai che l’apparenza di un uomo». Così marcata è la sua sensibilità religiosa che Virgulino Ferreira (Lampião) dà l’impressione di essere poco virile (voce che sarà ripresa in seguito sino a far sospettare una sua omosessualità di fondo);
10 – Lampião dà spesso a vedere di preoccuparsi della moralità sessuale per motivi etico-religiosi (ma invero egli stesso non è proprio impeccabile a questo riguardo);
11 – alla morte del fratello Livino, Lampião prende il lutto e si lascia crescere barba e capelli;
12 – nel mese di marzo del 1926 il padre Cicero (personaggio ritenuto taumaturgico, in fama di santità, ma pure abbastanza discusso e avversato per la sua grande influenza) invita Lampião a vivere altrove in tutta tranquillità (una simile operazione gli era già riuscita con Sinhô Pereira e Luiz Padre). Il bandito obbedisce almeno in parte; infatti evita di entrare nelle regioni da cui il padre lo aveva pregato di allontanarsi e risparmia le case in cui trova un’immagine di Cicero. Un mese dopo riceverà un altro invito dallo stesso religioso che lo pregherà di combattere la già citata Coluna Prestes, penetrata nel sertão;
13 – Virgulino Ferreira partecipa a molte feste di santi patroni. Sono sicuramente delle buone occasioni per mescolarsi tra la folla e sfuggire allo sguardo dei soldati federali, uscendo anche da lunghi periodi di isolamento e procurandosi il necessario per continuare a vivere alla macchia. Intanto però non è assente la motivazione religiosa;
14 – nel giugno 1927 decide di non assalire Mossoró dicendo che «non è bene per i cangaceiros assalire una città che possiede più di una chiesa». Anche in questo caso si può immaginare che la motivazione sia fittizia e che la ragione reale della ritirata sia un’altra, cioè 1’impossibilità di compiere impunemente un’azione troppo impegnativa per la banda. Tuttavia resta il fatto che la presenza di luoghi religiosi svolge una funzione apotropaica di allontanamento del possibile danno (il che era già riscontrabile – come si è detto – nei posti in cui si trovasse affissa un’immagine di padre Cicero);
15 – la cangaceira Maria Bonita, diletta compagna di Virgulino, è soprannominata santinha, piccola santa, appellativo che fa bene il paio con quello di beato attribuito dal fratello Livino a Lampião. Ad onor del vero il chiamare santinha una donna brasiliana non è del tutto infrequente;
16 – Virgulino Ferreira ha con sé la Vita di Cristo di Papini. Non è un suo acquisto, è un regalo di un commerciante. C’è da chiedersi comunque perché il donatore abbia scelto quel testo: evidentemente conosceva il sentimento religioso del ricevente. Quest’ultimo peraltro non si disfa del libro e presumibilmente ha avuto modo di leggerlo durante i lunghi periodi di inattività;
17 – sovente si è detto di Lampião che avesse il corpo fechado, chiuso cioè ad ogni colpo esterno. Alcuni parlano di un suo patto con il diavolo, altri invece con Dio;
18 – persino la macabra esposizione delle teste dei cangaceiros nel 1938 davanti ad una chiesa sembra chiudere simbolicamente il cerchio del loro legame con la religione;
19 – tra i reperti trovati addosso a Lampião c’è anche una medaglietta raffigurante padre Cicero; in alcuni sacchetti poi sono contenute delle preghiere (ma non mancano amuleti magici);
20 – sul versante opposto, il colonnello José Rufino, della volante contro Lampião e Corisco, dice: «Pregavo sempre il Signore di Bonfim». Ed in combattimento gridava (probabilmente per darsi animo): «Viva il Signore di Bonfim».
21 – Lampião aveva obbligato i suoi a recitare un tipo particolare di Padre nostro (di cui non resta traccia);
22 – ancora Lampião pretendeva dai suoi che avessero una sola donna, secondo i canoni della dottrina cattolica;
23 – egli era generoso con i poveri, cui dava denaro senza nemmeno contarlo;
24 – allo stesso tempo disprezzava i negri reputandoli «immagine del diavolo», espressione che in ogni caso scaturisce da una visione re1igioso-manichea della vita;
25 – la prova più pregnante della religiosità di un cangaceiro come Lampião è costituita dal suo comportamento dimesso, dalla sua bontà accentuata, dalla sua rinunzia a combattere di venerdì. Di lui si racconta molto in relazione alla sua «passione personale» rivissuta ogni settimana. «Il venerdì non conversava con nessuno, neanche con Maria Bonita. Restava solo, isolato da tutto e da tutti, perso in una lunga meditazione, borbottando a mezza voce preghiere, guardando ora il cielo, ora un punto all’orizzonte. Quel giorno non mangiava e non beveva, e teneva costantemente la canna del fucile rivolta a terra… Per lui i preti erano dei santi». Il primo fra tutti era ovviamente padre Cicero, il “santo” di Juazeiro;
26 – al più noto dei cangaceiros si riconoscevano inoltre capacità divinatorie: sarebbe stato in grado di sapere se un cibo fosse stato avvelenato;
27 – un altro famoso cangaceiro conferma una tendenziale religiosità dei banditi d’onore. Labarêda sostiene di aver pregato Dio affinché i soldati non andassero verso di lui;
28 – Durvalina, figlioccia di Labarêda, resta ferita. Per la sua guarigione tutta la banda fa un voto alla Vergine della salute, cui viene offerto del denaro, dopo il ristabilimento della donna.
5. Conclusione
Credo si possa a ragione confermare la sostanziale religiosità dei cangaceiros e specialmente di Lampião. Senonché il sentimento religioso dei banditi d’onore non nasce con l’esperienza del cangaço; esso è ampiamente precedente alla scelta della devianza sociale; è per questo che non entra in conflitto con le decisioni più crudeli quali quelle di privare gli altri del bene della vita (ed in ogni caso non si verifica un abbandono né della religione né della violenza).
La cultura religiosa è parte vitale dell’esperienza dei sertanejos e diventa perciò irrinunciabile. Ugualmente irrinunciabile è il desiderio di rivalsa e di giustizia dei cangaceiros. Perciò le due dimensioni non si scontrano, convivono perché non percepite dai protagonisti come contrastanti, anzi in qualche caso la sovrapposizione è totale sino all’identificazione tra fede e giustizia divina, sia da parte dei cangaceiros che dei coroneis. Da entrambi i fronti ognuno prega Dio per riuscire vincitore o evitare lo scontro o superare indenne il combattimento.
Del resto la guerra è “santa” per l’uno e l’altro contendente, che pure fanno riferimento alla medesima fede religiosa, agli stessi insegnamenti. Ognuno pensa e dice di avere Dio con sé, in quanto comune è la religione che fa da scenario ai vissuti sia dei banditi che dei soldati.
Il merito di Maria Isaura Pereira de Queiroz è di aver dato ordine a sparsi frammenti e di aver aperto solchi entro i quali altri si stanno cimentando per riannodare i fili della complessa trama socio-storico-antropologica del cangaço. Ora tocca seminare entro quei solchi per poter raccogliere in futuro i frutti di nuove, più sistematiche e circostanziate interpretazioni scientifiche.
Un ultimo interrogativo occorre sciogliere: la religione resta solo un accessorio nel fenomeno dei cangaceiros?
La risposta può essere data in termini metaforici: esattamente come sul cappello di Lampião, sono reperibili vari elementi socio-culturali sistemati insieme, fra cui quelli a carattere religioso (si pensi alle due medaglie d’oro con scritta, citate sopra). Ed è “sotto quel cappello” che Lampião ha pensato e agito. Il mix delle varie componenti ha prodotto inoltre un mito, una leggenda, ha creato un eroe, magari non del tutto corrispondente alla realtà di fatto. Anche questo ha del “religioso”: è il “miracolo” di una cultura popolare che si è impossessata di un personaggio, lo ha trasformato, adattandolo alle proprie esigenze espressive e comunicative, per consegnarlo all’attenzione delle generazioni future. L’opera di Maria Isaura si inserisce appieno in questa operazione di trasmissione culturale, di traditio culturae.
Riferimenti bibliografici / References
Maria Isaura Pereira de Queiroz, La guerre sainte au Brésil. Le mouvement messianique du Contestado, Éditions de la Faculté de philosophie, sciences et lettres, Université de São Paulo, São Paulo, 1957.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, O messianismo no Brasil e no mundo, Dominus, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1965.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Os Cangaceiros: les bandits d’honneur brésiliens, Julliard, Paris, 1968.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Réformes et révolutions dans les sociétés traditionnelles, Éditions Anthropos, Paris, 1968.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Images messianiques du Brésil, Éditions Cidoc-Sondeos, Cuernavaca (Mexique), 1971.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Bairros rurais paulistas, Duas Cidades, São Paulo, 1973.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, O campesinato brasileiro, Vozes, São Paulo, 1973.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, O mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios, Editora Alfa-Omega, São Paulo, 1976.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Cultura, sociedade rural e sociedade urbana no Brasil, Ed. da Universidade de São Paulo, Rio de Janeiro, 1978.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Nostalgia do outro e do alhures: a obra sociológica de Roger Bastide, in Maria Isaura Pereira de Queiroz (org.), Roger Bastide, Ática, São Paulo, 1983.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Carnaval brésilien: le vécu et le mythe, Éditions Gallimard, Paris, 1992.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, Carnaval brasileiro: o vivido e o mito, Editora Brasiliense, São Paulo, 1992.
Maria Isaura Pereira de Queiroz, I cangaceiros. I banditi d’onore brasiliani, Liguori Editore, Napoli, 1993.
Il corpo tra biologia e sociologia
Sommario
Questo saggio considera i genomi di una data comunità di microflora come una sorta di impronta digitale di uno specifico gruppo biosociale. Tale tipo di comunità non deve essere considerato come un mosaico in cui i singoli componenti individuali sono le tessere, ma come un quasi-organismo complesso e organico, che possiede un tipico “meta-genoma sociale” prodotto da tutti i genomi presenti nel mfDNA (acido desossiribonucleico della microflora) dei ceppi microbici costituenti.
Questa prospettiva apre un vasto panorama di suggestioni per la sociologia, offrendo la possibilità di analizzare tipologie di popolazioni molto diverse tra loro.
L’autore fornisce i parallelismi tra le analisi delle comunità di microflora biologica e le dinamiche delle società umane, mostrando anche come il mfDNA possa spiegare diversi fenomeni sociali (ad esempio: concorrenza, recrudescenza, simbiosi, parassitismo, interrelazioni economiche, finanziarie e agricole, società antiche e moderne, comunità virtuali basate su Internet).
Parole chiave:biologia; società; comunità.
Abstract
This paper considers the different genomes of a given microflora community as a kind of fingerprint or “meta-genome” of that specific biosocial group. In the light of this, the type of community should not be considered as a mosaic in which individual components are the tesserae, but as a complex and organic quasi-organism, which possesses a typical “social meta-genome” yielded by all the genomes present in the mfDNA (microflora deoxyribonucleic acid) of the constituent microbial strains.
This perspective opens up a vast panorama of productive suggestions for sociology, providing possibilities by which to analyse very different kinds of populations, including human societies.
The author introduces his thesis and provides several parallelisms between analyses of biological microflora communities and the dynamics of human societies, and also show how mfDNA can explain different social phenomena (e.g.: competition, recrudescence, symbiosis, parasitism, economic, financial and agricultural interrelations, ancient and modern societies, virtual Internet-based communities).
Keywords: biology; society; community.
Introduzione
In generale, la conoscenza scientifica della realtà assume forme prevalentemente monodisciplinari. Gli sforzi analitici interdisciplinari sono piuttosto rari e, il più delle volte, incontrano riserve, resistenze e critiche, rivolte soprattutto a questioni di contenuto e di metodologia. È difficile, tuttavia, negare che la presenza di prospettive differenziate possa conferire maggiore attendibilità ai risultati. Semmai, la questione critica è come superare la diffidenza che impedisce agli studiosi di rimanere aperti al confronto con ambiti al di fuori delle loro abituali aree di competenza e di mettere in discussione il know how che già possiedono. Indubbiamente la scelta interdisciplinare non interesserà gli studiosi che ritengono la propria l’unica disciplina veramente rigorosa, corretta e seria. Un fisico, ad esempio, che non considera l’etologia veramente degna dell’appellativo scientifico, troverà ancora più difficile uscire dal suo guscio e avventurarsi nell’area flessibile delle scienze fuzzy come la sociologia o la psicologia.
1. Biologia e sociologia
A dire il vero, precedenti tentativi operativi sono stati fatti per coniugare, ad esempio, biologia e sociologia, che hanno prodotto soluzioni miste, come quelle avanzate da socio-biologi come E. O. Wilson (1975), S. S. S. Acquaviva (1983), A. S. Franklin (2002), T. Newton (2003). Ma gli scarsi risultati di questi tentativi non devono necessariamente fungere da barriera ad ulteriori proposte di collaborazione interdisciplinare tra sociologia e biologia (in termini diversi e con una mente più aperta) riguardo allo sviluppo di aree di convergenza e divergenza, queste ultime a causa dei limiti tipici del soggetto umano. Si può fare riferimento, ad esempio, a casi di cosiddette scienze esatte ispirate a metodologie sociologiche (ad esempio la fitosociologia, che studia comunità di vegetali che emergono spontaneamente in natura) o etno-botanica (che studia i rapporti tra piante e uomo).
Il neonato riceve un particolare tipo di imprinting dovuto alla flora batterica della madre. Questa iniziale “contaminazione” viene attuata dalla vagina. Il bambino viene partorito dopo un certo numero di ore di contatto con il canale vaginale della madre. Nel caso di parto libero da interventi tecnologici, la madre, subito dopo il parto, porta spontaneamente il bambino al seno, non per nutrirlo, ma per guardarlo. Si tratta di un contatto profondo, causato da uno specifico cocktail ormonale di endorfine a cui madre e bambino sono soggetti in questa fase: questo processo è chiamato legame.
Quando nasce il bambino è composto solo da cellule proprie (c’è, però, una successiva trasmissione della flora batterica materna, dopo la nascita, comunque). Il sistema immunitario non è ancora attivo e, quindi, l’individuo è aperto all’acquisizione di molti elementi provenienti dall’esterno. Così, vari microrganismi cominciano a svilupparsi sul e nel corpo del bambino, a partire dalle parti esterne più facilmente raggiungibili (paradossalmente alcuni dei tessuti interni meno accessibili e sterili sono più malleabili) a causa dell’impatto esterno ed eteroclito. In realtà, il bambino, dal momento del suo concepimento, inizia un rapporto con un altro soggetto: la madre. Successivamente, dopo il parto, quando il neonato entra in contatto con l’ambiente esterno, alcune aree del suo corpo vengono invase da microbi. Ma, allo stesso tempo, anche il cervello, cioè il suo apparato mentale comincia a ricevere ed assimilare nuovi messaggi, inputs. Le loro caratteristiche, come quelle di microbi, protozoi, funghi e virus (che non sono cellule), non differiscono sostanzialmente gli uni dagli altri, visto che le loro strutture sono abbastanza simili. Una sorta di simbiosi si costruisce lentamente e gradualmente tra il corpo del neonato e la microflora dell’ambiente; ma tra questo e le voci, i toni e i gesti degli altri appartenenti all’ambiente sociale, emerge anche un altro tipo di simbiosi. Non a caso si parla di batteri simbiotici i quali coevolvono con i corpi umani che sono la sede del loro insediamento. Analogamente, si possono considerare simbiotici anche i legami tra la madre bambino e l’adulto-bambino. Questo tipo di simbiosi sempre crescente fa sì che il legame così stabilito diventi sempre più reciproco e imitativo, cosa estremamente utile nelle prime fasi di apprendimento e socializzazione. Bisogna però considerare il fatto che non si tratta tanto di un tipo di microrganismo, quanto di un ambiente microflorale (microrganismo che significa piccolo ma anche microbico) che colonizza varie parti del corpo. Lo stesso si può dire delle relazioni umane nelle prime fasi della vita: si assiste ad un sorprendente insieme di scambi interpersonali, linguistici e comportamentali, insieme ad abitudini che cominciano a cristallizzarsi e consolidarsi fino a diventare una sorta di fondamento su cui si fonda la nostra società, che sarà molto difficile da minare o cambiare in seguito nella vita. Lo stesso vale e riguarda ogni sfera dell’ambiente circostante nel suo complesso. È il caso, ad esempio, dei processi naturali di biodegradazione in cui gli inquinanti innescano una serie di procedure da parte di microbi, protozoi, minuscoli vermi ed altri piccoli metazoi, che li trasformano in liquidi inquinati e li purificano: è esattamente quello che succede ai sedimenti fluviali o ai fanghi attivi trattati dagli impianti di depurazione dei rifiuti urbani. Anche in questi ambienti entra in azione quella che potrebbe essere considerata una comunità microflorale, classificabile come il genoma di quei particolari contesti.
2. Trasformazioni e microflora
A livello umano, le trasformazioni avvengono come risultato di una serie di interventi-chiave che danno una direzione alla vita di un individuo, inducendolo a cambiare rotta per convinzione o come risultato di una scelta consapevole ed autonoma, anche se, in seguito, non è possibile stabilire quali possano essere i risultati di un’influenza presumibilmente significativa. Qualcosa di simile accade quando la microflora digerisce un inquinante, prima di rilasciare nuovamente la materia decomposta (anche sotto forma di gas) nell’ambiente. A questo proposito si può parlare di plagio o di educazione forzata.
Va notato che specifici elementi microflorali sono in grado di adattarsi ad ambienti molto particolari e si combinano, ad esempio, con contesti vulcanici o solforosi. È importante ricordare, tuttavia, che al di fuori di certi ambienti e nicchie ecologiche alcune componenti microflorali non sarebbero in grado di sopravvivere. Il contrario vale anche perché la microflora dentro e sul nostro corpo non sarebbe in grado di resistere in condizioni vulcaniche o solforose. Si può quindi affermare che gli elementi microflorali sono dotati di uno specifico e ben noto grado di adattabilità e complessità.
La microflora del cavo orale è diversa da quella della bocca e delle feci (di cui è una componente rilevante, che pesa circa un quinto del tutto). La sua struttura, tuttavia, è estremamente diversificata e, in questo, può essere paragonata a comunità sociali complesse e differenziate. Nel caso della società umana, la variabilità è ancora più ampia e varia e presenta caratteristiche condivise da un dato gruppo, ma anche in contesti lontani e non necessariamente simili. Soprattutto, occorre sottolineare esplicitamente e chiaramente un tratto della società umana: la società delle persone è sempre associativa e collettiva, con un proprio profilo costituente e distintivo.
Va sottolineato che la società nel suo insieme, come la microflora, non è un semplice mosaico composto da molte tessere, ma una struttura a sé stante, racchiusa, si potrebbe dire, in un particolare ambiente necessario al suo efficace funzionamento. Tuttavia, i componenti della struttura non rimangono confinati per sempre all’interno di questo quadro di riferimento, ma possono essere espulsi (come quando si tossisce, si soffia il naso, ecc.). Le minuscole parti strutturali rimarranno nella loro nicchia, svolgeranno le loro funzioni e cresceranno insieme. Allo stesso modo, un dato gruppo sociale rimarrà all’interno di un dato territorio, lo caratterizzerà, lo definirà, lo colonizzerà e lo trasformerà. Ora, se un unico elemento viene espulso dalla comunità microflorale o sociale qui descritta, non c’è garanzia che possa crescere altrove. D’altra parte, la sottrazione anche di un solo elemento può innescare il declino di tutti gli altri membri di una colonia microflorica, di un gruppo sociale, di un gruppo comunitario. Durante i processi di depurazione, come quello della biodegradazione degli inquinanti presenti nell’acqua, si verificano molte trasformazioni che portano, infine, alla creazione di una serie di prodotti dovuti al processo di biodegradazione stesso. Seguendo una simile procedura generale, si potrebbe dire che, anche nel caso delle società umane, il cambiamento dà luogo, giorno dopo giorno, a qualcosa di diverso, anche se la continuità con il passato non viene mai spezzata. In altre parole, le aziende sociali non ripudiano mai completamente la propria identità ma procedono per gradi, lentamente, costruendo sul preesistente.
Variazioni all’interno dell’ambiente microflorale possono portare alla patologia. Ad esempio, una quantità eccessiva di un dato elemento microflorale nella bocca può causare una malattia parodontale. Se una singola componente si sviluppa troppo, questo squilibrio altererà il microambiente di tutti gli altri elementi, cosicché la persona la cui bocca ospita questa microflora alterata subirà dolore e disagio. Può anche accadere che, in assenza di un elemento, tutti gli altri si possano riadattare. In breve, i membri di una comunità microflorica sono interrelazionati e gli squilibri prodotti si ripercuotono sull’ospite, sulla nicchia ecologica, sull’ambiente circostante, in modo biunivoco. Questo è esattamente ciò che si trova nei gruppi sociali o nelle comunità umane. La “sofferenza”, il disagio di un singolo membro ha un impatto sul resto del gruppo, in modo da produrre conseguenze, cambiamenti ed effetti di ogni tipo. Se un attore sociale esercita un potere eccessivo, questo fatto produce cambiamenti all’interno del rispettivo quadro sociale. Tutti gli altri membri del gruppo percepiscono questo potere come autoritario e quale imposizione, diverso, in ogni caso, dal normale flusso del “fluido” sociale, cioè della linfa sociale, il liquido “amniotico”, che garantisce la sopravvivenza di tutti gli esseri sociali.
3. La microflora del Mar dei Sargassi
A questo punto si può fare riferimento all’esame di Craig Venter dei microrganismi presenti nel Mar dei Sargassi (Venter et alii, 2004), dove la microflora presenta una sorprendente varietà morfologica, genetica e funzionale di specie microbiche, come si trova, inoltre, in altre matrici naturali, quali suolo, acqua, detriti. Ma il Mar dei Sargassi non avrebbe le sue singolari caratteristiche senza la sua particolare microflora, intesa come un insieme dinamico, alla pari di altri complessi microflorali.
Alcuni fluidi, tuttavia, per evitare gravi pericoli, devono essere sterili, come il liquido cerebrospinale o lo sperma e persino il sangue stesso; tutti questi sono privi di microflora, almeno quando il corpo gode di buona salute.
Da ciò si può dedurre che non è utile considerare singoli elementi indipendentemente da tutti gli altri, ma che è necessario concentrarsi sulla comunità nel suo insieme. In altre parole, è opportuno studiare il gruppo per cogliere le relazioni esistenti tra l’individuo e la comunità e tra il gruppo e i suoi singoli membri.
La coincidenza tra i fluidi corporei e la società liquida è veramente singolare; non è un semplice caso in termini baumaniani (Bauman, 2000, 2003). Questa coincidenza è accentuata dalla contingente situazione contemporanea, che testimonia la liquefazione delle strutture solide del passato. La mancanza di occupazione, la fine della sicurezza del lavoro e la maggiore mobilità delle persone, dovuta ai processi di globalizzazione, hanno creato condizioni che favoriscono una flessibilità non voluta e persistente (almeno per il momento). L’individuo e il sociale sono forse più interconnessi che mai, proprio come la microflora del DNA che si aggrappa quasi inestricabilmente al corpo umano. Ma un evento imprevisto può annullare il lavoro precedente, creando instabilità; allo stesso modo, l’azione di un essere umano e/o di un fattore biologico esterno e ambientale può minare il legame esistente tra una realtà microflorale del DNA e il corpo che lo ospita.
La cosa più intrigante è però il fatto che l’espulsione anche di un solo microbo dalla sua comunità produce effetti che non possono essere sottovalutati. Bisogna, naturalmente, scoprire le ragioni della separazione, ovvero la variabile indipendente che l’ha favorita.
4. Il determinismo situazionale
La teoria del determinismo situazionale avanzata da Lucy Suchman (1987), con la sua “cognizione situata” e “azione situata”, considera l’ambiente come parte del processo cognitivo e operativo; sostiene che la conoscenza è legata al fare ed appartiene a quadri sociali, culturali e fisici. È un dato di fatto, tuttavia, che oggi c’è una marcata tendenza a fare i conti con una modernità in cui non esiste più un rifugio solido, tendenzialmente statico, protettivo, di salvaguardia. In realtà, siamo ora costretti a rinunciare a molte certezze ed a lasciarci assalire da una miriade di preoccupazioni esistenziali di ogni tipo. La stabilizzazione di una comunità non è più un dato di fatto. L’inserimento lavorativo è una preoccupazione sempre più ricorrente. Fallimento e licenziamento si profilano all’orizzonte, che si avvicina sempre di più. La crisi socio-economica non è più una questione marginale che riguarda solo pochi. Instabilità e flessibilità sono praticamente la norma fissata nel tempo e nello spazio. Tutto sommato, come scrive Bauman, i lavori nei luoghi consolidati appaiono oggi come un ricordo del passato; non esistono competenze od esperienze particolari che, una volta acquisite, sono in grado di garantire un lavoro permanente e, soprattutto, a vita (Bauman, 2000: 161). Lo stesso si può dire degli elementi liquidi presenti in alcune cavità del corpo: non sono garantiti per durare nel tempo, esposti come sono al degrado ambientale, all’interazione con altri liquidi e con altre comunità batteriche che entrano in contatto con la mucosa orale, intestinale e vaginale del corpo. Questi fluidi biologici, una volta entrati nell’ambiente, sono soggetti ad ulteriori modificazioni, causate da vari agenti, compresi altri microrganismi. Anche la forma microbica determinata dai residui di mfDNA non dura molto a lungo eppure, sebbene non più vitale, può comunque permetterci di riconoscerne l’origine. Questo vale anche per gli individui sociali, le cui origini sono difficili da nascondere per vari motivi (dal linguaggio che parlano al colore della pelle, dai tratti somatici alle attitudini e comportamenti culturali). Le testimonianze di antiche civiltà, documenti, rovine e resti architettonici, che sopravvivono alle devastazioni del tempo ed alla distruzione, raccontano molto più della storia della loro specifica funzione originaria, riflettendo, come fanno, la complessità, la storia e le radici della società che li ha prodotti. Un’informazione simile non è affatto statica, quindi, ma le sue tracce assumono un significato dinamico e complesso alla luce della texture originale che l’ha generata.
La forma liquida è anche il mezzo per sfuggire alla solidità del potere, comunque esprimibile, ed entrare in mobilità, flessibilità e libera circolazione. La società liquida postmoderna sembra offrire gradi e campi di libertà sempre più ampi, anche se l’instabilità indebolisce i legami esistenti. E cioè l’appartenenza a comunità si riduce e porta all’affermazione di individui senza legami.
In termini più espliciti, Bauman sostiene che la solidità è una maledizione, come ogni altra forma di persistenza, perché quest’ultima è segno di pericolosa incapacità di adattamento ad un mondo che cambia in modo rapido e imprevedibile, alle opportunità che offre inaspettatamente ed alla velocità con cui le risorse di ieri diventano il peso di domani (Bauman, 2001: 231). In realtà, ciò che l’idea di individualizzazione porta con sé è l’emancipazione dal determinismo non scritto, ereditato ed innato al suo carattere sociale (Bauman, 2001: 144). L’individuo non può più contare su un rifugio in cui rifugiarsi. Non c’è più sicurezza.
5. Conclusione
Infine, una posizione da cui studiare l’organizzazione delle società umane (Donaldson, 2001) potrebbe essere quella fornita dall’approccio mfDNA che viene utilizzato per l’analisi delle comunità microbiche. Secondo questa prospettiva, la comunità non è né un mosaico né una somma di identità diverse, ma qualcosa di simile ad un nuovo essere composto, caratterizzato da un proprio genoma: appunto l’mfDNA. Si tratta, in particolare, di una sorta di colonizzazione, l’esito di eventi, contingenze, dinamiche probabilistiche, interrelazioni tra l’individuo (o la società) e l’ambiente.
Inoltre, la comunità non implica una mera lista di specie, ma un ambito che esiste per servire le loro rappresentazioni e interrelazioni relative, non semplicemente singole e biunivoche, agendo all’interno di una complessa rete multifattoriale caratterizzata da un approccio preliminare modellato matematicamente.
Responsabilità ed educazione alla pro-socialità
Premessa
Parlare di responsabilità significa riferirsi ad un concetto che è alla base di tutti i processi sociali e culturali di ogni tempo e di ogni luogo. Lì dove è l’agire di un attore sociale lì è anche in atto un intento di agire o non agire, di intervenire o non intervenire, di parlare o di tacere, di andare in soccorso o di lasciare andare, di provvedere o rinviare, di accogliere o di respingere, di punire o perdonare. Detto altrimenti è nella responsabilità che si gioca la vicenda umana e sociale di tutti i soggetti che sono individui ma al tempo stesso componenti sociali.
Dall’esercizio della responsabilità dipendono conflitti e catastrofi, guerre e contrasti, ma anche paci ed accordi, collaborazioni e convergenze. In verità il punto più strategico è costituito proprio dalla formazione della responsabilità o meglio alla responsabilità.
A lungo si è discusso di un presunto contrapporsi fra principi (o regole) e responsabilità. In merito ci sono riflessioni di illustri pensatori che hanno teorizzato un’insanabile opposizione fra i dettami etici e le scelte di responsabilità. La realtà invece mostra ampie possibilità di composizione tra gli uni e le altre. In effetti il rifarsi a norme morali non pregiudica sempre e comunque l’esercizio della responsabilità. Ovviamente nella misura in cui prevalgono motivazioni ideologiche riesce arduo immaginare soluzioni serene, socialmente utili, produttrici di nuove esperienze cooperative e fautrici di esiti positivi per l’intera società.
Il concetto di responsabilità nella tradizione antropologica
Le scienze sociali si sono interessate molto al tema della responsabilità sia individuale che collettiva o sociale. E l’hanno presa in considerazione sul piano etico e su quello giuridico, come questione estemporanea legata cioè al singolo evento e come questione costante, cioè tipica di una società, di un gruppo, di una comunità, di una tribù. Per esempio l’antropologo inglese Evans-Pritchard (1902-1973) riferendosi agli Azande del Sudan parlava di un procedimento di attribuzione di responsabilità ad un individuo per le difficoltà, i disagi, i mali occorsi all’intera tribù (Evans-Pritchad, 1937). Il soggetto colpevolizzato veniva accusato di stregoneria e di ricorso ad arti malefiche. In tal modo si alleggeriva il peso delle sofferenze indicandone di fatto l’origine. Appunto sull’origine della responsabilità si sono cimentate diverse scuole di pensiero che hanno sviluppato studi comparativi e longitudinali sulle diverse forme di responsabilità, distinguendo quelle tradizionali che prevedevano solo la responsabilità diretta dell’individuo da quelle più avanzate che ampliavano la matrice della responsabilità a più soggetti e ad intenzioni plurime. In tal senso torna utile discernere proprio fra responsabilità ed intento, l’una e l’altro non connessi solo alla singola persona ma risultato di una serie di legami interindividuali che travalicano la coscienza del singolo. Insomma la responsabilità non sarebbe più da limitare al volere unico della persona ma da allargare ad un più vasto contesto. Tra i Barotse della Rhodesia valeva, secondo Gluckman (1911-1975), assai più la dimensione relazionale che non quella individuale (Gluckman 1965), per cui erano da prendere in considerazione sia le dinamiche di rete che quelle dovute alle situazioni del momento.
Da quanto detto si può dedurre che la responsabilità non è mai esclusivamente personale e diretta ma anche collettiva e condivisa, almeno in parte. Nessun individuo è totalmente isolato in se stesso in quanto comunque ed in misura differenziata tiene conto della presenza degli altri e delle loro reazioni. Se si fa eccezione per le situazioni patologiche accentuate dove vigono altri meccanismi si nota piuttosto un’interazione costante fra livello personale e livello socio-comunitario. Da qui nascono poi anche forme cooperative volte, per esempio, anche alla vendetta da attivare in risposta ed in difesa rispetto ad un atto che ha colpito in precedenza un solo individuo ma che in effetti ha toccato l’intero gruppo di sua appartenenza. Così l’intera comunità si fa carico di un impegno che deriva dal danno subito dal singolo ma che è diventato di ordine comune nella misura in cui il danneggiato è parte di un tessuto connettivo saldo e funzionale. Ed allora la risposta da dare appare consona e coerente nell’ambito del sistema culturale e giuridico di riferimento.
Non va trascurata poi la valenza dell’impatto verbale (Hill, Irvine 1993) che ha luogo nel processo di attribuzione di responsabilità, nella procedura difensiva di un accusato di colpa grave, nei processi di legittimazione di un’autorità, nella formazione dell’idea di prestigio assegnato a soggetti che rivestono ruoli di potere e di guida dell’opinione comune e dunque dei modelli culturali di una comunità, di un popolo, di una nazione. In tali termini assume la massima importanza il discorso, come evento straordinario che riposiziona i punti di vista, enfatizza alcune prospettive, ne limita altre, riferisce di fatti, esprime valutazioni. In definitiva autorità ed autorevolezza insieme contribuiscono a rendere credibile una decisione, una visione, una scelta.
La responsabilità secondo Max Weber
Il concetto di responsabilità non è stato usato di frequente dalla sociologia, quasi a voler sottolineare una certa distanza fra la conoscenza scientifica e le implicazioni etiche. In questo senso l’avalutatività come assenza di giudizio su persone e fatti ha investito anche l’uso e la diffusione del termine stesso di responsabilità, ritenuta troppo intrisa di principi morali e di connotazioni ideologiche. Nel contempo non è da trascurare la valenza giuridica del lemma che rimanda, per esempio, all’obbligo di un primo ministro di un governo di dare le dimissioni se gli manca la fiducia parlamentare oppure, su un altro versante, all’imposizione (in punta di diritto civile) di porre rimedio ai danni procurati o di restituire il maltolto. Ma soprattutto è da prendere in considerazione la presa in carico degli effetti che possono derivare da un’azione, da un’opzione, da un mancato intervento, da un’omissione, da una trascuratezza, da una sottovalutazione. Detto altrimenti l’agire individuale comporta sempre e comunque conseguenze sul piano sociale e riveste un carattere morale.
Conviene però fare chiarezza, prima di procedere oltre, sull’uso di due concetti spesso confusi fra di loro, resi interscambiabili, soggetti ad interpretazioni non solo diverse ma spesso opposte: etica e morale. L’ordine delle due parole non è casuale, giacché per ragioni storiche l’una precede l’altra. Infatti l’etimo di etica è di origine greca, quello di morale risale al mondo della latinità. Se così è (difficile avere dubbi su questo) si è indotti a ritenere la morale un insieme di valori, di principi, di regole che si antepongono al pensiero ed all’azione mentre l’etica riguarderebbe il comportamento stesso come risultato finale della morale. Quest’ultima avrebbe un carattere più sociale, condiviso, tipico di un gruppo, di un’etnia, mentre l’etica riguarderebbe piuttosto il singolo soggetto che pensa ed agisce a partire dai contenuti della morale.
Va però anche detto che esiste una filosofia morale che si interessa degli aspetti valoriali ed in particolare della differenza fra bene e male e delle implicazioni che ne derivano. Una complicazione ulteriore proviene comunque dal fatto che spesso si considera l’etica un ramo della filosofia che affronta la questione del bene e del male. E per di più occorre aggiungere l’apporto che giunge dalla prospettiva religiosa che pure affronta il medesimo discorso relativo al bene ed al male. Non va dimenticato che Émile Durkheim (1973: 59) nella sua definizione di religione parlava, non a caso, di una “comunità morale, chiamata chiesa”.
Com’è ampiamente noto, si deve al sociologo tedesco Max Weber (1864-1920) una duplice concezione dell’etica: quella della convinzione e quella della responsabilità (Weber 2000). Nell’etica della convinzione vigono principalmente le norme ed i valori indipendentemente dalle risultanze, da ciò che ne consegue. Per esempio chi non si adegua, sulla base dei propri valori di riferimento, al diktat di una persona dispotica lo fa in nome di un’etica della convinzione, cioè convinto di essere nel giusto e nell’etico comportandosi in tal maniera. Quest’etica dei principi è tipica di un religioso, di un rivoluzionario, di un idealista, di un ideologo, di un sindacalista, di un arbitro, di un giudice. Invece nell’etica della responsabilità si tiene massimamente conto di ciò che si produce con un’azione. Per esempio si può decidere di operare secondo una certa logica pensando ai benefici che ne proverranno. E magari tali benefici potranno esserci a prezzo di qualche rinuncia minore o ininfluente. Infatti Weber sottolinea che a volte ci possono essere sia paradossi nelle conseguenze che contrapposizioni fra i valori.
Questo duplice approccio weberiano è presente nella conferenza su “Politica come professione” (Monaco, 28 gennaio 1919). Secondo Weber (2001: 97-113, passim) “l’etica può presentarsi in un ruolo assai deleterio da un punto di vista morale”. Con ciò si presume che anche dall’etica possano scaturire danni gravi alla società nella misura in cui non tiene conto di ciò che provoca. Non a caso viene citato il discorso evangelico di Gesù sul monte: “Con il sermone della montagna – vale a dire con l’etica assoluta del Vangelo – si pone una questione assai più seria di quanto credono coloro che oggi citano volentieri questi precetti. Non va presa alla leggera. Per essa vale ciò che è stato detto della causalità nella scienza: non è una carrozza che si possa far fermare a piacere per salirvi o scenderne. Al contrario: tutto oppure niente, è proprio questo il suo senso, se ne deve derivare qualcosa di diverso dalla banalità. Cosi, per esempio, la parabola del giovane ricco: ‘Egli se ne andò triste, poiché possedeva molte ricchezze’. Il precetto evangelico è incondizionato e univoco: dai via ciò che possiedi, semplicemente tutto… Sta qui il punto decisivo. Dobbiamo renderci chiaramente conto che ogni agire orientato in senso etico può essere ricondotto a due massime fondamentalmente diverse l’una dall’altra e inconciliabilmente opposte: può cioè orientarsi nel senso di un’‘etica dei principi’ oppure di un’‘etica della responsabilità’. Ciò non significa che l’etica dei principi coincida con la mancanza di responsabilità e l’etica della responsabilità con una mancanza di principi. Non si tratta ovviamente di questo. Vi è altresì un contrasto radicale tra l’agire secondo la massima dell’etica dei principi, la quale, formulata in termini religiosi, recita: ‘Il cristiano agisce da giusto e rimette l’esito del suo agire nelle mani di Dio’, oppure secondo la massima dell’etica della responsabilità, secondo la quale si deve rispondere delle conseguenze (prevedibili) del proprio agire”. Ben diverso è quanto avviene se entra in gioco un’altra etica, quella più responsabile. In effetti “colui che invece agisce secondo l’etica della responsabilità tiene conto, per l’appunto, di quei difetti propri della media degli uomini. Egli non ha infatti alcun diritto – come ha giustamente detto Fichte – di dare per scontata la loro bontà e perfezione, non si sente capace di attribuire ad altri le conseguenze del suo proprio agire, per lo meno fin là dove poteva prevederle. Egli dirà: queste conseguenze saranno attribuite al mio operato. Colui che agisce secondo l’etica dei principi si sente ‘responsabile’ soltanto del fatto che la fiamma del puro principio – per esempio la fiamma della protesta conto l’ingiustizia dell’ordinamento sociale – non si spenga”. Ciò detto, Weber precisa che “nessuna etica al mondo prescinde dal fatto che il raggiungimento di fini ‘buoni’ è legato in numerosi casi all’impiego di mezzi eticamente dubbi o quanto meno pericolosi e alla possibilità, o anche alla probabilità, che insorgano altre conseguenze cattive. E nessuna etica al mondo può mostrare quando e in che misura lo scopo eticamente buono ‘giustifichi’ i mezzi eticamente pericolosi e le sue possibili conseguenze collaterali… Qui, in relazione a questo problema della giustificazione dei mezzi attraverso il fine, anche l’etica dei principi sembra in generale destinata al fallimento. Essa, infatti, ha logicamente soltanto la possibilità di respingere ogni agire che faccia uso di mezzi eticamente pericolosi. Logicamente. Nel mondo reale, tuttavia, noi sperimentiamo continuamente che colui il quale agisce in base all’etica dei principi si trasforma improvvisamente nel profeta millenaristico, e che per esempio coloro che hanno appena predicato di opporre ‘l’amore alla violenza’, nell’istante successivo invitano alla violenza – alla violenza ultima, la quale dovrebbe portare all’annientamento di ogni violenza – cosi come i nostri militari dicevano ai soldati a ogni offensiva: questa sarà l’ultima, porterà la vittoria e poi la pace”. In particolare “colui che agisce in base all’etica dei principi non tollera l’irrazionalità etica del mondo. Egli è un ‘razionalista’ cosmico-etico. Chi di voi conosce Dostoevskij ricorderà senz’altro l’episodio del Grande Inquisitore, dove il problema è trattato con grande precisione. Non è possibile mettere d’accordo l’etica dei principi e l’etica della responsabilità oppure decretare eticamente quale fine debba giustificare quel determinato mezzo, quando si sia fatta in generale una qualche concessione a questo principio”. In definitiva “se si debba agire in base all’etica dei principi o all’etica della responsabilità, e quando in base all’una o all’altra, nessuno è in grado di prescriverlo… Pertanto l’etica dei principi e l’etica della responsabilità non costituiscono due poli assolutamente opposti, ma due elementi che si completano a vicenda e che soltanto insieme creano l’uomo autentico”.
L’educazione alla pro-socialità
Per la creazione dell’“uomo autentico” prospettato da Weber risulta fondamentale un adeguato processo educativo-formativo che approdi ad un’etica basata sulle intenzioni pro-sociali e su una disponibilità al volontariato (Wilson, Musick 1997) come azione fautrice di azioni utili al benessere altrui. In realtà se si ricevono inputs a favore della socievolezza, della disponibilità verso gli altri, della generosità, dell’accoglienza e dell’attenzione rispettosa si creano come degli anticorpi in grado di combattere e sconfiggere l’individualismo, l’egoismo, la sopraffazione, l’anti-socialità, il comportamento violento, l’aggressività, l’invadenza. In pratica l’attitudine verso l’aiuto crea le premesse per incrementare la pro-socialità (Penner, Dovidio 2005), procurando quindi benessere e vantaggi altrui. Non a caso si parla di altruismo come contraccettivo dell’egoismo sfrenato ed opprimente. Per questo l’altruismo (Batson 1991) diventa un modello comportamentale che è motivato dalla volontà decisa, volta a fare il bene dell’altro, a desiderare e permettere il suo benessere. Il che avviene anche pagando dei costi, affrontando delle rinunce, facendo dei sacrifici, usando di fatto una propensione oblativa, di offerta, di prendersi cura (Cipriani, Stievano 2018), di accompagnare, di sostenere.
Talora si registra qualche vantaggio per lo stesso individuo che si china verso gli altri per sorreggerli ma questo dettaglio non inficia del tutto l’intento iniziale di chi si avvicina per soccorrere, salvare, proteggere. Al contrario l’atteggiamento egoistico ed autoreferenziale non fa che rispondere al desiderio, talvolta smodato, di migliorare al massimo il proprio benessere, di trarre il più alto tornaconto a proprio vantaggio.
Può anche capitare che il comportamento pro-sociale non sia spiegabile in chiave di filantropia, di bontà, come pure che un orientamento altruistico non incida a favore della società, dunque con un carattere pro-sociale.
Le azioni dirette verso l’esterno della propria individualità sono numerose e differenziate. Vanno dal semplice intervento all’atto caritatevole, dal dono alla cooperazione, dal volontariato al conforto, dal sacrificio alla condivisione. Ognuna di queste attività impiega del tempo, sottratto ad altre incombenze, pure rilevanti per il soggetto in quanto attore sociale.
E non solo si investe sul tempo ma anche sulle risorse umane e materiali. Da questo provengono anche profitti nel campo della cooperazione, della mutualità, dell’assistenza, del coordinamento dell’associazionismo non lucrativo (ONLUS, ONG, ecc.), che tuttavia non appaiono come interventi di aiuto in senso stretto in quanto producono vantaggi economici per gli stessi operatori. Nondimeno l’insieme di queste iniziative può rientrare nel novero del pro-sociale in quanto generano conseguenze positive per la società, anche se non è facile annoverarle nell’ambito dell’altruismo vero e proprio. Per definirle altruistiche occorrerebbe conoscere a fondo i motivi che animano coloro che prestano la loro opera in funzione di aiuto.
Questa apertura al pro-sociale ha indubbie matrici religiose e culturali allo stesso tempo. Si può riandare all’ospitalità della Grecia classica ma anche alla ϕιλία intesa come amicizia, amore verso il prossimo, il vicino, l’altro. E qui si innesta evidentemente anche la tradizione ebraico-cristiana, che giunge sino a David Hume (1739) e Adam Smith (1759) ed alle loro concezioni della compassione e della benevolenza. Ma invero è stato Auguste Comte (1851) ad inventare il termine “altruismo”, che descrive la motivazione per portare aiuto agli altri.
Forse però il contributo più significativo è dovuto a Kurt Lewin (1936) inventore dell’equazione B=f(P, E), dove B (behavior) è il comportamento il quale è funzione (f) della persona (P) e dell’ambiente (E ovvero environment). Nella concezione della persona sono inclusi i caratteri ereditari, le competenze, la personalità. L’ambiente è costituito principalmente dalla situazione e dalle persone che in essa sono presenti. Molto si è discusso se in questa formula lewiniana abbia maggior rilievo la dimensione personale o la situazione sociale. Quale che sia la risposta ad un simile interrogativo resta comunque acclarato che l’atteggiamento ed il comportamento pro-sociali insistono soprattutto sull’individuo ed anche sul contesto cui egli appartiene. In altri termini molto dipende dai tratti della personalità che si costruisce nel tempo e dalla società circostante. L’una e l’altra poi hanno la loro matrice di base nei processi educativo-formativi pregressi. Da qui l’importanza strategica di ogni momento della socializzazione di una persona che si va ad inserire, sin dalla sua nascita, nel consorzio sociale.
Riferimenti bibliografici
Batson, C. D. 1991, The Altruism Question. Toward a Social Psychological Answer, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, N. J.
Cipriani, R., Stievano, A. (a cura di) 2018, Prendersi cura. Malati, infermieri e volontari nel Giubileo della Misericordia, FrancoAngeli, Milano.
Comte, A. 1851, Système de Politique Positive ou Traité de Sociologie instituant la Religion de l’Humanité, Mathias, Carilian-Goeury, Dalmont, Paris.
Durkheim, É. 1973, Le forme elementari della vita religiosa. Il sistema totemico in Australia, Newton Compton Italiana, Roma; ed. or., Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Alcan, Paris, 1912.
Evans-Pritchard, E. E. 1937, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Clarendon Press, Oxford; ed. it., Stregoneria, oracoli e magia fra gli Azande, Angeli, Milano, 1976.
Gluckman, M. 1965, The Ideas in Barotse Jurisprudence, Yale University Press, New Haven-London.
Hill, J, Irvine, J. 1993, Responsibility and Evidence in Oral Discourse, Cambridge University Press, Cambridge.
Hume, D. (anonimo), 1739 (voll. I-II), 1740 (vol. III), A Treatise of Human Nature.
Lewin, K. 1936, Principles of Topological Psychology, McGraw-Hill, New York.
Penner, L. A., Dovidio, J. F. (2005), “Prosocial Behavior: A Multilevel Perspective”, Annual Review of Psychology, 56, 365-392.
Smith, A. 1759, The Theory of Moral Sentiments.
Weber, M. 2000, L’etica della responsabilità, La Nuova Italia, Firenze.
Weber, M. 2001, La scienza come professione. La politica come professione, Edizioni di Comunità, Milano. Wilson, J., Musick, M. 1997, “Who Cares? Toward an Integrated Theory of Volunteer Work”, American Sociological Review, 62, 694-713.
La Chiesa cattolica in Italia, oggi
La Chiesa cattolica in Italia, oggi
Roberto Cipriani
Abstract
1. Premessa
A tre lustri di distanza dalla prima ed unica (almeno sinora) indagine completamente dedicata al fenomeno religioso in Italia, per di più sulla base di un campione realmente statisticamente rappresentativo dell’intero territorio nazionale[1], non è agevole rendere conto della situazione odierna relativa alla Chiesa cattolica nel nostro paese. Sono molte le dinamiche sociologiche intervenute nel frattempo a livello sociale, politico, economico e culturale, nonché attitudinale e comportamentale, che andrebbero debitamente analizzate ed interpretate[2]. Com’è noto, la ricerca scientifica in questi ultimi anni ha subito pesanti restrizioni economiche che non hanno consentito il decollo di progetti d’indagine pur necessari.
Ci si deve dunque ridurre a trarre indicazioni da indizi e dati di diversa provenienza e natura, per potere tentare – in assenza di elementi più probanti – di offrire un quadro della situazione in termini sufficientemente plausibili, ma non certo del tutto soddisfacenti, rispetto a quello che la vasta problematica in esame meriterebbe.
Non sono mancati invero alcuni contributi anche significativi, ma si tratta di studi parziali, territorialmente circoscritti e dunque non in grado di fornire una visione complessiva relativa all’intera popolazione nazionale.
2. Chiesa cattolica e Stato italiano
Un punto cruciale che condiziona il tipo di presenza del cattolicesimo in Italia è rappresentato dall’esistenza di un apposito accordo istituzionale, in forma codificata e legittimata, fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Ernesto Galli Della Loggia ha scritto in proposito che la storia dello Stato italiano «appare troppo inestricabilmente intrecciata alla vicenda del Cristianesimo e della Chiesa romana perché sia realmente plausibile immaginare un reciproco disinteresse, una reale indifferenza dell’una rispetto all’altra all’insegna dell’unilateralità»[3]. La formula pattizia risale all’epoca del fascismo, in data 11 febbraio 1929, ma è stata recepita anche nell’articolo 7 della costituzione italiana della repubblica, nata dopo la fine del secondo conflitto mondiale, e ribadita successivamente con l’Accordo del 18 febbraio 1984, auspice il governo presieduto da Bettino Craxi. La legge 222 del 1985 veniva poi a dare un sostegno decisivo alla Chiesa cattolica attraverso la destinazione delle somme provenienti dall’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nelle complesse vicende che hanno accompagnato il declino del socialismo craxiano prima e l’avvento di Berlusconi e di Forza Italia poi, in buona misura erede dei voti già democristiani, un peso rilevante ha avuto la presidenza della Conferenza Epsicopale Italiana, in particolare sotto la gestione ultraquindicennale (1991-2007) del cardinale Camillo Ruini, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Quest’ultimo ha di volta in volta cercato ulteriori appoggi da parte del governo italiano su questioni di varia natura. Al termine del suo lungo mandato, la Segreteria di Stato del Vaticano ha voluto avocare a sé la competenza diretta per gli affari italiani, anche in forza delle normative vigenti che vedono come interlocutore la stessa Santa Sede e non certamente la conferenza nazionale dei vescovi.
Anche nella prospettiva affacciatasi più di recente, con l’ipotesi della costituzione di un centro partitico-politico di marca cattolica, l’influenza del Segretario di Stato vaticano non appare secondaria. Venuto meno, per molteplici ragioni, l’affiancamento rispetto alla coalizione governativa berlusconiana, si pensa ora a nuovi scenari, resi probabili da un prevedibile esaurirsi dell’esperienza in corso, per cui si immagina la possibilità di un recupero di un ruolo specifico dei cattolici in campo politico.
Alcuni eventi di questi ultimi tempi comproverebbero l’esistenza di operazioni tese a sganciarsi dal carro degli ex-vincitori per trovare invece nuove soluzioni di convenienza. Ma nell’incertezza del momento i passi sono cauti, prudenti, in attesa di sviluppi più chiari.
Nel frattempo alcuni intellettuali cattolici stanno promuovendo azioni di rivisitazione storica di alcuni fatti del passato: dalle crociate all’inquisizione, dalla rivoluzione francese al risorgimento italiano. L’obiettivo è una rivalutazione dell’azione della Chiesa e dei cattolici in generale, in relazione ad avvenimenti strategici nella storia dell’Italia cattolica.
Si riapre a questo punto l’annosa diatriba sulla laicità dello Stato e della politica, già riemersa in modo diffuso in occasione del centenario della legge francese del 1905, che aveva portato a molti espropri di beni ecclesiastici ed all’abolizione di vari benefici a favore della Chiesa cattolica. Su questo tema ho già avuto modo di intervenire, per cui mi limito a ribadire una mia lettura della questione in termini sintetici: «la stessa religione fornisce strumenti analitici e definitori per distinguere sacro e secolare, anima e corpo, sentimento e ragione, spirituale e temporale, ragion per cui le soglie di laicizzazione sono facilmente rinvenibili e praticabili come punti-limite, per evitare invasioni di campo, colonizzazioni, espansioni indebite. Ma d’altro canto lo stato laico proprio perché tale non può negare diritto di cittadinanza alle varie esperienze religiose dei suoi cittadini. L’autonomia del soggetto non può non stare a cuore allo stato, chiamato invece ad allontanare quanto possa arrecare danno. Nessun rappresentante di uno stato democratico può negare ai cittadini-membri il diritto alla credenza (o alla non credenza) religiosa. Per non dire poi di quello che una o più religioni possono rappresentare per la storia di un paese come la Francia (od anche la Germania e l’Italia), in relazione alla conservazione dell’appartenenza territoriale e della memoria locale. All’orizzonte c’è una prospettiva che contempla non più la strumentalizzazione o la mera contrapposizione ma una possibile sinergia, nel rispetto reciproco, fra stato e religione/i»[4].
Posta una premessa formulata in tali termini c’è da chiedersi fino a che punto sia laica un’attività di lobby esercitata da gerarchie ecclesiastiche nei riguardi dello Stato ed in particolare del suo governo. E soprattutto vale la pena di domandarsi se le carenze delle formazioni partitico-politiche giustifichino l’intervento diretto di una Chiesa (cattolica e non) nelle questioni di gestione della struttura statale, nell’attività legislativa, nell’accesso alle risorse pubbliche. Se anche è reale l’incapacità delle culture politiche italiane di affrontare in modo adeguato la complessa e delicata querelle sull’autonomia dello Stato e su quella delle Chiese organizzate, che diritto ha una specifica struttura religiosa di occupare anche il ruolo che spetta di diritto e di fatto alla sua controparte statale?
Che la religione cattolica sia la religione diffusa per eccellenza, nel nostro paese è indubitabile[5] ma un conto è riferirsi a dei valori che orientino l’agire nella sfera pubblica un altro conto è l’iniziativa mirata su esponenti del governo, per ottenerne vantaggi normativi ed economici.
Il discorso si allarga poi ad altri ambiti, per i quali si richiede un orientamento preciso ed operativo: dalla presenza del crocifisso nelle scuole al finanziamento delle scuole private, dal riconoscimento delle radici cristiane dell’Europa al diniego dell’eutanasia, dal rifiuto dell’aborto all’opposizione nei riguardi dell’inseminazione artificiale e di altre sperimentazioni genetiche.
Il tutto peraltro è accompagnato da una scarsa dimestichezza del popolo cattolico con la teologia, con la dottrina sociale della Chiesa, con le problematiche scientifiche di maggio rilievo. Il che lascia ampio spazio all’agire dei vertici ecclesiastici che per un verso perdono consenso fra la base ecclesiale e per un altro verso cercano presso gli attori politici un credito che però di fatto viene usato strumentalmente in una sorta di scambio politico-elettorale: da una parte si chiede appoggio per mettere a segno qualche risultato legislativo o per ricevere qualche sovvenzione economica, dall’altra si domanda il favore di organizzazioni, strutture ed associazioni d’impronta cattolica in occasione di scadenze elettorali.
Sintomatico è il rapporto, per esempio, con il partito della Lega Padana, che ricorre a simbologie neo-pagane ma non disdegna la non belligeranza della Chiesa cattolica. Fra l’altro è da immaginare una certa pressione del partito padano per quanto concerne pure le nomine dei vescovi, che si auspicano ben legati al territorio, insomma padani in Padania. Esemplare è quanto sostiene Renzo Guolo, un sociologo che è un profondo conoscitore e dell’immigrazione islamica in Italia e della realtà leghista, in particolare di Treviso: «città di forte tradizione cattolica, dove la Dc aveva le stesse, altissime, percentuali di consenso che oggi ha la Lega,la Chiesa è sempre stata vicina ai più deboli. Così è stato sul fronte degli immigrati e della libertà di culto per i musulmani. Scelte che hanno provocato a partire dalla metà degli anni novanta un duro scontro con la Lega. Uno scontro che ha visto il Carroccio contrapporsi ai cosiddetti “preti rossi”, un ossimoro politico che i leghisti hanno coniato per stigmatizzare i sacerdoti più impegnati su quel versante. Sacerdoti che sono stati difesi strenuamente dal loro vescovo; almeno sino a quando la Lega è diventata forza di governo nazionale e vi è stato un mutamento della guida episcopale. Si è giunti così a una sorta di tacito compromesso, ispirato alla realpolitik, che ha profondamente diviso il mondo cattolico locale. Un compromesso che sul piano nazionale vede la Chiesa guardare oggi al carroccio come a un partito affidabile sul piano dei “valori non negoziabili”, in particolare sul terreno della bioetica e della famiglia»[6].
Più problematico è il rapporto con il Partito Democratico (nato il 14 ottobre 2007), dal quale si sono staccati alcuni esponenti cattolici, fra cui la parlamentare Paola Binetti, ma che vede pure una cattolica, Rosy Bindi, alla sua presidenza. Il dialogo avviato in tempi ormai lontani fra Enrico Berlinguer, segretario dell’allora Partito Comunista Italiano, ed il vescovo di Ivrea, monsignor Luigi Bettazzi, non ha avuto sviluppi degni di nota. Politici cattolici hanno militato nei Democratici di Sinistra e nella Margherita (fino al 2007) ma per ragioni personali o per limitazioni poste dalle rispettive segreterie politiche non hanno avuto un impatto rimarchevole, almeno a livello diffuso. Così il dialogo fra mondo cattolico e sinistra politica è parso interrompersi. Si può dire, invero, che neppure tra i vertici vaticani ci sia stata una particolare attenzione, che invece non è mancata – sia pure a corrente alternata, per qualche intemperanza del premier Berlusconi – nei confronti di Forza Italia prima e del Popolo della Libertà poi. Segnatamente negli ultimi anni ne è stato protagonista lo stesso cardinale Tarcisio Bertone, nella sua veste ufficiale di Segretario di Stato del Vaticano. Ma anche altri hanno dato man forte: si pensi a monsignor Rino Fisichella, dapprima rettore della Pontificia Università Lateranense e poi presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Intanto qualche esito appare già evidente: quello che un tempo era il cattolicesimo democratico ha oggi perso molta lena, tanto da non essere quasi più riconoscibile a livello di presa di parola in pubblico; di converso non sembra più avere molto seguito il cosiddetto progetto culturale promosso dal cardinale Camillo Ruini nella sua qualità di presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Le azioni e gli interventi di soggetti rappresentativi dell’intellettualità cattolica democratica e di sinistra non hanno prodotto gli effetti desiderati. In pratica si può dire che la scomparsa di uomini come lo storico Pietro Scoppola ed il sociologo Achille Ardigò abbiano segnato altresì la fine di un’epoca, quella del confronto dialogante, favorendo invece lo sviluppo di discussioni teoricamente meno fondate, quasi tutte orientate come sono al da farsi quotidiano, anzi orario data la forte accelerazione dei cambiamenti in atto nella politica italiana. In definitiva l’ipotesi di una politica di rapporti sia pure laici fra sinistra politica e Chiesa cattolica e/o Vaticano è ancora di là da venire e non presenta neppure i prodromi che possano avviare la discussione in merito. Ovviamente non si pensa a ristabilire forme di collateralismo quali i Comitati Civici (galoppinaggio elettorale a favore della Democrazia Cristiana), promossi da Pio XII nel 1948 e messi in atto (fino al 1974) da Luigi Gedda, presidente generale dell’Azione Cattolica Italiana. Si tratta più verosimilmente di raccordare sensibilità diverse ma anche cospicue per la loro diffusione tra la popolazione italiana. Come a dire: non un cartello di intese politico-elettorali ma posizioni di ascolto reciproco in vista del bene comune dei cittadini.
3. L’adesione religiosa dell’otto per mille
L’accordo stipulato nel 1984 con lo Stato italiano ha dato adito alla Chiesa cattolica di acquisire risorse importanti, specialmente grazie alla legge successiva, promulgata nel 1985, sul cosiddetto otto per mille. Tale operazione ha dato indubbiamente linfa vitale alle strutture ecclesiastiche italiane, che se ne sono giovate ampiamente, come mostrano le cifre e segnatamente l’andamento sostanzialmente costante delle entrate a loro favore.
L’entrata in vigore della normativa approvata non è stata immediata ma ha avuto inizio nel 1990, allorquando per la prima volta si sono contate le scelte operate dai contribuenti italiani tra le opzioni possibili, che elencavano, fra l’altro, sia lo Stato che la Chiesa cattolica.
L’andamento nel corso degli anni è stato altalenante, con incrementi e decrementi di volta in volta, senza che si potesse individuare una chiara linea di tendenza a lunga gittata, ma in linea di massima si è registrata una discreta tenuta dei flussi. Però fare ora delle previsioni per quanto concerne l’immediato futuro rischia di essere fallace. Giova comunque tenere presente la dinamica del numero delle firme (o, meglio, delle quote percentuali riconosciute dallo Stato) in favore della Chiesa cattolica, di anno in anno:
Tab. 1
QUOTE COMPLESSIVE* DELL’8‰ PER LA CHIESA CATTOLICA
| Anno | Quote per la Chiesa cattolica % * | Differenza in aumento (+) o in diminuzione (-) rispetto all’anno precedente |
| 1990 | 76,17 | = |
| 1991 | 81,43 | + |
| 1992 | 84,92 | + |
| 1993 | 85,76 | + |
| 1994 | 83,60 | – |
| 1995 | 83,68 | + |
| 1996 | 82,56 | – |
| 1997 | 81,58 | – |
| 1998 | 83,30 | + |
| 1999 | 86,58 | + |
| 2000 | 87,17 | + |
| 2001 | 87,25 | + |
| 2002 | 88,83 | + |
| 2003 | 89,16 | + |
| 2004 | 89,81 | + |
| 2005 | 89,82 | + |
| 2006 | 86,05 | – |
* Va considerato che l’ammontare delle somme attribuite
deriva dalle firme effettivamente apposte ma anche dalla ridistribuzione in percentuale
della quota parte non assegnata (per mancanza di firme).
Pertanto il numero reale di firme per la Chiesa cattolica
è di fatto inferiore alle percentuali indicate in tabella.
Fonte: Elaborazione su Comunicazioni dello Stato italiano alla Conferenza Episcopale Italiana
Lo Stato italiano ha versato ogni anno alla Chiesa cattolica un’anticipazione, prima di provvedere ad un conguaglio negli anni successivi, una volta accertata la ripartizione dovuta delle quote.
Nel 1989, prima dell’entrata in vigore della legge 222, la Chiesa cattolica aveva ricevuto per l’ultima volta la somma di 406 miliardi di lire in relazione alla congrua, per 399 miliardi di lire, ed all’edilizia per il culto, per 7 miliardi. Per gli anni 1990, 1991 e 1992 aveva ottenuto un pari anticipo annuale di 406 miliardi di lire, nella medesima misura dunque della somma percepita nel 1989. Per il 1993 l’ammontare dell’anticipo, in lire, è stato pari a ciò che oggi corrisponde a 303 milioni di euro, per il 1994 a 363 milioni di euro e per il 1995 a 449 milioni sempre di euro.
A partire dal 1996 sono stati attribuiti i conguagli relativi a tre o più anni precedenti. Ecco dunque il quadro dettagliato degli introiti dal 1990 al 2009, calcolati sempre in milioni di euro per ragioni comparative (anche se i versamenti sono avvenuti in lire, nei primi anni di applicazione della legge e dunque fino all’introduzione della nuova moneta europea):
Tab. 2
ANTICIPI E CONGUAGLI DELL’8‰
(in milioni di euro)
| Anno | Anticipo | Conguaglio | TOTALE |
| 1990 | 210 | – | 210 |
| 1991 | 210 | – | 210 |
| 1992 | 210 | – | 210 |
| 1993 | 303 | – | 303 |
| 1994 | 363 | – | 363 |
| 1995 | 449 | – | 449 |
| 1996 | 491 | 260 | 751 |
| 1997 | 476 | 238 | 714 |
| 1998 | 494 | 192 | 686 |
| 1999 | 539 | 216 | 755 |
| 2000 | 555 | 88 | 643 |
| 2001 | 630 | 133 | 763 |
| 2002 | 726 | 184 | 910 |
| 2003 | 788 | 228 | 1.016 |
| 2004 | 783 | 154 | 937 |
| 2005 | 854 | 130 | 984 |
| 2006 | 859 | 71 | 930 |
| 2007 | 887 | 104 | 991 |
| 2008 | 928 | 74 | 1.003 |
| 2009 | 913 | 54 | 968* |
| 1990-2009 | 11.668 | 2.126 | 13.796* |
* Tutte le cifre sono arrotondate, per cui il totale non corrisponde alle somme effettive.
Per esempio il totale effettivo del 2009 è di 967 milioni e 538.000 euro.
Fonte: Elaborazione su Comunicazioni dello Stato italiano alla Conferenza Episcopale Italiana
Uno dei vantaggi derivanti dalla legge 222 è connesso al fatto che l’entità del sussidio statale non è più commisurato al numero dei sacerdoti secolari e regolari (che è andato diminuendo, nel suo complesso, in questo ultimo ventennio) ma al totale delle firme a favore della Chiesa cattolica, cui si aggiunge la percentuale derivante (in misura proporzionale al numero di firme) dalle quote non assegnabili per mancanza di scelta da parte del contribuente fra le alternative possibili. Insomma anche chi non firma risulta offrire comunque un vantaggio al maggiore destinatario, appunto la Chiesa cattolica.
Le opzioni in forma di firma a favore della medesima Chiesa hanno segnato un costante aumento in percentuale dal 1990 al 1993 e dal 1998 al 2005, mentre riduzioni – rispetto all’anno immediatamente precedente – si sono registrate negli anni 1994, 1996 e 1997, nonché nel 2006. Se si prescinde dalle percentuali, gli anni per così dire in sofferenza, per minori entrate, sono il 1997, il 1998, il 2000, il 2004, il 2006 ed il 2009. Riesce difficile stabilire le ragioni di tali riduzioni, legate probabilmente a fattori piuttosto contingenti (per esempio, sia durante il pontificato di Giovanni Paolo II che quello di Benedetto XVI si sono registrati talora qualche calo talora qualche incremento). Forse la differenza di risultati può derivare anche dal tipo e dal contenuto della campagna pubblicitaria effettuata a livello di mezzi di comunicazione di massa oppure da eventi internazionali, nazionali e persino locali che possono aver condizionato le scelte.
Vanno poi prese in considerazione le utilizzazioni delle somme percepite, le quali vengono devolute per tre finalità: il sostentamento del clero, le necessità di culto e le attività pastorali, e l’azione caritativa in Italia ed all’estero.
Vi sono state nel corso degli anni rimarchevoli differenze, specialmente nell’ambito di alcune voci per la ripartizione dei fondi. Quelle specifiche per il sostentamento del clero sono più che raddoppiate dal 1990 al 2009, giacché sono passate da 145 milioni di euro nel 1990 a 381 milioni nel 2009.
Quelle caritative a favore del Terzo Mondo erano 15 milioni di euro nel 1990 ma sono divenute 85 milioni di euro nel 2009, cioè risultano moltiplicate di quasi sei volte (i progetti finanziati dal 1990 al 2009 sono stati 9.955). Nel contempo le provvidenze di carità ad uso delle diocesi italiane sono aumentate di nove volte, visto che erano appena 10 milioni di euro nel 1990 e sono risultate essere 90 milioni nel 2009. Tale dato fa pensare che la carità da esercitare nel nostro paese sia da preferire a quella da destinare ai paesi terzomondiali.
Sono poi predominanti le spese diocesane per il culto e la pastorale, che attingono la cifra di 156 milioni di euro nel 2009 mentre erano di soli 18 milioni nel 1990: l’aumento è di quasi nove volte.
Inoltre sono stati anche accantonati 50 milioni di euro nel 2003 per culto, pastorale e carità, di cui sono stati spesi per culto e pastorale 5 milioni di euro e per carità 10 milioni di euro nell’anno 2004, ma nel 2005 vi è stata un’integrazione del medesimo accantonamento per 3 milioni di euro; infine nel 2009 all’assegnazione statale di 967 milioni e 538.000 euro si sono aggiunti 42 milioni di euro provenienti dagli accantonamenti degli anni precedenti, “a futura destinazione per esigenze di culto e pastorale e per interventi caritativi”.
In realtà, in base ai nostri conteggi ed alle informazioni ufficiali rese note, si dovrebbe trattare di 38 milioni di euro, ma probabilmente il fondo è stato incrementato di altri 4 milioni di euro. Sta di fatto che su questo aspetto particolare il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa offre informazioni contraddittorie, in quanto nella documentazione ufficiale si parla anche di un fondo di riserva, che però potrebbe anche essere il già citato fondo di accantonamento.
Orbene nell’ambito delle iniziative di rilievo nazionale si fa riferimento appunto ad un fondo di riserva, «costituito nel 2000 con 8 milioni di euro, integrato poi nel 2002 con 15 milioni di euro e nel 2003 con 30 milioni, e destinato ad essere utilizzato in futuro per le iniziative di culto e pastorale»[7].
A questo punto, con buona probabilità accantonamento e fondo di riserva riguardano la medesima operazione. Ma i conti non tornano, anche a voler considerare gli effetti di eventuali arrotondamenti. Infatti per l’accantonamento del 2003 viene indicata la cifra di 50 milioni di euro ma per il fondo di riserva, sempre del 2003, il totale sarebbe di 53 milioni di euro, derivanti dagli 8 milioni di euro messi da parte nel 2000, cui si sono aggiunti 15 milioni di euro nel 2002 ed altri 30 nel 2003, dunque per un totale di 53 milioni di euro.
In definitiva delle due l’una: o 50 o 53 milioni. Un arrotondamento di ben 3 milioni non è verosimile. Comunque il quadro che ne emerge non è affatto chiaro o quantomeno non vengono forniti elementi sufficienti per una comprensione dei calcoli effettuati e delle somme in questione).
Nell’ambito del totale delle spese per culto e pastorale (che includono anche quelle per i 19 Tribunali ecclesiastici regionali, sovvenzionati con 4 milioni di euro nel 2000 e con 10,5 milioni di euro nel 2009 per rendere meno onerose le spese giudiziarie relative all’annullamento dei matrimoni), la stessa Conferenza Episcopale Italiana ha potuto accertare che per il culto in particolare la percentuale media diocesana di utilizzo è il 24%, per la cura delle anime il 49%, per le attività in diocesi il 13%, per la formazione del clero secolare e regolare il 9%, per la catechesi e l’educazione il 4%, per le missioni l’1%.
Un’ultima non meno importante voce concerne la nuova edilizia di culto, che prevedeva 15 milioni di euro nel 1990 e che ha attribuito 122 milioni di euro nel 2009, cioè una somma più di otto volte maggiore di quella iniziale.
In definitiva edilizia e culto e pastorale sembrano le destinazioni privilegiate. Insomma strutture edilizie e organizzative hanno la meglio su tutto il resto.
Un discorso a parte merita la voce “tutela beni culturali ecclesiastici”, del tutto assente nel 1990, inaugurata nel 1996 con 52 milioni di euro, ridotta a soli 3 milioni di euro nel 2000 (presumibilmente in concomitanza con altre provvidenze pubbliche, in occasione dell’Anno santo) e passata a 65 milioni di euro nel 2009.
L’incremento maggiore è quello riguardante le iniziative di rilievo nazionale nell’ambito delle esigenze di culto della popolazione: all’inizio, nel 1990, erano finanziate con soli 4 milioni di euro ma alla fine, nel 2009, hanno ottenuto 80 milioni di euro, dunque un aumento venti volte superiore a quello di diciannove anni prima.
Più contenuto è l’incremento degli interventi di rilievo nazionale per la carità: vanno dai 2 milioni di euro del 1990 ai 30 milioni di euro nel 2009, per cui dopo venti anni la somma si moltiplica per quindici.
Ecco le varie voci in dettaglio, suddivise per anno e per destinazione:
Tab. 3
DESTINAZIONI DELL’8‰ DA PARTE DELLA CHIESA CATTOLICA
(in milioni di euro)
| Anno | Culto e pastorale | Edilizia di culto | Beni culturali | Iniziative nazionali | Carità diocesana | Terzo mondo | Carità nazionale | Clero | TOTALE |
| 1990 | 18 | 15 | – | 4 | 10 | 15 | 2 | 145 | 210 |
| 1991 | 23 | 23 | – | 9 | 15 | 26 | 4 | 108 | 210 |
| 1992 | 23 | 26 | – | 9 | 15 | 28 | 4 | 103 | 210 |
| 1993 | 31 | 30 | – | 10 | 21 | 30 | 3 | 177 | 303 |
| 1994 | 33 | 38 | – | 15 | 21 | 39 | 5 | 212 | 363 |
| 1995 | 46 | 65 | – | 36 | 31 | 65 | 5 | 201 | 449 |
| 1996 | 118 | 74 | 52 | 75 | 68 | 72 | 5 | 287 | 751 |
| 1997 | 118 | 77 | 52 | 80 | 68 | 72 | 5 | 241 | 714 |
| 1998 | 118 | 73 | 41 | 69 | 68 | 62 | 4 | 249 | 686 |
| 1999 | 118 | 76 | 62 | 111 | 68 | 65 | 4 | 250 | 755 |
| 2000 | 118 | 54 | 3 | 58 | 65 | 54 | 7 | 284 | 643 |
| 2001 | 134 | 83 | 26 | 81 | 69 | 65 | 16 | 290 | 763 |
| 2002 | 150 | 120 | 50 | 107 | 75 | 70 | 30 | 308 | 910 |
| 2003 | 150 | 130 | 50 | 122 | 75 | 80 | 30 | 330 | 1.016 |
| 2004 | 150 | 130 | 70 | 92 | 80 | 80 | 30 | 320 | 937 |
| 2005 | 155 | 130 | 70 | 116 | 85 | 80 | 30 | 315 | 984 |
| 2006 | 155 | 117 | 63 | 64 | 85 | 80 | 30 | 336 | 930 |
| 2007 | 160 | 117 | 68 | 88 | 90 | 85 | 30 | 354 | 991 |
| 2008 | 160 | 117 | 68 | 80 | 90 | 85 | 30 | 373 | 1.003 |
| 2009 | 156 | 122 | 65 | 80 | 90 | 85 | 30 | 381 | 968* |
| 1990-2009 | 2.134 | 1.617 | 740 | 1.306 | 1.189 | 1.238 | 304 | 5.264 | 13.796 |
* Tutte le cifre sono arrotondate, per cui il totale non corrisponde alle somme effettive. Per esempio il totale effettivo del 2009 è di 967 milioni e 538.000 euro.
Fonte: Elaborazione su Rendiconti della Conferenza Episcopale Italiana allo Stato 1990-2008
e Assegnazioni dell’Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana 2009
In definitiva culto, attività pastorale e sostentamento del clero assorbono più della metà dell’intero ammontare dell’otto per mille. Dunque prevalgono le destinazioni a livello organizzativo della Chiesa cattolica. Il resto è in subordine. E la nuova edilizia cultuale ha la meglio sulla conservazione dei beni, pur cospicui.
La distribuzione delle somme alle diocesi per culto e pastorale viene effettuata sulla base di un doppio criterio: una prima metà dell’intero ammontare va a costituire un plafond comune per tutte le 226 diocesi, grandi o piccole che siano; l’altra metà del finanziamento è proporzionato al numero di abitanti residenti in diocesi.
Per quanto riguarda il finanziamento degli edifici di culto la Conferenza Episcopale Italiana offre alle diocesi solo una parte di quanto necessario (fino al 75% per nuova edilizia e fino al 50% per vecchia edilizia). L’intento di questa modalità di cofinanziamento è coinvolgere i fedeli, perché anch’essi contribuiscano in parte a sostenere le spese relative alla propria comunità.
Il patrimonio culturale ed artistico della Chiesa cattolica è notevole: circa 85.000 templi su un totale di 90.000 sono ritenuti un patrimonio culturale. Vi sono inoltre 1.535 monasteri, quasi 3.000 monumenti, 26.000 archivi, 5.500 biblioteche, 700 musei e collezioni. Difficile è, per di più, riuscire ad enumerare sculture, dipinti ed altre preziose opere d’arte in possesso della Chiesa cattolica italiana.
Un precipuo interesse presentano i dati sul sostentamento del clero. Nel 2008 un giovane sacerdote neo-ordinato ha ricevuto mensilmente 862,86 euro ed un vescovo quasi al termine del suo mandato ha riscosso mensilmente 1.341,90 euro. Il totale dei sacerdoti in servizio è stato di 37.689 unità, di cui 34.649 in attività nelle diocesi italiane o nelle missioni estere (in cui sono stati impegnati 548 preti) e 3.040 in previdenza integrativa, per ragioni di età o di salute.
Il sostentamento del clero non deriva esclusivamente dall’otto per mille. Infatti ci sono sacerdoti che hanno già un’attività retribuita, come insegnanti di religione o cappellani negli ospedali e nelle carceri, oppure come operatori pastorali nelle diocesi e nelle parrocchie. Si aggiungono poi le rendite degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero. A sua volta l’Istituto Centrale Sostentamento Clero contribuisce in parte con le offerte ricevute (deducibili dall’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) ed in parte con i fondi provenienti dall’otto per mille. La distribuzione percentuale delle fonti di finanziamento del clero risulta dalla tabella che segue.
Tab. 4
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL CLERO
| Fonte di finanziamento | Milioni di euro | % |
| Retribuzioni dei sacerdoti insegnanti o cappellani | 112,9 | 20 |
| Retribuzioni dei sacerdoti operatori pastorali | 45,7 | 8 |
| Rendite degli Istituti diocesani sostentamento clero | 47,3 | 8 |
| Offerte deducibili (da Istituto Centrale Sostentamento Clero) | 16,8 | 3 |
| Otto per mille (da Istituto Centrale Sostentamento Clero) | 343,3 | 61 |
| TOTALE | 556,0 | 100 |
Nella documentazione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana si legge che nel 2008 occorrevano 566 milioni di euro per il sostentamento del clero, l’IRPEF, la previdenza, l’assistenza e l’assicurazione sanitaria. Quando però si passa a quantificare nel dettaglio (cfr. Tab. 4) la somma si riduce, senza giustificazione alcuna, di 10 milioni di euro (ed anche qui non vale, data l’entità, il discorso degli arrotondamenti). Se si prende comunque per valida la somma di 556 milioni annui, invece di 566, però il dato di 343,3 milioni di euro relativo all’otto per mille non corrisponde a quanto esposto nella Tab. 3 per l’anno 2008 sotto la voce clero (sostentamento), dove la somma indicata è di 373 milioni di euro, con una differenza quindi di 30 milioni di euro. Ancora una volta i dati sono incerti e non reggono neanche ad una semplice verifica aritmetica. A meno che nei calcoli effettuati non vi siano operazioni non evidenziate o sottintese o piuttosto complesse o non ancora sottoposte a resoconto.
Un dato, anche se imprecisato (non si hanno informazioni chiare e puntuali al riguardo), resta comunque certo: il numero dei contribuenti che sceglie con apposita firma l’attribuzione dell’otto per mille alla Chiesa cattolica non si attesta sulle percentuali complessive fornite ufficialmente e dallo Sato italiano e dalla Chiesa cattolica. Verosimilmente si è ben al di sotto delle percentuali che danno un tasso costantemente superiore all’80%: il numero effettivo delle firme è di qualche decina di punti percentuali in meno, comunque meno della metà (per esempio nel 2004 le dichiarazioni dei redditi sono state 40.316.692, di cui 16.290.418 ovvero il 40,40% avevano una scelta valida relativa all’otto per mille ripartita tra Chiesa Cattolica, Stato, Chiesa evangelica valdese, Unione delle comunità ebraiche italiane, Chiesa evangelica luterana in Italia, Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia). Insomma la Chiesa cattolica in Italia non gode di consensi straripanti, come lascerebbero invece intendere le cifre messe a disposizione ed una loro ulteriore elaborazione.
4. La religione diffusa come religione dei valori
Nel corso degli ultimi due decenni si è constatato che le relazioni fra Chiesa cattolica e Stato italiano – anche se non del tutto scomparse come punto strategico per la verifica del legame interistituzionale a carattere politico e religioso, fondato sull’interesse dei cittadini per i problemi di natura legislativa (si pensi alla diatriba degli anni ’70 ed ’80 sul divorzio e sull’aborto, per nulla paragonabile a quella attuale sul finanziamento pubblico delle scuole cattoliche) – non sono più un test di prova per la capacità della religione dominante di influire sulle vicende politiche italiane.
Peraltro il nucleo essenziale della religione cattolica diffusa è rinvenibile proprio nell’insieme di valori che costituiscono la base della condivisione di orientamenti e pratiche che accomunano cattolici e non cattolici, credenti e non credenti, sul medesimo terreno dell’agire in società. Insomma attraverso questa mediazione culturale di valori condivisi passa gran parte delle decisioni operative assunte dai soggetti sociali. L’establishment ecclesiastico resta sullo sfondo. Non c’è più, se mai vi è stata, una stretta accondiscendenza all’ortodossia ed all’ortoprassi insegnate dalla chiesa cattolica, eppure il parametro essenziale resta il cattolicesimo come ideologia di orientamento.
La religione diffusa oggi in Italia non sembra accentuatamente diversa da quella di un quindicennio fa. Anzi proprio la sua persistenza ne costituisce una caratteristica peculiare. Se qualcosa è cambiato ciò è avvenuto a livello secondario, in aspetti di dettaglio e non di sostanza. Dunque la religione diffusa continua ad essere il risultato di una vasta azione di socializzazione religiosa che pervade anche tuttora la realtà italiana e non solo. Come spiegare altrimenti la tenuta massmediatica di un personaggio come il papa (anche indipendentemente dal suo carisma personale)? Il carattere di religione diffusa resta perché nasce comunque dalla religione, è intriso fortemente di religione e non è certo un fenomeno anticattolico, come del resto non è antireligioso neppure negli altri contesti in cui una religione è dominante e risulta diffusa (nel caso dell’islam o dell’induismo, dello scintoismo o del buddismo).
Solitamente l’appartenente alla religione diffusa è poco praticante e poco attento agli insegnamenti direttamente legati a conseguenze pratiche immediate più che ad orientamenti di massima.
Inoltre nel caso italiano va pure considerato che appunto la presenza del riferimento al cattolicesimo, rintracciabile pure nei discorsi degli uomini politici, è la riprova dell’esistenza di una religione il cui peso non sfugge certo a quanti sono alla ricerca di leve potenti per accrescere il loro consenso politico-elettorale. Invero la religione diffusa può essere soggetta a strumentalizzazioni facili giacché il richiamo a valori religiosi ha sempre un suo fascino, un suo appeal. Più che di termini biblici, infatti, alcuni esponenti politici fanno uso di richiami semplici, usuali: Padre Pio come il papa, una Madonna protettrice di un luogo o un santo ritenuto grande taumaturgo.
E così allora non è molto facile distinguere fra religione diffusa e religione dei valori: la prima è inclusa nella seconda, che abbraccia un più largo settore della popolazione caratterizzata da diversi livelli di credenza. Le contingenze politiche e soprattutto i risultati elettorali non si spiegano solo con gli appoggi confessionali o con i rinvii a tematiche religiose: molti e complessi fattori interferiscono, al di là delle apparenze e dei pronunciamenti religiosi ufficiali e/o privati.
Indubbiamente la presenza di valori è una costante delle religioni storiche, più radicate a livello culturale. Tali valori rappresentano dei motivi ideali, dei concetti-guida, delle idee di base, dei parametri di riferimento, degli orientamenti ideologici, che presiedono all’agire personale ed interpersonale degli individui, lo rendono plausibile, socialmente collocabile, sociologicamente classificabile.
Orbene, ogni esperienza religiosa comporta una dedizione ad una causa, ad un ideale, con un coinvolgimento socio-individuale più o meno accentuato secondo le intenzionalità dei singoli, la loro convenienza (anche in termini di rational choice ovvero di opzione ragionata), la loro storia biografica, le occasioni presentatesi, gli incontri avuti, le prove affrontate. Il dirsi appartenenti ad una certa religione significa essenzialmente condividerne i principi di massima, le opzioni di fondo, le modalità rituali. Queste ultime consentono una visibilità delle appartenenze, l’incontro con i correligionari, la legittimazione dei ruoli operativi (e di potere, non solo simbolico), il rinforzo dell’adesione, l’approfondimento delle motivazioni valoriali.
Molto si deve indubbiamente alla socializzazione, in verità più alla primaria (essenzialmente familiare) che alla secondaria (scolastica ed amicale nell’ambito dei gruppi di soggetti aventi pari età). In effetti la costruzione sociale della realtà è la base da cui si dipartono le ramificazioni costitutive dell’impianto valoriale che presiede all’agire sociale, facendo leva su una concezione del mondo oggettivata e storicizzata e perciò dotata di un carattere religioso dal quale non è facile prescindere. Lo stesso significato ultimo della vita vi si inscrive a chiare lettere ed orienta atteggiamenti e comportamenti.
Intanto è ampiamente dimostrata la connessione fra valori religiosi cattolici e valori diffusi in ambito sociale. In molti casi vi è sovrapposizione fra gli uni e gli altri, se non proprio una totale identificazione. A dire il vero, partendo dal concetto di “religione diffusa” in riferimento soprattutto ai legami con la dimensione politica, si approda poi ad una concezione della religione presente in Italia come intessuta di elementi valoriali derivati direttamente dal bagaglio della socializzazione cattolica.
Innanzitutto resta tuttora valida l’affermazione che la religione diffusa investe larghi strati della popolazione italiana. Più di un’indagine ha consolidato nel tempo questa convinzione, che via via si è arricchita di nuove variazioni sul tema ma senza stravolgimenti. Di per sé anche la cosiddetta religione di chiesa sarebbe parte fondamentale all’origine della stessa religione diffusa. Ma per ragioni esplicative e per evitare equivoci è preferibile considerarla come una categoria a parte, a sua volta scomponibile al suo interno in base a differenze attitudinali e comportamentali dei soggetti intervistati (di solito raggruppati insieme secondo stratificazioni suggerite dalla cluster analysis che aggrega gruppi di individui con caratteristiche simili). Peraltro la diversificazione della religione diffusa rispetto alla religione cattolica istituzionale appare necessaria in chiave sociologica al fine di accertare i punti discriminanti fra modalità ortodosse ed eterodosse rispetto al modello ufficiale cattolico.
Ma l’aspetto più rilevante resta il forte radicamento storico-geografico e quindi culturale della religione più praticata in Italia. Appunto la forza della tradizione, la prassi dell’abitudine, il coinvolgimento familiare e comunitario rendono cogente, quasi imprescindibile l’appartenenza alla religione prevalente. Ove non arriva la socializzazione tra le mura domestiche sopraggiunge l’attività pastorale ed evangelizzatrice svolta capillarmente sul territorio da parte di sacerdoti e collaboratori laici parrocchiali[8].
In effetti il cattolicesimo è diffuso in ogni parte del paese ad opera di una struttura di Chiesa ben attrezzata da tempo e particolarmente capace di far ricorso ad un suo know how. Dell’efficacia di tali azioni la prova migliore è data dal facile proselitismo messo in atto da altri gruppi e movimenti religiosi, sopraggiunti in Italia, primi fra tutti quelli di marca cristiana (ma non solo). Un altro riscontro è rinvenibile nelle propensioni etiche e, specie nel passato, politiche.
Questi caratteri della religione diffusa ne fanno un’esperienza non autocratica, aperta verso altre soluzioni, poco attenta ai confini teologico-dottrinali fra appartenenze confessionali molteplici. I soggetti della religione diffusa sono poco propensi ad intraprendere battaglie in nome dei loro ideali di riferimento ma neppure avversano gli altri per l’espressione di punti di vista non sempre condivisibili.
La religione diffusa potrebbe anche essere classificata come una “religione invisibile”[9] sui generis, ma in realtà essa presenta la peculiarità di rifarsi in parte alla religione di chiesa, attraverso la partecipazione alle pratiche liturgiche ed ai riti religiosi, ed in parte ad una “semiappartenenza” o persino non appartenenza (nelle sue forme più periferiche, quasi confinanti con l’assenza totale di indicatori religiosi)[10].
Nonostante la sua pervasività la religione diffusa non è però presente in ogni caso ed in ogni contesto. Infatti non è agevolmente catalogabile secondo indicatori omogenei. Di solito la cluster analysis delinea tre livelli di religione diffusa: il primo appare più vicino alla religione di chiesa, il secondo se ne discosta parzialmente, il terzo si colloca ai margini del continuum fra religione di chiesa e religione diffusa.
Se si guarda in particolare alla collocazione politica tutto l’arco ideologico-partitico ha i suoi seguaci distribuiti nelle tre grandi aree della religione diffusa. L’appartenente alle classi della religione diffusa preferisce soluzioni che vanno dalla destra all’estrema sinistra, con esclusione dunque dell’estrema destra.
Sul piano dei valori sembra restringersi l’area di quelli strettamente religiosi, ma è in aumento quella dei criteri valoriali laici però vagamente ispirati od ispirabili a modelli religiosi.
Anni fa era già stato posto il problema del mutamento all’interno della stessa religione diffusa. Il fatto è che mentre mutano, quasi impercettibilmente, i contenuti della religione diffusa anche l’approccio sociologico si modifica, mette a punto i suoi strumenti di analisi empirica, scava più a fondo nella realtà e cerca verifiche o falsifiche delle ipotesi-guida.
Invero sino alla fine degli anni ’80, non si disponeva ancora – stranamente – di risultati scientifici abbastanza affidabili e frutto di indagini serie, complete e realmente rappresentative in relazione all’intero territorio italiano. Fu dunque anche sulla scorta degli interrogativi sollevati dalla teorizzazione sulla religione diffusa che iniziò una stagione fertile di ricerche sul campo: dall’inchiesta siciliana su La religione dei valori[11] alla già citata indagine nazionale su La religiosità in Italia[12], a quella a carattere internazionale e con una comparazione fra Europa e Stati Uniti su Religious and moral pluralism[13].
5. La geografia socio-religiosa dell’Italia
In attesa di una nuova indagine a carattere nazionale sulla religiosità in Italia, conviene far riferimento a qualche più recente studio[14] che offra alla considerazione dei sociologi alcuni dati dotati almeno del pregio di una certa affidabilità, in quanto elaborati a partire, nel caso specifico, dalle indagini aventi un carattere “multiscopo” condotte sulle famiglie italiane da parte dell’Istituto Centrale di Statistica, nel periodo 1993-2009.
Roberto Cartocci non è nuovo a nutrire interessi per il fatto religioso in Italia. Già in precedenza aveva collaborato, in particolare sul tema dei valori, con Carlo Tullio-Altan [15], il quale aveva rilevato la presenza di «giovani serissimi, anche se poco loquaci, pieni di fede e di convinzione nelle istanze di valore che loro si dischiudono»[16] ed in altra sede aveva aggiunto che «le idee, le credenze, i pregiudizi, le norme di vita che fanno parte di una cultura, quando si traducono in concreti comportamenti, cessano di appartenere al puro regno dei simboli e dei concetti, e si fanno “cose” e cose di eccezionale durezza e consistenza, con le quali bisogna fare i conti come con la più feroce realtà»[17].
In vari lavori di Cartocci vengono usati concetti-chiave di natura geografica: territori, zone, città, atlante, mappe, ecc.. Nel 2011, come autore unico, ha pubblicato un testo di geografia statistica dell’Italia religiosa[18], il quale pur presentando qualche dato che meriterebbe maggiori approfondimenti nondimeno rappresenta un ulteriore punto di vista sulla situazione attuale e dunque merita adeguata discussione.
Si prendano due elementi in qualche modo correlati: il declino della pratica religiosa e l’aumento dei matrimoni civili. Entrambi sarebbero da attribuire al processo di secolarizzazione in atto. Ma intanto è già dubbia la percentuale, registrata nel 2009, di una pratica religiosa almeno settimanale da parte del 32,5%, contrapposta ad una totale assenza di frequenza ai riti domenicali da parte del 19,1%. La diminuzione sarebbe avvenuta in misura significativa rispetto al 1995 allorquando era del 38,1%. Intanto altre indagini provano che i tassi di frequenza sono ben diversi, in entrambi i casi: è stato documentato nell’indagine nazionale sulla religiosità – i cui esiti sono stati resi noti appunto nel 1995[19] – che i praticanti regolari settimanali erano quasi il 31%. Che tale risultato possa essere cambiato sostanzialmente e persino aumentato, dopo quattordici anni, non pare verosimilmente fondato, perché sarebbe in contraddizione palese con gli esiti di varie altre indagini svolte nel frattempo. Ed anche il tasso di non frequenza assoluta della messa appare alto rispetto a percentuali più contenute accertate nel 1995 che presentavano quasi una decina di punti in meno.
Non va dimenticato infine che da parte degli intervistati c’è di solito una tendenza (data abbastanza per scontata fra gli specialisti del settore socio-religioso) per cui si afferma di fare molto di più di quello che realmente si fa: per esempio si dice di andare a messa ogni domenica ma in realtà la frequenza è di una volta in un mese.
L’aumento delle coppie di fatto passate dal 3,5% al 5,5% in dieci anni non si lega, peraltro, necessariamente alla secolarizzazione: possono essere mutati i costumi relazionali, vi possono essere ragioni economiche ed occupazionali (o, meglio, di mancata occupazione), può interferire un modello giovanile diverso da quello in voga in precedenza. Insomma la scelta civile, invece che religiosa, in campo matrimoniale non vuol dire necessariamente un’opzione antireligiosa o atea o indifferente.
Cartocci, inoltre, parla di un «cattolicesimo di maggioranza» che attingerebbe circa metà della popolazione. Una tale percentuale di poco più del 50% ricorda da vicino un’altra categoria, assai criticata, usata da don Silvano Burgalassi nel 1970[20]: quella dell’indifferenza, ammontante al 55% della popolazione. In entrambi i casi le categorie appaiono troppo ampie e troppo onnicomprensive. Chi fa indagini con l’approccio della cluster analysis sa bene che gruppi così numerosi presentano in genere delle diversificazioni al loro interno, tali da rendere necessaria un’ulteriore procedura almeno di dicotomizzazione dell’insieme qualificato «di maggioranza» o «indifferente».
La minoranza, sempre per Cartocci, sarebbe rappresentata dai cattolici militanti, nella misura del dieci per cento. Anche in questo caso l’esperienza di ricerca sul campo fa propendere per altre quantificazioni: se per esempio è vero che l’associazionismo a carattere religioso riguarda circa l’8% della popolazione non è detto che la militanza cattolica si limiti a questo. Ed anzi la stessa pratica religiosa regolare domenicale è appena un indicatore fra gli altri.
Insomma occorre fare i conti con altre evidenze: sei su dieci matrimoni avvengono in chiesa, otto bimbi su dieci nascono a matrimonio avvenuto, l’otto per mille per la Chiesa cattolica non è plebiscitario ma ha pur sempre una sua consistenza (massima in Puglia e minima in Emilia-Romagna), una larga maggioranza degli alunni opta per l’insegnamento scolastico della religione (coloro che non si avvalgono sarebbero l’8,8%, cioè una percentuale abbastanza vicina a quella dei non praticanti in assoluto già nota dal 1995[21]).
Fra l’altro il docente bolognese si avvale pure dello studio di Garelli sull’Italia cattolica[22], in cui l’associazionismo, compreso quello nella Caritas e nella pastorale parrocchiale, risulta attestato sul 10% («cattolici militanti»), ma in aggiunta si segnala tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti che comprendono il 20% di persone («cattolicesimo di minoranza») che vanno regolarmente a messa la domenica, quelle assai più numerose (attorno al 50%, «cattolicesimo di maggioranza») la cui pratica è saltuaria, quelle infine (circa il 10%) che non praticano ma firmano a favore dell’otto per mille destinandolo alla Chiesa cattolica ed optano per l’insegnamento della religione cattolica da impartire ai loro figli. La quota rimanente (ancora 10%) è fatta di soggetti indifferenti, agnostici, atei, anticlericali, non cattolici in generale. Quest’ultima categoria risulta ancora una volta piuttosto generica. Sarebbe auspicabile un’adeguata indagine ad hoc, per comprendere meglio le dinamiche in atto nel variegato mondo che non si richiama alla Chiesa cattolica.
In definitiva nella visione prospettica di Cartocci appaiono un po’ troppo ampia la categoria maggioritaria e, di converso, un po’ troppo ristretta quella minoritaria (a dire il vero, Cartocci più volte ha insistito, nel corso dei suoi studi, sull’idea di bipolarismo[23] applicata al caso italiano, fino a distinguere anche fra un nord laico ed un nord cattolico[24], memore forse della lezione di Tullio-Altan, il quale nella sua ricerca sui «valori difficili»[25] aveva parlato di valori in contrapposizione, di dualismo non solo generazionale ma anche geografico, con orientamenti più tradizionalistici nel sud).
Il dato di fatto è che la credenza e la pratica di matrice cattolica non sono limitate a circa un terzo della popolazione italiana. E comunque se è vero che c’è una tendenziale compattezza dei cattolici è altresì un dato di fatto la loro diversificazione su temi politici, etici, comportamentali, ideologici. D’altra parte anche il numero dei non praticanti in assoluto va forse ridimensionato, come si è già detto, più verso il 10% che non il 15% od anche più.
Andrebbero poi enfatizzate alcune dimensioni storico-culturali, come nel caso dell’alta frequenza religiosa in Campania e dei matrimoni religiosi tra i palermitani. Da anni gli studiosi di sociologia della religione, specialmente coloro che hanno condotto ricerche in Campania ed in Sicilia, vanno sostenendo che in tali contesti il frequentare la chiesa ogni domenica è essenzialmente un tratto culturale ben radicato, che travalica la sostanza stessa della motivazione religiosa (lo stesso discorso vale per la celebrazione del matrimonio religioso). A proposito di quest’ultimo il differenziarsi dei dati, nel tempo, fra Napoli e Milano è dovuto probabilmente non ad un’inversione di tendenza ma ad una diversa velocità di diffusione di una prassi, anche a seguito dell’approvazione della legge sul divorzio, a partire dunque dagli anni ‘70. Così il fatto che a Napoli nel 1951 i matrimoni civili toccassero il 17,7% ed a Milano il 5,4% era dovuto, a pochi anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, a ragioni forse di natura economica (il matrimonio in chiesa e la successiva offerta di convivialità potevano costare assai più di una semplice celebrazione in municipio, magari neppure seguita dal pranzo di nozze). Comunque all’epoca non era ancora così accentuato il divario socio-economico fra le due metropoli, entrambe reduci dal disastro bellico. Successivamente lo sviluppo industriale milanese e le abituali difficoltà di tenuta economica nella città partenopea hanno fatto sì che si amplificasse la differenza fra le due città, anche in termini di modernizzazione delle rispettive culture urbane, per cui Milano potrebbe aver subito una maggiore accelerazione in fatto di costume e modelli comportamentali mentre Napoli potrebbe aver mantenuto la tendenza già in atto (infatti i matrimoni civili sono comunque aumentati fino al 26,3% di tutti i matrimoni; invece a Milano il mutamento è stato maggiore, anche in questo campo, ed ha portato la celebrazione civile delle nozze a costituire il 57,6% del totale; insomma Napoli è giunta ad avere un matrimonio civile ogni quattro e nel contempo Milano è passata a nozze civili più frequenti, cioè oltre la metà di tutte quelle celebrate). Nondimeno la questione resta aperta, dato che l’autore con rara umiltà scientifica dichiara l’impossibilità di riuscire a spiegare il caso napoletano: «chi scrive non è in grado di dare una spiegazione di questo crollo dei matrimoni civili nel comune di Napoli»[26].
Ancora lo stesso Cartocci sottolinea che un certo livello di mancato sviluppo va di pari passo con una maggiore, più intensa pratica religiosa (per esemplificare: nel sud, religiosamente più osservante, non si fa la raccolta differenziata dei rifiuti e quando occorre si fa ricorso agli ospedali settentrionali). E d’altro canto la religiosità parrocchiale tradizionale del meridione non mostrerebbe una particolare capacità nel contrastare l’illegalità, il degrado, la corruzione.
Qui però il discorso si fa ancora più complicato, perché rischia di prescindere da dati di contesto, e di tipo storico e di tipo culturale. Tornano utili dunque le parole, ancora una volta, di Carlo Tullio-Altan: «una certa mentalità pubblica è il prodotto di una combinazione storica di fattori economici, sociali, politici, e specificamente culturali, combinazione nella quale tale mentalità prende forma, in armonia e in relazione alle esigenze che quella combinazione stessa globalmente esprime. Ma una volta formatasi, e consolidatasi in una certa guisa, tale mentalità diviene una realtà vischiosa e resistente, che sopravvive alle condizioni che l’hanno generata, e agisce a sua volta come uno dei fattori rilevanti, sugli eventi successivi, economici, sociali e politici»[27].
Non va dimenticato peraltro che in Italia la ruralità ha ancora un suo peso nel mantenimento delle tradizioni consolidate e che la realtà territoriale è fatta in buona parte proprio di piccoli agglomerati residenziali (molti comuni rurali e meridionali sono al di sotto di mille abitanti).
Sono poi ben note nel sud le ambiguità delle relazioni Chiesa-mafia ma altrettanto note sono le lotte condotte in proposito da alcuni esponenti della Chiesa cattolica[28].
La propensione di Cartocci a dividere la fenomenologia religiosa in due soli aspetti o quasi si applica non solo alla relazione fra praticanti e non praticanti, come pure fra matrimoni civili e religiosi, ma investe l’intera realtà italiana che parrebbe più secolarizzata al centro-nord che non al centro-sud, dove perdurerebbe la religiosità di tipo tradizionale.
Anche gli indicatori della scelta dell’insegnamento della religione a scuola e della firma dell’otto per mille a favore della Chiesa cattolica paiono rientrare nella medesima logica bipartitoria. Ed allora la non scelta scolastica della religione riguarda più il nord che il sud in ogni ordine e grado. Pure l’assenza di firme per l’otto per mille a favore della Chiesa cattolica è più frequente nel settentrione (specie in Emilia e Romagna) che nel meridione (dove Calabria, Campania e Sicilia contribuiscono con la quasi totalità delle firme per la Chiesa cattolica).
Particolarmente utile è la tabella 7.1 predisposta da Cartocci[29] sulle scelte dell’otto per mille. I dati provengono da Monsignor Mauro Rivella, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, e si riferiscono al 2004. Un’ulteriore elaborazione della tabella offre un quadro più dettagliato sulla ripartizione delle firme, anche in termini percentuali effettivi.
Tab. 5
FIRME E SCELTE VALIDE DELL’OTTO PER MILLE NEL 2004
| Destinatario | Dichiarazioni I.R.PE.F. presentate | Firme considerate come scelte valide | % delle firme considerate come scelte valide sul totale delle dichiarazioni presentate | % delle quote assegnate sul totale dell’otto per mille |
| Chiesa Cattolica | 14.628.795 | 36,28,4468 | 89,8 | |
| Stato | 1.254.362 | 3,11,1251 | 7,7 | |
| Chiesa evangelica valdese | 228.066 | 0,57,5683 | 1,4 | |
| Unione delle comunità ebraiche italiane | 65.162 | 0,16,1624 | 0,4 | |
| Chiesa evangelica luterana in Italia | 48.871 | 0,12,1217 | 0,3 | |
| Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno | 32.581 | 0,08,0812 | 0,2 | |
| Assemblee di Dio in Italia | 32.581 | 0,08,0812 | 0,2 | |
| Totale | 40.316.962 | 16.290.418 (16.480.730*) | 40,4 | 100,0 |
* comprese 190.312 scelte non valide
In conclusione la maggioranza dei contribuenti italiani non ha preso affatto in considerazione la possibilità di scelta offerta con l’otto per mille ma in pratica ha favorito sensibilmente i destinatari cui non avrebbe voluto assegnare alcuna somma: sono 23.836.232 i soggetti che non hanno fatto alcuna opzione sull’otto per mille e costituiscono più della metà (59,12%) dei dichiaranti l’imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.Pe.F.). .
Per Cartocci, dopo aver riconosciuto che «la tradizione cattolica appare così come il collante più antico, il tratto più solido di continuità fra le diverse componenti del paese»[30], segnatamente l’azione esercitata dal Regno delle Due Sicilie non sarebbe estranea alla religiosità più tradizionale e stabile rintracciabile nel meridione italiano. L’ipotesi potrebbe avere qualche fondamento, ma occorre considerare che la Sardegna non rientrerebbe nel discorso formulato, nonostante sia poco secolarizzata, stando agli indicatori sociologici utilizzati dallo studioso fiorentino. D’altro canto per la maggiore secolarizzazione del centro-nord si potrebbe pensare alla presenza del socialismo e del comunismo come pure di varie forme di laicismo. Ma pure in questo caso giova ricordare invece la forte presenza dello Stato della Chiesa in vasti territori dell’Italia centrale (e non solo). Come combinare influenze così diverse? La storia invero ha tracciati assai lunghi, che travalicano i secoli e che si combinano in modo assai differenziato con le situazioni con cui entrano in contatto.
A completamento del discorso il politologo dell’Università di Bologna riconosce che «in Italia esiste una rete di diocesi e parrocchie senza paragoni rispetto a tutti gli altri paesi cattolici, una presenza istituzionale che non è minimamente avvicinata da nessun’altra organizzazione, a parte lo stato. Sul piano dei comportamenti si registrano poi tassi di religiosità più elevati della maggior parte degli altri paesi»[31]. Appunto questa capillarità e reticolarità della Chiesa cattolica italiana consente di verificare la presenza di forti dosi di religiosità anche in aree del nord ritenute piuttosto secolarizzate, ma altresì un basso livello di religiosità e di pratica religiosa pure in qualche enclave del sud e delle isole.
Se però lo strumento statistico viene adoperato per classificare le differenziazioni territoriali (come fa Cartocci per regioni e province) esso mostra abbastanza la corda perché basato su pochi indicatori (appena quattro: pratica religiosa festiva, matrimoni ed unioni di fatto, insegnamento della religione ed otto per mille). E dunque c’è da chiedersi quanto possa aiutare il rating fondato su basi non particolarmente solide, visto che il fenomeno religioso è ben più articolato delle quattro componenti analizzate da Cartocci. Oltretutto la classifica per province e per regioni non fa altro che confermare talune interpretazioni ed elaborazioni statistico-sociologiche ampiamente acquisite da tempo e quindi non segnala particolari sorprese: il laicismo dell’Emilia-Romagna come la bassa frequenza della messa a Siena (già studiata da Silvano Burgalassi molti anni fa, nell’ambito delle ricerche sulla Toscana[32]).
Entrando nel merito, Cartocci giustamente mette in guardia rispetto a facili conclusioni che assimilerebbero la religiosità meridionale allo scarso sviluppo socio-economico e dunque respinge l’ipotesi della «variante anticlericale» che vede nella Chiesa cattolica l’origine del mancato sviluppo[33].
Un’altra suggestione da ritenere foriera di sviluppi futuri nella campo della ricerca socio-religiosa sul cattolicesimo italiano deriva dall’individuare una categoria di individui pienamente secolarizzati o indifferenti o anticlericali o appartenenti ad altre confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica: sono il 10% e rappresentano il cerchio più lontano dal mondo cattolico[34].
In definitiva «il 60% delle coppie si sposa in chiesa, i bambini nascono per l’80% dopo il matrimonio, il 90% sceglie la chiesa come destinazione dell’otto per mille, il 91% degli scolari frequenta le lezioni di religione nelle scuole. Coloro che non mettono piede in chiesa sono meno del 20% degli italiani. E comunque, anche tra questi, una buona metà ha più fiducia nella chiesa che nello stato, quanto meno come istituzione educativa e di carità»[35]. Queste affermazioni sono certo fondate sui dati ma in qualche caso anche discutibili, a partire dal 90% che sceglie la Chiesa nell’otto per mille (la consistenza reale è del 36,28% in rapporto al numero totale dei contribuenti dell’I.R.Pe.F.).
Semmai è da tenere presente anche quanto ha sostenuto Giancarlo Zizola, commentando il lavoro di Cartocci: «la Chiesa che affiora da questi grafici è una grande e gloriosa istituzione fortemente stanca e assopita sulla propria potenza burocratica, ma che è coinvolta suo malgrado in un processo di mutazione storica dovuta più ancora ai cambiamenti sociologici e culturali che ai problemi interni dell’istituzione»[36].
Infine non va trascurata l’acculturazione degli immigrati di matrice cattolica giunti nel nostro paese e inseriti a vario titolo nelle attività della Chiesa cattolica italiana. Ne parla precipuamente Enzo Pace[37] segnalando la presenza di 40.000 filippini a Roma, 30.000 a Milano, 20.000 a Torino. In molti casi essi operano a pieno titolo nelle parrocchie.
6. La preghiera come forma religiosa non istituzionale
In Italia è stato soprattutto Franco Garelli[38] ad evidenziare il ruolo del sentire religioso fra tensione spirituale ed espressione religiosa, esaminando i risultati di un’inchiesta sul pluralismo, statisticamente rappresentativa a livello nazionale. In merito alla «coscienza di essere una persona religiosa e percezione di avere una vita spirituale» vengono individuate sette categorie: l’ateo/agnosticismo cioè né religiosità né spiritualità (12,3%), la religiosità etnico/culturale cioè medio-alta religiosità e scarsa-nessuna spiritualità (17,3%), la spiritualità critica cioè scarsa-nessuna religiosità e medio-alta spiritualità (8,8%), la credenza debole cioè religiosità media e spiritualità media (23%), la religiosità maggiore della spiritualità cioè alta religiosità e media spiritualità (10,3%), la spiritualità maggiore della religiosità cioè alta spiritualità e media religiosità (9,5%) ed infine la fedeltà cioè alta religiosità ed alta spiritualità (18,8%).
Da tale scenario risulta che «a) In primo luogo, il termine religiosità desta nella popolazione più consensi del termine spiritualità, in quanto sono più numerose le persone che si definiscono religiose di quelle che ritengono di avere una vita spirituale. […] b) Tra i vari tipi di religiosità individuati quello della spiritualità critica desta particolare interesse, sia per l’orientamento culturale sotteso sia per i soggetti che più lo esprimono. […] c) Sulle due dimensioni qui rilevate (religiosità e spiritualità) quanti esprimono posizioni di marcata congruenza ammontano a circa il 50% della popolazione, mentre il 26% dei casi palesa un atteggiamento di sensibile incongruenza. […] d) In margine a quanto rilevato, si può ancora notare che la quasi totalità della popolazione riconosce il significato di termini quali religiosità e spiritualità ed è in grado di definire il proprio grado di coinvolgimento in queste due dimensioni»[39].
Inoltre il peso del contesto socio-culturale appare evidente dal dato relativo all’apporto dell’insegnamento scolastico della religione cattolica ai fini dell’alfabetizzazione religiosa, in quanto l’ora di religione nelle scuole fa «incrementare i livelli di conoscenza dei gruppi con minori occasioni di conoscere la religione cattolica, rispetto ai livelli manifestati dai gruppi che dispongono di un maggior numero di fonti di socializzazione a ciò orientate. Le conoscenze specifiche proposte dall’Insegnamento della Religione Cattolica ‘arrivano’ infatti ai ragazzi in proporzione maggiore delle conoscenze religiose generali. L’insegnamento sembrerebbe dunque effettivamente in grado di ridurre in una certa misura le differenze nei livelli di alfabetizzazione che la socializzazione extrascolastica determina»[40].
Non è senza significato che sin dall’indagine nazionale sulla religiosità in Italia si sia accertato che «gli italiani di 18-74 anni che dichiarano di aver pregato almeno qualche volta durante l’anno sono l’83%. Pregano anche i non credenti, soprattutto se sono in un atteggiamento di ricerca (49%) e coloro che credono in un essere supremo ma non appartengono ad una specifica religione (44%). Perfino tra coloro che si dichiarano atei c’è una quota, seppur piccola (8%), che prega»[41].
Le motivazioni della preghiera ripercorrono puntualmente la tipologia classica che annovera la categoria del misticismo (ricerca di relazione con la divinità: 44%), quella dell’impetrazione-perorazione per ottenere un sostegno nei momenti di difficoltà (44%), quella mista che vede insieme il desiderio di rapporto con Dio e la richiesta di un suo intervento, quella di ringraziamento (circa il 25%) che contempla sia la gratitudine che il pentimento per qualche colpa, quella fatta per tradizione ovvero per insegnamento ricevuto, quella dovuta ad una ricerca personale ed infine quella per domandare grazie (che sarebbe la meno frequente in Italia: 10%).
Le conclusioni sono che la preghiera «sia una modalità di espressione del proprio sentimento religioso ancora saldamente radicata e quindi destinata a permanere nel tempo, anche se circoscritta ad una minoranza della popolazione»[42].
Tale carattere minoritario previsto per il futuro non presenta ancora indicatori consolidati. Ma è anche vero che «le generazioni a noi più vicine e le persone più istruite rifuggono da comportamenti ascrittivi (pregare perché è un dovere o perché così è stato insegnato loro) e privilegiano più degli altri intervistati la forma di preghiera che forse meglio si addice all’uomo contemporaneo: quella intenzionata a far chiarezza dentro di sé»[43].
Senza soluzione di continuità anche ricerche successive sono rimaste nella medesima linea ed hanno confermato i modi tipici del pregare: come ringraziamento, come pentimento; privato-individuale-separato/pubblico-collettivo-unito; orale-detto/silente-mentale; laudativo/perorativo; fiducioso/supplice; spontaneo/fondato su testi.
Nonostante questa ampiezza di possibilità non è detto che vi sia sempre consapevolezza da parte dei soggetti intervistati. Per esempio nell’arcidiocesi urbinate la preghiera è posta al sesto posto fra le azioni da privilegiare da parte di un credente: la predilige appena l’11% dei rispondenti[44]. Ma quando si passa alla domanda sulla frequenza della preghiera risulta che il 10,4% prega ogni giorno, il 31,3% circa una volta al giorno, il 15% qualche volta la settimana, il 10% qualche volta in un mese, l’11,7% qualche volta durante l’anno ed il 21,6% mai. E giustamente si osserva preliminarmente che «l’importanza di analizzare la preghiera esercitata al di fuori dei riti religiosi deriva dal fatto che tale comportamento è presente in tutte le religioni e spesso riguarda anche chi si dichiara non credente»[45]. Ma è opportuno sottolineare il fatto che «gli intervistati, per la maggior parte, quando pregano utilizzano le tradizionali formule di preghiera trasmesse attraverso il processo di socializzazione religiosa e ascoltate frequentando i vari riti e culti»[46].
Pure fra i giovani l’influenza della socializzazione religiosa pregressa rimane: se il 30% non prega mai, il 26% lo fa una o più volte al giorno, il 16,2% una o più volte ogni settimana ed il 13,4% qualche volta in un mese[47]. «Le modalità della preghiera riguardano principalmente la recita di formule conosciute (59,2%), stando in silenzio, in ascolto o in contemplazione (25%), ma anche riflettendo sulla propria vita e su quanto capita intorno a noi (50%), o attraverso l’uso di parole o espressioni proprie (50%). I giovani, rispetto al totale, privilegiano maggiormente la preghiera personale e la ricerca interiore»[48].
Altresì nel teatino-vastese la preghiera dei giovani presenta tassi cospicui: il 27,56% prega spesso, il 41,99% talvolta, il 20,21% raramente ed il 9,97% mai[49]. Ma «essi sembrano poco inclini, se non per quella quota peraltro non trascurabile che si individua come il nucleo dei ‘ferventi’, ad utilizzare modalità ritualizzate e tradizionali»[50]. I giovani interpellati preferiscono «comunicazione, contatto con Dio» (27,75%), «dialogo con Dio, con i Santi, con i defunti» (14%), «riflessione e meditazione personale»» (12,25%), «vicinanza con dio» (11,5%). Da notare, fra questi dati[51], la presenza dei defunti come destinatari della preghiera, anche se la domanda posta mettendo insieme pure Dio ed i Santi non consente poi di discernere quale peso abbia nella risposta la parte relativa ai defunti. Da ultimo è da prendere in considerazione il modo del pregare: il 29,66% usa parole sue, il 23,36% frasi e formule di preghiera tradizionali, il 19,95% riflette sulla sua vita ed il 13,39% dialoga interiormente con Dio[52].
In un’inchiesta effettata nel Basso Lazio[53] (Meglio 2010: 104), i giovani dicono di rivolgersi alla propria fede nei momenti difficili, in misura differenziata: sempre il 29,3%, spesso il 28,7%, qualche volta il 32,2%, mai il 9,8%. Non c’è un esplicito riferimento alla preghiera ma tale elemento appare sottinteso, anche perché la stratificazione dell’intensità del comportamento corrisponde in linea di massima a quanto già rilevato, appunto in relazione alla preghiera giovanile.
Nella diocesi di Oristano in Sardegna[54] la preghiera personale occupa un posto non trascurabile perché la frequenza rilevata è «spesso (tutti i giorni o quasi)» nella misura del 45,4%, «qualche volta» per il 34,4% degli intervistati e «mai» per il 20,2% (con una particolare accentuazione nel caso di soggetti maschi). Le medie italiane registrate nel 2009 in un’inchiesta con campione nazionale erano un po’ diverse (rispettivamente 50,8%, 31,9% e 17,3) per cui la popolazione oristanese appare meno religiosa di quella italiana. Nell’ambito delle motivazioni, nondimeno, il sentimento religioso è espresso nei termini seguenti: il 47% prega per sentirsi più vicino a Dio ed una medesima percentuale lo fa per ottenere un supporto nelle difficoltà, mentre il 31% è mosso dal desiderio di lodare e ringraziare Dio ed il 23% per pentirsi e fare penitenza. Il peso dell’insegnamento ricevuto tocca appena l’11% e quello del dovere il 14%, invece la ricerca di chiarezza con se stessi arriva al 18%. Si riduce infine al 10% la motivazione di una domanda di grazie. In definitiva la preghiera strumentale riguarda una quota ridotta della popolazione ma non è destinata a scomparire, visto che fra i giovani essa permane, anche se contenuta entro gli stessi limiti percentuali fatti registrare dall’intero campione dell’indagine.
Provocatoriamente Introvigne e Zoccatelli[55] si chiedono, al termine di uno studio sociologico sulla diocesi siciliana di Piazza Armerina, se la messa non sia finita, se cioè la pratica religiosa cattolica più emblematica, quella dei giorni festivi, non sia destinata a ridursi se non proprio a scomparire. Un punto qualificante del tentativo di Introvigne e Zoccatelli è la verifica della differenza intercorrente fra le dichiarazioni di pratica e la pratica effettiva, cioè la questione dell’over-reporting. Nel caso in esame la partecipazione al culto festivo (cattolico e non) in modo regolare (una volta o più per ogni settimana) secondo le risposte degli intervistati raggiunge il 33,6%, invece un controllo sul numero effettivo di presenti nei luoghi di culto fa scendere il tasso percentuale al 18,5%. Gli autori fanno tuttavia osservare che «se qualche cosa ‘dimostrano’ le indagini sull’over-reporting compiute negli anni negli Stai Uniti, in Polonia e in Italia è precisamente che la pratica dichiarata è, appunto, ‘dichiarata’: misura un’identità e forse anche un’identificazione, ma non misura fatti e comportamenti»[56]. Dunque non sarebbero da ritenere percentuali probanti né quella del 33,6% né quella del 18,5%, in quanto entrambe sono parziali e non rappresentano adeguatamente l’intero set comportamentale ed attitudinale. Anche in questa inchiesta non si parla esplicitamente della fenomenologia della preghiera ma si può inferire che sia i dati sulla pratica domenicale sia le riflessioni metodologiche sull’over-reporting siano applicabili anche al quadro sociologico relativo alla frequenza della preghiera nella Sicilia Centrale[57] ed altrove.
Ancor più dei dati quantitativi c’è da aspettarsi che siano i risultati qualitativi a fornire corroborazioni sul nesso fra religione diffusa e diffusione della preghiera. Un contributo convincente giunge da uno studio qualitativo sulla spiritualità giovanile. Va segnalato come strategico un paragrafo dedicato a «Davanti alla morte e al dolore»[58], in cui si mostra come «l’evento della morte svolga ancora oggi il suo ruolo antropologico di connessione tra i mondi, obbligando chi vive questo tragico avvenimento a doversi interrogare su ciò che va oltre la vita, e spingendo molti a tirare in ballo Dio nel tentativo di formulare una risposta plausibile. Ciò può succedere a chi pensava di aver chiuso i ponti con la religione»[59]. Ed appunto «attraverso la pratica della preghiera si può entrare in relazione con il radicalmente altro: sentirne l’abbraccio o l’abbandono; si possono esprimere i propri dubbi e le proprie convinzioni sull’esistenza o meno di qualcosa che va oltre l’umano; ci si può riferire all’appartenenza alla propria chiesa o gruppo religioso/ecclesiale con la possibilità di diversificare forme e ruoli del pregare; e infine anche attraverso la preghiera si può ‘esercitare’ la propria conoscenza dei testi sacri. La preghiera rappresenta quindi un punto di potenziale convergenza delle diverse dimensioni della religiosità: la pratica, l’esperienza, la credenza, l’appartenenza e anche la conoscenza»[60]. Seguono poi diversi esempi tratti dai documenti raccolti nel corso dell’indagine qualitativa su 72 giovani vicentini, con la tecnica del focus group. Emblematicamente da una persona intervistata viene riproposta esplicitamente la dimensione ultraterrena come locus di interlocuzione: ella si rivolge a suo nonno defunto perché le riesce più facile, «recuperando ed andando oltre una lunga tradizione che attraversa le religioni»[61]. Ed ovviamente non mancano Dio e santi come interlocutori: la serie di brani estratti dalle diverse dichiarazioni dei giovani è lunga ed articolata e verifica il carattere sociale della preghiera, «tra obbligo e personalizzazione», anche se fatta in privato e nell’intimità[62].
Il quadro d’insieme che scaturisce dalla ricerca vicentina testimonia quale sia l’incidenza della preghiera nell’universo mentale giovanile: essa si colloca al ventottesimo posto (seguita da Vangelo, valori, morte e paura) di una lista di «parole piene di media frequenza» che comincia con «Dio» e termina con «scelte»[63] e nella sua area tematica (settima per numero di frequenze, dopo «figure sacre», «familiari», «messa», «aldilà», «clero» e «chiesa»)[64] rientrano «Atto di dolore, Ave Maria, il credo, Padre nostro, Lodi, pregare, preghiera comunitaria, preghiera di lode, preghiera di ringraziamento, preghiera libera, preghiera mattutina, preghiere della sera, salteri/o, vespri ecc.»[65]. Infine l’analisi delle corrispondenze mette in relazione la preghiera soprattutto con le figure sacre, la Parola ed i sacramenti e, sul piano sociale, con i movimenti[66].
La diffusione della preghiera è essenzialmente frutto dell’azione socializzatrice svolta in Italia dalla Chiesa cattolica con le sue strutture educative e legittimatrici, che perpetuano forme e contenuti della preghiera, lasciando spazio anche ad innovazioni che lungi dall’erodere il patrimonio esistente ne rimotivano e ne riadattano le proposte, a tutto vantaggio di una religione diffusa che si fa forte dell’apporto di intere generazioni del passato le quali hanno conservato nel tempo le testimonianze pregresse.
Non è fuor di luogo potere immaginare che anche le resistenze da parte dei giovani ad usare il capitale culturale pre-esistente risponda – alla lunga – ad un’esigenza di conservazione non garantibile dalle sole strutture operative già in atto. Del resto se anche si prescinde da formule consolidate e da soluzioni già disponibili nondimeno un afflato religioso e spirituale insieme pare mantenere in essere una «abitudine del cuore», per dirla ancora con Rousseau e Bellah[67], dura a morire perché correlata alla morte stessa, con cui si confronta continuamente, attraverso lo schermo-copertura della figura sacra che funge da interlocutore utile, anche se ritenuto fittizio.
In che misura tutto ciò possa trovare conferma anche nel futuro non è facile stabilire a priori.
7. Conclusione
Ancora in assenza di dati più aggiornati ed inequivocabilmente rappresentativi della realtà nazionale italiana, un ulteriore strumento di analisi resta a disposizione: quello dell’osservazione partecipante. Si tratta di un’esperienza quotidiana di presenza diretta nelle attività della Chiesa cattolica italiana, di relazioni interpersonali continue, di insegnamento nelle università statali ed anche in strutture accademiche pontificie, di ricerche teoriche ed empiriche (sovente sul campo), di letture costanti della stampa cattolica quotidiana e periodica, delle riviste d’ispirazione cattolica sia scientifiche che pastorali, della partecipazione a convegni locali, regionali, nazionali ed internazionali organizzati dal mondo cattolico, della frequentazione di accademie religiose, nonché di archivi e biblioteche appartenenti all’organizzazione ecclesiastica, della partecipazione a movimenti ed associazioni d’impronta spirituale.
Tutto ciò rappresenta un osservatorio privilegiato per seguire le strategie in atto, le azioni in corso, le operazioni promosse, i cambiamenti incoraggiati, le resistenze poste in essere, la circolazione di idee ed intenti, le opzioni di volta in volta proposte su diversi piani della realtà sociale. Insomma è la condizione tipica di un testimone privilegiato, che agisce all’interno ma cerca pure di osservare dall’esterno.
Ebbene, sulla scorta di una pluridecennale esperienza di portata nient’affatto secondaria, è possibile tracciare qualche linea guida di analisi globale della situazione attuale della Chiesa cattolica in Italia.
Innanzitutto va detto che si tratta di una struttura primaria, a livello di radicamento sul territorio, di capacità organizzativa spesso a costo zero o quasi, di forza d’impatto nelle azioni educative, formative e socializzatrici, di ramificazione in vari campi dell’intervento sociale, di patrimonio personale, culturale e sociale, di tradizioni, norme comportamentali, valori diffusi e modelli dell’agire individuale e collettivo, di know how nella carità, nell’assistenza, nella cura, nella protezione, nonché di mobilitazione delle masse su obiettivi strategici. Tutto ciò non risulta immediatamente evidente ma alla prova dei fatti si riconoscono conseguenze ed origini.
Rispetto al passato, sono numerosi i laici (cioè i soggetti non istituzionalmente organici e schierati) in grado di dire la propria, di prendere la parola, di assumersi la responsabilità – soprattutto pubblica – su questioni delicate ed incerte.
Sempre più soggetti laici subentrano in ruoli che in passato erano esclusivi del clero. E lo fanno con competenza ed autonomia di giudizio e di azione. Hanno avuto modo di capire forme e contenuti delle attività pastorali e socio-religiose e dunque intervengono a ragion veduta, riuscendo a far giungere il messaggio religioso persino in comparti un tempo lontani e refrattari.
Si tratta di un movimento, quello laicale, ancora minoritario, marginale ed emarginato, ma si notano i prodromi di sviluppi significativi, a mano a mano che vengono occupate e mantenute le posizioni in cui si fanno le scelte decisive.
La crisi delle vocazioni ecclesiastiche non consente al vecchio establishment di tutto preordinare, gestire, sovrintendere e condizionare. Le aree operative sono numerose e talora inarrivabili da parte dei ministri del culto cattolico che dunque si devono affidare al supporto dei laici.
Anche la preparazione teologica dei laici è in crescita. Alcuni di loro hanno metodi e strumenti tali da renderli indipendenti dal ricorso alla consulenza degli ecclesiastici ed anzi tali da metterli pure a confronto diretto, paritario, senza timori reverenziali e con ricchezza di argomenti e prove (specialmente testuali, tratte dai libri sacri). Ciò potrà produrre tra non molto una teologia cattolica laica ben più attrezzata scientificamente e più capace nella dialettica argomentativa.
La stessa crisi delle vocazioni al sacerdozio, riscontrabile non sempre e non dappertutto, non impedisce di far uso di selezioni più attente per quanto concerne i candidati all’esercizio del ministero religioso. Le sfide del mondo moderno e post-moderno richiedono qualità adeguate per affrontare temi e problemi quasi sempre ostici, difficili da capire, condizionati da approcci globali che fanno smarrire il senso dell’appartenenza ad una terra, ad un luogo, ad una collettività. In prospettiva dunque si potrebbe avere un clero meno numeroso, ma più qualificato, più abituato allo studio ed all’approfondimento.
Se la duplice sfida del laicato e del clero avrà risvolti almeno in parte positivi è immaginabile che il ruolo della Chiesa cattolica in Italia non subirà molti contraccolpi nell’immediato futuro.
Roberto Cipriani, Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione (insegnamento di Sociologia), via Milazzo 11b, 00185 Roma, rciprian@uniroma3.it
[1] Cfr. Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, Milano, Mondadori, 1995.
[2] Un utile contributo alla comprensione di quanto è avvenuto nel corso dell’ultimo quindicennio proviene anche dalla storia delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, tracciata da Carlo Felice Casula, il quale – attraverso approfondite interviste a tre presidenti nazionali delle ACLI succedutisi nel periodo in considerazione – fa intravedere quasi in filigrana quella che è l’atmosfera sociale di una serie di anni piuttosto intensi per lo sviluppo economico e culturale del paese, in una chiave che congiunge insieme varie storie: quelle dei partiti e dei sindacati ma anche quelle delle istituzioni civili e religiose: cfr. Carlo Felice Casula, Le ACLI una bella storia italiana, Roma, Anicia, 2008.
[3] Ernesto Galli Della Loggia, Quando il papa non fu più prigioniero, «Il Corriere della Sera», 6 febbraio 2009.
[4] Roberto Cipriani, Laicità e religione nella sfera pubblica, «Rivista lasalliana», 77, 1, gennaio-marzo, 2010, pp. 439-463, in particolare pp. 24-25.
[5] Cfr. Roberto Cipriani, La religione diffusa. Teoria e prassi, Roma, Borla, 1988.
[6] Rosy Bindi, Renzo Guolo e Gian Enrico Rusconi in dialogo con Giancarlo Bosetti, La conversione della Lega, «Reset», Maggio/Giugno 2011, pp. 83-88, in particolare pp. 87-88.
[7] Conferenza Episcopale Italiana, Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, Otto per mille. Destinazione ed impieghi 1990-2009, aprile 2010, p. 10.
[8] Cfr. Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, Bologna, il Mulino, 2011.
[9] Cfr. Thomas Luckmann, La religione invisibile, Bologna, il Mulino, 1969, 1985.
[10] Cfr. Roberto Cipriani, Appartenenza, semiappartenenza, non appartenenza, in: Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, op. cit., pp. 99-152.
[11] Cfr. Roberto Cipriani, La religione dei valori, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1992.
[12] Cfr. Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, op. cit.
[13] Cfr. Franco Garelli, Gustavo Guizzardi, Enzo Pace, Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani,Bologna, il Mulino, 2003.
[14] Cfr. Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit. Cfr. pure Enzo Pace, Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa dell’Italia che cambia, Milano, Paoline, 2011.
[15] Cfr. Carlo Tullio-Altan, I valori difficili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche e politiche dei giovani in Italia, Milano, Bompiani, 1974; Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi, Milano, Feltrinelli, 1986; Carlo Tullio-Altan, Italia: una nazione senza religione civile. Le ragioni di una democrazia incompiuta, presentazione di Roberto Cartocci, Udine, Istituto editoriale veneto friulano, 1995; Carlo Tullio-Altan, La coscienza civile degli italiani. Valori e disvalori nella storia nazionale, Udine, Gaspari, 1997 (collaborazione di Roberto Cartocci, autore del saggio L’Italia di tangentopoli e la crisi del sistema politico); Roberto Cartocci, La banalità dei valori: la riflessione di Tullio-Altan e lo studio della cultura politica, «Metodi e ricerche», XXIV, 2, luglio-dicembre 2005, pp. 3-23; Roberto Cartocci, Chi ha paura dei valori? Capitale sociale e dintorni, «Rivista italiana di scienza politica», XXX, 3, 2000, pp. 423-474; Roberto Cartocci, Voto, valori e religione, in: Mario Caciagli, Piergiorgio Corbetta (a cura di), Le ragioni dell’elettore. Perché ha vinto il centro-destra nelle elezioni itliane del 2001, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 165-202; Roberto Cartocci, Fra lega e Chiesa. L’Italia in cerca di integrazione, Bologna, il Mulino, 1994.
[16] Carlo Tullio-Altan, I valori difficili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche e politiche dei giovani in Italia, op. cit., p. 95.
[17] Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi, op. cit., p. 14.
[18] Cfr. Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit.
[19] Cfr. Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, op. cit.
[20] Cfr. Silvano Burgalassi, Le cristianità nascoste, Bologna, Dehoniane, 1970.
[21] Cfr. Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, op. cit.
[22] Cfr. Franco Garelli, L’Italia cattolica nell’epoca del pluralismo, Bologna, il Mulino, 2006.
[23] Cfr. Edmondo Berselli, Roberto Cartocci, Due Italie, forse. A proposito delle elezioni del 9-10 aprile, «il Mulino», LV, 424, 2006, pp. 243-252; Roberto Cartocci, Che ne sarà del nostro bipolarismo?, «il Mulino», LIII, 414, 2004, pp. 621-628; Roberto Cartocci, Bipolarismo reale, «il Mulino», LIII, 411, 2004, pp. 57-66.
[24] Cfr. Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 125.
[25] Cfr. Carlo Tullio-Altan, I valori difficili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche e politiche dei giovani in Italia, op. cit.
[26] Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 62.
[27] Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi, op. cit., p. 29.
[28] Cfr. Cataldo Naro, L’opzione “culturalista” della chiesa siciliana, in: Stefano Diprima (a cura di), Per un discorso cristiano di resistenza alla mafia, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1995, pp. 115-131; Francesco Mercadante, Legalità e santità: la morte bianca di un vescovo in terra di mafia, in: Massimo Naro, Sorpreso dal Signore. Linee spirituali emergenti dalla vicenda e dagli scritti di Cataldo Naro, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2010, pp. 277-325.
[29] Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 118.
[30] Op. cit., p. 12.
[31] Op. cit., p. 17.
[32] Cfr. Silvano Burgalassi, Elementi per un’analisi della religiosità in Toscana, Bologna, il Mulino, 1965.
[33] Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 139.
[34] Cfr. op. cit., p. 25.
[35] Op. cit., p. 135.
[36] Giancarlo Zizola, Benvenuto nel Paese che ha smarrito la fede “tradizionale”, «la Repubblica», 7 luglio 2011, p. 35.
[37] Cfr. Enzo Pace, Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa dell’Italia che cambia, op. cit., p. 152.
[38] Franco Garelli, Gustavo Guizzardi, Enzo Pace, Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani, op. cit., pp. 77-114.
[39] Op. cit., pp. 88-92, passim.
[40] Alessandro Castegnaro (a cura di), Apprendere la religione. L’alfabetizzazione religiosa degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, Bologna, Dehoniane, 2009, p. 219.
[41] Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, op. cit., p. 91.
[42] Op. cit., p. 94.
[43] Op. cit., p. 96.
[44] Cfr. Pierpaolo Parma (a cura di), Il messaggio e la prassi. Indagine socio-religiosa nell’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-S. Angelo in Vado, Bologna, Dehoniane, 2004, p. 121.
[45] Op. cit., p. 160.
[46] Op. cit., pp. 163-164.
[47] Cfr. op. cit., p. 303.
[48] Op. cit., p. 304.
[49] Gabriele Di Francesco, I giovani nella chiesa locale. Religiosità e modelli di partecipazione giovanile nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 59.
[50] Op. cit., p. 61.
[51] Cfr. op. cit., p. 152.
[52] Cfr. op. cit., p. 153.
[53] Lucio Meglio, Società religiosa e impegno nella fede. Indagine sulla religiosità giovanile nel Basso Lazio, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 104.
[54] Roberto Cipriani, Clemente Lanzetti, La religione continua. Indagine nella diocesi di Oristano, Oristano, L’Arborense, 2010.
[55] Massimo Introvigne, PierLuigi Zoccatelli, La messa è finita? Pratica cattolica e minoranze religiose nella Sicilia Centrale, Roma-Caltanissetta, Sciascia, 2010.
[56] Op. cit., p. 86.
[57] Cfr. Roberto Cipriani, La religione dei valori, op. cit.
[58] Cfr. Alessandro Castegnaro, Monica Chilese, Giovanni Dal Piaz, Italo De Sandre, Nicola Doppio, C’è campo? Giovani, spiritualità, religione, Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 192-194.
[59] Op. cit., p. 192.
[60] Op. cit., p. 385.
[61] Op. cit., p. 395.
[62] Cfr. op. cit., pp. 385-418.
[63] Op. cit., p. 611.
[64] Op. cit., p. 614.
[65] Op. cit., p. 612.
[66] Cfr. op. cit., p. 615.
[67] Robert N. Bellah, Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler, Steven M. Tipton, Habits of the Heart. Individualism and Commitment in American Life, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1985; ed. it., Le abitudini del cuore. Individualismo e impegno nella società complessa, Roma, Armando, 1996.
Quali cattolici in Italia?
In attesa di una nuova indagine a carattere nazionale sulla religiosità in Italia, conviene far riferimento ad un recente studio[1] che presenta alcuni dati che hanno almeno il pregio di una certa affidabilità, in quanto elaborati a partire dalle indagini, aventi un carattere “multiscopo”, condotte sulle famiglie italiane da parte dell’Istituto Centrale di Statistica, nel periodo 1993-2009.
L’autore, Roberto Cartocci, non è nuovo a nutrire interessi per il fatto religioso in Italia. Già in precedenza aveva collaborato, in particolare sul tema dei valori, con Carlo Tullio-Altan [2], il quale aveva rilevato la presenza di «giovani serissimi, anche se poco loquaci, pieni di fede e di convinzione nelle istanze di valore che loro si dischiudono»[3] ed in altra sede aveva aggiunto che «le idee, le credenze, i pregiudizi, le norme di vita che fanno parte di una cultura, quando si traducono in concreti comportamenti, cessano di appartenere al puro regno dei simboli e dei concetti, e si fanno “cose” e cose di eccezionale durezza e consistenza, con le quali bisogna fare i conti come con la più feroce realtà»[4].
In vari lavori di Cartocci vengono usati concetti-chiave di natura geografica: territori, zone, città, atlante, mappe, ecc.. Nel 2011, come autore unico, ha pubblicato un testo di geografia statistica dell’Italia religiosa[5], il quale pur presentando qualche dato che meriterebbe maggiori approfondimenti nondimeno rappresenta un ulteriore punto di vista sulla situazione attuale e dunque merita adeguata discussione.
Si prendano due elementi in qualche modo correlati: il declino della pratica religiosa e l’aumento dei matrimoni civili. Entrambi sarebbero da attribuire al processo di secolarizzazione in atto. Ma intanto è già dubbia la percentuale, registrata nel 2009, di una pratica religiosa almeno settimanale da parte del 32,5%, contrapposta ad una totale assenza di frequenza ai riti domenicali da parte del 19,1%. La diminuzione sarebbe avvenuta in misura significativa rispetto al 1995 allorquando era del 38,1%. Intanto altre indagini provano che i tassi di frequenza sono ben diversi, in entrambi i casi: è stato documentato nell’indagine nazionale sulla religiosità – i cui esiti sono stati resi noti appunto nel 1995[6] – che i praticanti regolari settimanali erano quasi il 31%. Che tale risultato possa essere cambiato sostanzialmente e persino aumentato, dopo quattordici anni, non pare verosimilmente fondato, perché sarebbe in contraddizione palese con gli esiti di varie altre indagini svolte nel frattempo. Ed anche il tasso di non frequenza assoluta della messa appare alto rispetto a percentuali più contenute accertate nel 1995 che presentavano quasi una decina di punti in meno.
Non va dimenticato infine che da parte degli intervistati c’è di solito una tendenza (data abbastanza per scontata fra gli specialisti del settore socio-religioso) per cui si afferma di fare molto di più di quello che realmente si fa: per esempio si dice di andare a messa ogni domenica ma in realtà la frequenza potrebbe essere di una-due volte in un mese.
L’aumento delle coppie di fatto passate dal 3,5% al 5,5% in dieci anni non si lega, peraltro, necessariamente alla secolarizzazione: possono essere mutati i costumi relazionali, vi possono essere ragioni economiche ed occupazionali (o, meglio, di mancata occupazione), può interferire un modello giovanile diverso da quello in voga in precedenza. Insomma la scelta civile, invece che religiosa, in campo matrimoniale non vuol dire necessariamente un’opzione antireligiosa o atea o indifferente.
Cartocci, inoltre, parla di un «cattolicesimo di maggioranza» che riguarderebbe circa metà della popolazione. Una tale percentuale, di poco più del 50%, ricorda da vicino un’altra categoria, assai criticata, usata da don Silvano Burgalassi nel 1970[7]: quella dell’indifferenza, ammontante al 55% della popolazione. In entrambi i casi le categorie concettuali usate appaiono troppo ampie e troppo onnicomprensive. Chi fa indagini sociologiche sa bene che gruppi così numerosi presentano in genere delle diversificazioni al loro interno, tali da rendere necessaria un’ulteriore procedura almeno di suddivisione dell’insieme qualificato «di maggioranza» o «indifferente».
La minoranza, sempre per Cartocci, sarebbe rappresentata dai cattolici militanti, nella misura del 10%. Anche in questo caso l’esperienza di ricerca sul campo fa propendere per altre quantificazioni: se per esempio è vero che l’associazionismo a carattere religioso riguarda circa l’8% della popolazione non è detto che la militanza cattolica si limiti a questo. Ed anzi la stessa pratica religiosa regolare domenicale è appena un indicatore fra gli altri.
Insomma occorre fare i conti con altri dati: sei su dieci matrimoni avvengono in chiesa, otto bimbi su dieci nascono a matrimonio avvenuto, l’otto per mille per la Chiesa cattolica non è plebiscitario ma ha pur sempre una sua consistenza (massima in Puglia e minima in Emilia-Romagna), una larga maggioranza degli alunni opta per l’insegnamento scolastico della religione (coloro che non si avvalgono sarebbero l’8,8%, cioè una percentuale abbastanza vicina a quella dei non praticanti in assoluto già nota dal 1995[8]).
Fra l’altro il docente bolognese si avvale pure dello studio di Garelli sull’Italia cattolica[9], in cui l’associazionismo, compreso quello nella Caritas e nella pastorale parrocchiale, risulta attestato sul 10% («cattolici militanti»), ma in aggiunta si segnala tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti che comprendono il 20% di persone («cattolicesimo di minoranza») che vanno regolarmente a messa la domenica, quelle assai più numerose (attorno al 50%, «cattolicesimo di maggioranza») la cui pratica è saltuaria, quelle infine (circa il 10%) che non praticano ma firmano a favore dell’otto per mille destinandolo alla Chiesa cattolica ed optano per l’insegnamento della religione cattolica da impartire ai loro figli. La quota rimanente (ancora 10%) è fatta di soggetti indifferenti, agnostici, atei, anticlericali, non cattolici in generale. Quest’ultima categoria risulta ancora una volta piuttosto generica. Sarebbe auspicabile un’adeguata indagine ad hoc, per comprendere meglio le dinamiche in atto nel variegato mondo che non si richiama alla Chiesa cattolica.
In definitiva appaiono un po’ troppo ampia la categoria maggioritaria e un po’ troppo ristretta quella minoritaria (a dire il vero, Cartocci più volte ha insistito, nel corso dei suoi studi, sull’idea di bipolarismo[10] applicata al caso italiano, fino a distinguere anche fra un nord laico ed un nord cattolico[11], memore forse della lezione di Tullio-Altan, il quale nella sua ricerca sui «valori difficili»[12] aveva parlato di valori in contrapposizione, di dualismo non solo generazionale ma anche geografico, con orientamenti più tradizionalistici nel sud).
Il dato di fatto è che la credenza e la pratica di matrice cattolica non sono limitate a circa un terzo della popolazione italiana. E comunque se è vero che c’è una tendenziale compattezza dei cattolici è altresì un dato di fatto la loro diversificazione su temi politici, etici, comportamentali, ideologici. D’altra parte anche il numero dei non praticanti in assoluto va forse ridimensionato, come si è già detto, più verso il 10% che non il 15% od anche più.
Andrebbero poi enfatizzate alcune dimensioni storico-culturali, come nel caso dell’alta frequenza religiosa in Campania e dei matrimoni religiosi tra i palermitani. Da anni gli studiosi di sociologia della religione, specialmente coloro che hanno condotto ricerche in Campania ed in Sicilia, vanno sostenendo che in tali contesti il frequentare la chiesa ogni domenica è essenzialmente un tratto culturale ben radicato, che travalica la sostanza stessa della motivazione religiosa (lo stesso discorso vale per la celebrazione del matrimonio religioso). A proposito di quest’ultimo il differenziarsi dei dati, nel tempo, fra Napoli e Milano è dovuto probabilmente non ad un’inversione di tendenza ma ad una diversa velocità di diffusione di una prassi, anche a seguito dell’approvazione della legge sul divorzio, a partire dunque dagli anni ‘70. Così il fatto che a Napoli nel 1951 i matrimoni civili toccassero il 17,7% ed a Milano il 5,4% era dovuto, a pochi anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, a ragioni forse di natura economica (il matrimonio in chiesa e la successiva offerta di convivialità potevano costare assai più di una semplice celebrazione in municipio, magari neppure seguita dal pranzo di nozze). Comunque all’epoca non era ancora così accentuato il divario socio-economico fra le due metropoli, entrambe reduci dal disastro bellico. Successivamente lo sviluppo industriale milanese e le abituali difficoltà di natura economica nella città partenopea hanno fatto sì che si amplificasse la differenza fra le due città, anche in termini di modernizzazione delle rispettive culture urbane, per cui Milano potrebbe aver subito una maggiore accelerazione in fatto di costume e modelli comportamentali mentre Napoli potrebbe aver mantenuto la tendenza già in atto (infatti i matrimoni civili sono comunque aumentati fino al 26,3% di tutti i matrimoni; invece a Milano il mutamento è stato maggiore, anche in questo campo, ed ha portato la celebrazione civile delle nozze a costituire il 57,6% del totale; insomma Napoli è giunta ad avere un matrimonio civile ogni quattro e nel contempo Milano è passata a nozze civili più frequenti, cioè oltre la metà di tutte quelle celebrate). Nondimeno la questione resta aperta, dato che l’autore con rara umiltà scientifica dichiara l’impossibilità di riuscire a spiegare il caso napoletano: «chi scrive non è in grado di dare una spiegazione di questo crollo dei matrimoni civili nel comune di Napoli»[13].
Ancora lo stesso Cartocci sottolinea che un certo livello di mancato sviluppo va di pari passo con una maggiore, più intensa pratica religiosa (per esemplificare: nel sud, religiosamente più osservante, non si fa la raccolta differenziata dei rifiuti e quando occorre si fa ricorso agli ospedali settentrionali). E d’altro canto la religiosità parrocchiale tradizionale del meridione non mostrerebbe una particolare capacità nel contrastare l’illegalità, il degrado, la corruzione.
Qui però il discorso si fa ancora più complicato, perché rischia di prescindere da dati di contesto, e di tipo storico e di tipo culturale. Tornano utili dunque le parole, ancora una volta, di Carlo Tullio-Altan: «una certa mentalità pubblica è il prodotto di una combinazione storica di fattori economici, sociali, politici, e specificamente culturali, combinazione nella quale tale mentalità prende forma, in armonia e in relazione alle esigenze che quella combinazione stessa globalmente esprime. Ma una volta formatasi, e consolidatasi in una certa guisa, tale mentalità diviene una realtà vischiosa e resistente, che sopravvive alle condizioni che l’hanno generata, e agisce a sua volta come uno dei fattori rilevanti, sugli eventi successivi, economici, sociali e politici»[14].
Non va dimenticato peraltro che in Italia la ruralità ha ancora un suo peso nel mantenimento delle tradizioni consolidate e che la realtà territoriale è fatta in buona parte proprio di piccoli agglomerati residenziali (molti comuni rurali e meridionali sono al di sotto di mille abitanti).
Sono poi ben note nel sud le ambiguità delle relazioni Chiesa-mafia ma altrettanto note sono le lotte condotte in proposito da alcuni esponenti della Chiesa cattolica[15].
La propensione di Cartocci a dividere la fenomenologia religiosa in due soli aspetti (o quasi) si applica non solo alla relazione fra praticanti e non praticanti, come pure fra matrimoni civili e religiosi, ma investe l’intera realtà italiana che parrebbe più secolarizzata al centro-nord che non al centro-sud, dove perdurerebbe la religiosità di tipo tradizionale.
Anche gli indicatori della scelta dell’insegnamento della religione a scuola e della firma dell’otto per mille a favore della Chiesa cattolica paiono rientrare nella medesima logica bipartitoria. Ed allora la non scelta scolastica della religione riguarda più il nord che il sud in ogni ordine e grado. Pure l’assenza di firme per l’otto per mille a favore della Chiesa cattolica è più frequente nel settentrione (specie in Emilia e Romagna) che nel meridione (dove Calabria, Campania e Sicilia contribuiscono con la quasi totalità delle firme per la Chiesa cattolica).
Particolarmente utile è la tabella 7.1 predisposta da Cartocci[16] sulle scelte dell’otto per mille. I dati provengono da Monsignor Mauro Rivella, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, e si riferiscono al 2004. Un’ulteriore elaborazione della tabella offre un quadro più dettagliato sulla ripartizione delle firme, anche in termini percentuali effettivi.
Tab. 1
FIRME VALIDE DELL’OTTO PER MILLE NEL 2004
| Destinatario | Dichiarazioni I.R.Pe.F. | Firme valide | % firme valide sul totale delle dichiarazioni | % quote assegnate sul totale dell’8‰ |
| Chiesa cattolica | 14.628.795 | 36,28 | 89,8 | |
| Stato | 1.254.362 | 3,11 | 7,7 | |
| Chiesa evangelica valdese | 228.066 | 0,57 | 1,4 | |
| Unione delle comunità ebraiche italiane | 65.162 | 0,16 | 0,4 | |
| Chiesa evangelica luterana in Italia | 48.871 | 0,12 | 0,3 | |
| Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno | 32.581 | 0,08 | 0,2 | |
| Assemblee di Dio in Italia | 32.581 | 0,08 | 0,2 | |
| Totale | 40.316.962 | 16.290.418 (16.480.730)* | 40,4 | 100,0 |
* comprese 190.312 scelte non valide
La maggioranza dei contribuenti italiani non ha preso affatto in considerazione la possibilità di scelta offerta con l’otto per mille: sono 23.836.232 i soggetti che non hanno fatto alcuna opzione e costituiscono più della metà (59,12%) dei dichiaranti l’imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.Pe.F.). .
Per Cartocci, dopo aver riconosciuto che «la tradizione cattolica appare così come il collante più antico, il tratto più solido di continuità fra le diverse componenti del paese»[17], segnatamente l’azione esercitata dal Regno delle Due Sicilie non sarebbe estranea alla religiosità più tradizionale e stabile rintracciabile nel meridione italiano. L’ipotesi potrebbe avere qualche fondamento, ma occorre considerare che la Sardegna non rientrerebbe nel discorso formulato, nonostante sia poco secolarizzata, stando agli indicatori sociologici utilizzati dallo studioso fiorentino. D’altro canto per la maggiore secolarizzazione del centro-nord si potrebbe pensare alla presenza del socialismo e del comunismo come pure di varie forme di laicismo. Ma pure in questo caso giova ricordare invece la forte presenza dello Stato della Chiesa in vasti territori dell’Italia centrale (e non solo). Come combinare influenze così diverse? La storia invero ha tracciati assai lunghi, che travalicano i secoli e che si combinano in modo assai differenziato con le situazioni locali.
A completamento del discorso, il politologo dell’Università di Bologna riconosce che «in Italia esiste una rete di diocesi e parrocchie senza paragoni rispetto a tutti gli altri paesi cattolici, una presenza istituzionale che non è minimamente avvicinata da nessun’altra organizzazione, a parte lo stato. Sul piano dei comportamenti si registrano poi tassi di religiosità più elevati della maggior parte degli altri paesi»[18]. Appunto questa capillarità della Chiesa cattolica italiana consente di verificare la presenza di forti dosi di religiosità anche in aree del nord ritenute piuttosto secolarizzate, ma altresì un basso livello di religiosità e di pratica religiosa pure in qualche area del sud e delle isole.
Lo strumento statistico adoperato per classificare le differenziazioni territoriali (regioni e province) è basato su pochi indicatori (appena quattro: pratica religiosa festiva, matrimoni ed unioni di fatto, insegnamento della religione ed otto per mille). E dunque c’è da chiedersi quanto possa aiutare il discorso fondato su basi non particolarmente solide, visto che il fenomeno religioso è ben più articolato delle quattro componenti analizzate da Cartocci. Oltretutto la classifica per province e per regioni non fa altro che confermare talune interpretazioni ed elaborazioni statistico-sociologiche ampiamente acquisite da tempo e quindi non segnala particolari sorprese: il laicismo dell’Emilia-Romagna come la bassa frequenza della messa a Siena (già studiata da Silvano Burgalassi molti anni fa, nell’ambito delle ricerche sulla Toscana[19]).
Entrando nel merito, Cartocci giustamente mette in guardia rispetto a facili conclusioni che assimilerebbero la religiosità meridionale allo scarso sviluppo socio-economico e dunque respinge l’ipotesi della «variante anticlericale» che vede nella Chiesa cattolica l’origine del mancato sviluppo[20].
Un’altra suggestione da ritenere foriera di sviluppi futuri nel campo della ricerca socio-religiosa sul cattolicesimo italiano deriva dall’individuare una categoria di individui pienamente secolarizzati o indifferenti o anticlericali o appartenenti ad altre confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica: sono il 10% e rappresentano il cerchio più lontano dal mondo cattolico[21].
In definitiva «il 60% delle coppie si sposa in chiesa, i bambini nascono per l’80% dopo il matrimonio, il 90% sceglie la chiesa come destinazione dell’otto per mille, il 91% degli scolari frequenta le lezioni di religione nelle scuole. Coloro che non mettono piede in chiesa sono meno del 20% degli italiani. E comunque, anche tra questi, una buona metà ha più fiducia nella chiesa che nello stato, quanto meno come istituzione educativa e di carità»[22]. Queste affermazioni sono certo fondate sui dati ma in qualche caso anche discutibili, a partire dal 90% che sceglie la Chiesa nell’otto per mille (la consistenza reale è del 36,28%, in rapporto al numero totale dei contribuenti dell’I.R.Pe.F.).
Semmai è da tenere presente anche quanto ha sostenuto il compianto Giancarlo Zizola, commentando il lavoro di Cartocci: «la Chiesa che affiora da questi grafici è una grande e gloriosa istituzione fortemente stanca e assopita sulla propria potenza burocratica, ma che è coinvolta suo malgrado in un processo di mutazione storica dovuta più ancora ai cambiamenti sociologici e culturali che ai problemi interni dell’istituzione»[23].
[1] Cfr. Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, Bologna, il Mulino, 2011.
[2] Cfr. Carlo Tullio-Altan, I valori difficili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche e politiche dei giovani in Italia, Milano, Bompiani, 1974; Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi, Milano, Feltrinelli, 1986; Carlo Tullio-Altan, Italia: una nazione senza religione civile. Le ragioni di una democrazia incompiuta, presentazione di Roberto Cartocci, Udine, Istituto editoriale veneto friulano, 1995; Carlo Tullio-Altan, La coscienza civile degli italiani. Valori e disvalori nella storia nazionale, Udine, Gaspari, 1997 (collaborazione di Roberto Cartocci, autore del saggio L’Italia di tangentopoli e la crisi del sistema politico).
[3] Carlo Tullio-Altan, I valori difficili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche e politiche dei giovani in Italia, op. cit., p. 95.
[4] Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi, op. cit., p. 14.
[5] Cfr. Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit.
[6] Cfr. Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, Milano, Mondadori, 1995.
[7] Cfr. Silvano Burgalassi, Le cristianità nascoste, Bologna, Dehoniane, 1970.
[8] Cfr. Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti, Gianfranco Rovati, La religiosità in Italia, op. cit.
[9] Cfr. Franco Garelli, L’Italia cattolica nell’epoca del pluralismo, Bologna, il Mulino, 2006.
[10] Cfr. Edmondo Berselli, Roberto Cartocci, Due Italie, forse. A proposito delle elezioni del 9-10 aprile, «il Mulino», LV, 424, 2006, pp. 243-252; Roberto Cartocci, Che ne sarà del nostro bipolarismo?, «il Mulino», LIII, 414, 2004, pp. 621-628; Roberto Cartocci, Bipolarismo reale, «il Mulino», LIII, 411, 2004, pp. 57-66.
[11] Cfr. Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 125.
[12] Cfr. Carlo Tullio-Altan, I valori difficili. Inchiesta sulle tendenze ideologiche e politiche dei giovani in Italia, op. cit.
[13] Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 62.
[14] Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socio-culturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi, op. cit., p. 29.
[15] Cfr. Cataldo Naro, L’opzione “culturalista” della chiesa siciliana, in: Stefano Diprima (a cura di), Per un discorso cristiano di resistenza alla mafia, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1995, pp. 115-131; Francesco Mercadante, Legalità e santità: la morte bianca di un vescovo in terra di mafia, in: Massimo Naro, Sorpreso dal Signore. Linee spirituali emergenti dalla vicenda e dagli scritti di Cataldo Naro, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2010, pp. 277-325.
[16] Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 118.
[17] Op. cit., p. 12.
[18] Op. cit., p. 17.
[19] Cfr. Silvano Burgalassi, Elementi per un’analisi della religiosità in Toscana, Bologna, il Mulino, 1965.
[20] Roberto Cartocci, Geografia dell’Italia cattolica, op. cit., p. 139.
[21] Cfr. op. cit., p. 25.
[22] Op. cit., p. 135.
[23] Giancarlo Zizola, Benvenuto nel Paese che ha smarrito la fede “tradizionale”, «la Repubblica», 7 luglio 2011, p. 35.
Dalla Big Society alla Bigger Society
Premessa
L’idea di Big Society nasce, da evidenti ragioni di natura politico-elettorale, come concetto-guida del programma del partito conservatore britannico, in vista delle elezioni del 2010, che hanno poi portato alla coalizione fra tories e liberal democrats, cioè fra il primo ed il terzo partito più votati. La proposta originale resta però di matrice conservatrice e fa parte dell’Invitation to join the Government of Britain. The Conservative Manifesto 2010, datato aprile 2010. Il tema viene poi ripreso, ad elezioni concluse, nel Conservative-Liberal Democrat Coalition Agreement del 12 maggio 2010 e riproposto da David Cameron in suo intervento del 19 luglio 2010 presso la Liverpool Hope University. Successivamente, nel febbraio 2011, si torna a parlare ancora di Big Society in un documento ministeriale dal titolo Growing the Social Investment Market: A vision and strategy, a firma di Francis Maude, ministro per il Cabinet Office e Paymaster General, e di Nick Hurd, ministro per la Società Civile. Ma in quest’ultimo caso la posta in palio sembra ancora più elevata, giacché si parla di una Bigger Society.
Le quattro aree scelte per la sperimentazione iniziale del progetto-pilota sono Eden (Cumbria), Liverpool (Merseyside), Sutton (Greater London), Windsor e Maidenhead (Berkshire), ma nel febbraio del 2011 Liverpool ha rinunciato.
I contenuti e gli obbiettivi
Già le prime indicazioni di partenza sulla Big Society appaiono eloquenti: si sta facendo riferimento ad un programma elettorale, cioè ad una materia facilmente disattesa storicamente (ed a qualunque latitudine) nelle realizzazioni successive; inoltre la proposta originaria è costretta a fare i conti con il nuovo scenario di un accordo politico con un altro partito, diverso da quello conservatore (primo proponente) e che non si era affatto posto il problema di contribuire a creare una Big Society. Inoltre la formula di avvio, Big Society,non riemerge come tale in prosieguo di tempo, tanto che non più lo stesso David Cameron, principale esponente di governo per i conservatori e primo presentatore della Big Society in un suo discorso del 10 novembre 2009, ma due suoi ministri rilanciano un progetto che nel frattempo sembra aver incontrato difficoltà, dato che non viene più riconsiderato in termini piuttosto espliciti ed unici (in effetti si cita la Big Society ma solo in chiave di Big Society Bank, nel quinto dei sei capitoli del documento del 2011) ma rilanciato come Bigger Society.
Poste tali premesse, non vi è chi non veda uno slabbrarsi del progetto iniziale, un venire a patti con esigenze interpartitiche ed un indebolimento della carica iniziale, tali da costringere a chiedere un aiuto alle banche per sostenere il passaggio da una Big ad una Bigger Society.
Esaminiamo più da vicino i contenuti della proposta cameroniana ufficiale, cioè il programma dei conservatori per le elezioni del 2010. L’obiettivo è di “ridurre la povertà, combattere la disuguaglianza ed incrementare il benessere generale” raggiungendo “livelli più alti di responsabilità personale, professionale, civica e collettiva (corporate)”, insomma facendo in modo che “la gente si metta insieme per risolvere i problemi e migliorare la propria vita e quella delle proprie comunità”, in una società in cui “la forza guida per il progresso è la responsabilità sociale, non il controllo dello stato”. Per costruire la Big Society occorre “riformare i servizi pubblici, ricostruire (mend) la nostra società frammentata (broken) e ridare fiducia nei confronti della politica”. Per ottenere ciò va “ridistribuito il potere dallo stato alla società, dal centro alle comunità locali, offrendo alla gente l’opportunità di avere un maggiore controllo sulle proprie vite”. Pertanto “lo stato è chiamato a stimolare l’azione sociale, sostenendo le imprese sociali nel rendere servizi pubblici ed addestrando i nuovi organizzatori di comunità ad accompagnare la realizzazione della nostra ambizione che ogni cittadino adulto sia un membro di un gruppo attivo di vicinato”. A tale scopo si darà un “finanziamento diretto a quei gruppi che rafforzano le comunità nelle aree deprivate”. Lo strumento di tale operazione sarà l’introduzione del National Citizen Service,“inizialmente per i sedicenni, per aiutare a mettere insieme il nostro paese”. Pertanto si vorrà “rendere capaci le imprese sociali, le organizzazioni caritatevoli ed i gruppi di volontariato di svolgere un ruolo guida nello svolgimento dei servizi pubblici e nell’affrontare i problemi sociali dalle radici profonde”. Si pensa ad una Big Society Bank, “finanziata dai conti bancari dormienti, per disporre di nuove risorse finanziarie per i gruppi di vicinato, le organizzazioni caritatevoli, le imprese sociali ed altri enti non governativi” (p. 37).
Si farà inoltre un bando “per contratti governativi o lavoro in cambio dello svolgimento di servizi da pagare in base ai risultati raggiunti”. Il che fa anche leva sulla “tradizione di carità” presente nel mondo culturale britannico da lungo tempo (oltre 16.000 enti e 475.000 addetti). Si prevedono altresì “contributi per dare alle organizzazioni del settore del volontariato una maggiore stabilità” e si cercherà di fare in modo che “i genitori facciano decollare nuove scuole, rinvigoriscano le comunità assumendo in proprio la gestione di loisirs come i parchi e le biblioteche che sono in difficoltà (under threat), dando ai vicinati un maggiore controllo del sistema di pianificazione e rendendo capaci i residenti di avere la polizia” ed aiutando “le aree più povere ad assumere un ruolo guida nel ricostruire la società civica” (si badi bene non si parla di società civile ma “civica”). Si prevede di “trasformare il servizio civile in un servizio civico” cosicché “la partecipazione nell’azione sociale sia riconosciuta nelle valutazioni dei funzionari civili” (p. 38). Si celebrerà anche una “giornata annuale della Big Society”.
Inoltre si svilupperà ed incoraggerà “il concetto di servizio reso con spirito pubblico (public spirited service)”. E si offriranno “denaro e tempo per le buone cause” con lo scopo di far “crescere la filantropia” e “la partecipazione comunitaria su base regolare”. Pure la lotteria nazionale verrà ricondotta alle origini per mettere a disposizione “denaro per le buone cause”. “Gli sports – anche -, il patrimonio culturale e le arti riavranno il loro contributo originario del 20 per cento”. In merito si pensa in particolare ai Commonwealth Games previsti a Glasgow nel 2014, alla Rugby League del 2013 ed alle Rugby Union World Cups del 2015 e si spera nella Coppa del Mondo di calcio nel 2018 (p. 39). Insomma ben poco è trascurato fra le diverse possibilità di implementazione della Big Society. Ma nel documento ufficiale non mancano ripetizioni e ridondanze, che denotano una certa carenza di proposte valide e convincenti.
La nuova proposta
A seguito poi della coalizione fra il partito conservatore ed i democratici liberali il progetto della Big Society è stato riformulato il 12 maggio del 2010 e pubblicato il 20 maggio dello stesso anno, portando alla messa a punto di ulteriori contenuti condivisi da entrambi i partiti dell’accordo politico-governativo. Il documento avrebbe dovuto essere seguito da un’intesa finale di coalizione, riguardante “l’ambito completo della politica ed includente i temi politici interni e della difesa”. Ma di tale ulteriore dichiarazione ufficiale di intenti non vi è traccia.
La riformulazione, frutto dell’accordo fra i due citati partiti, investe la “riduzione del deficit” e “piuttosto delle spese invece di aumentare le tasse”, per “proteggere i bassi redditi” e “porre termine alla tassa del partito laburista sulle occupazioni”, onde “sostenere ancora di più la creazione di occupazione” e l’“investimento ecologico”. Si prospetta una “revisione delle spese (spending review) totale”.
Nel secondo punto si parla anche di un “rilevante premio, al di fuori del budget scolastico, per gli allievi svantaggiati”. Si prospetta “una revisione totale della sicurezza strategica e della difesa”, insieme con un “continuo avanzamento nel disarmo multilaterale”. Nel campo previdenziale è ipotizzata una “commissione indipendente per rivedere la sostenibilità delle pensioni del settore pubblico”.
Nel terzo punto dell’accordo si dice di voler “aiutare coloro che hanno un reddito basso e medio”, “ridurre la tassa ereditaria”, ma anche “tassare i profitti da capitale non-business”.
Nel punto seguente si prevede una “riforma del sistema bancario”, con particolare riferimento ai “bonus inaccettabili nel settore dei servizi finanziari”, per “far avanzare la differenziazione (diversity), promuovere forme di mutualità (mutuals) e creare un’industria bancaria più competitiva”, offrire “uno schema di maggiore garanzia per il prestito e l’uso di obiettivi di tasso netto ufficiale di prestito (net lending) per le banche nazionali”, pensando pure a “ridurre il rischio sistematico nelle banche” ed alla creazione di “una commissione indipendente per indagare sul complesso problema del separare le banche al dettaglio (retail) e quelle di investimento in un modo sostenibile”. Si vuole affidare alla “Banca d’Inghilterra il controllo della regolazione macro-prudenziale”. E da ultimo si esclude di ricorrere alla “moneta unica europea”. Si regola inoltre il “limite annuale del numero dei migranti economici non EU ammessi”. In pari tempo si vuole porre “fine alla detenzione di bambini per motivi di immigrazione”.
Il punto sei riguarda la durata del mandato parlamentare da fissare a cinque anni e la frode elettorale da ridurre. Per il lobbismo si propone di porre un argine creando un “registro dei lobbisti”. Inoltre si limiteranno le donazioni ai partiti e se ne riformerà il sistema di finanziamento. Soprattutto però si ritiene di “promuovere una devoluzione del potere ed una maggiore autonomia finanziaria al governo locale ed ai gruppi comunitari”.
Nel settimo punto del programma concordato fra i due partiti si propone di fissare a 66 anni l’età pensionabile. In pari tempo si provvederà a creare un programma di welfare che sostenga il ritorno dei disoccupati ad un’attività lavorativa. Si propone di offrire un programma di welfare anche a giovani al di sotto dei 25 anni che dopo sei mesi di ricerca di un lavoro non siano stati in grado di trovarlo.
Più avanti, al punto 8, si dice che la scuola sarà sottoposta a riforma, nuove proposte di offerta formativa potranno essere integrate nel sistema scolastico statale su richiesta dei genitori e le scuole potranno avere una maggiore libertà nell’organizzare i loro percorsi curricolari. Nell’ambito dell’alta educazione, poi, si mirerà ad incrementare la mobilità sociale, a finanziare il settore universitario, a migliorare la qualità dell’insegnamento e ad aumentare il numero degli studenti provenienti da contesti svantaggiati.
Per quanto concerne l’Unione Europea si assicura una collaborazione fattiva per migliorare la competitività globale ed affrontare il problema della povertà ma senza rinunciare ad alcuna sovranità e potere in favore dell’Unione Europea. Inoltre mentre si conferma di non accedere all’uso dell’euro nel corso della legislatura in atto si pensa piuttosto a difendere gli interessi del Regno Unito nelle negoziazioni di tipo budgetario. Si chiederà altresì di avere un’unica sede dell’Unione Europea a Bruxelles. A livello di giustizia si affronteranno le questioni di natura criminale caso per caso e non si prenderà parte all’insediamento di un unico pubblico ministero.
Nel penultimo punto, il decimo, si ritiene di attivare un programma di misure contrarie alla riduzione delle libertà civili, un registro di identità nazionale ed un passaporto di tipo biometrico. Non si potranno prendere a scuola le impronte digitali degli allievi senza il permesso dei genitori. Verrà esteso l’obiettivo del Freedom of Information Act in vista di una maggiore trasparenza. Saranno garantiti i diritti alla protesta non violenta ed alla libertà di parola. Anche la legislazione antiterrorismo sarà oggetto di particolare attenzione per evitare abusi. Lo stesso dicasi per le registrazioni abusive di comunicazioni elettroniche via Internet. Verrà infine escogitato un sistema che impedisca il proliferare di offese non necessarie.
L’ultimo punto, l’undecimo, tratta dell’ambiente e prevede un’economia che non lo danneggi e riduca il ricorso al carbone, insieme con una diminuzione delle tariffe elettriche. Si programma una banca di investimento “verde”. Si favorirà il ricorso all’energia marina. Si svilupperà la rete dell’alta velocità ferroviaria. Sarà cancellato il progetto di una terza pista ad Heathrow, nonché di quelle previste a Gatwick e Stansted. Si sostituirà il diritto aereo per passeggero con il diritto aereo per volo. Si favoriranno spazi verdi e corridoi naturali. Si creerà una rete per la ricarica di veicoli elettrici e misti. Si svilupperanno soluzioni di energia rinnovabile. Infine i democratici liberali manterranno la loro opposizione all’energia nucleare ma permetteranno al governo di procedere con la possibilità di nuovi impianti nucleari. Il governo si impegna altresì a mettere a punto una dichiarazione per la pianificazione nazionale.
Le critiche
Sono sostanzialmente due le osservazioni critiche di merito sulle diverse proposte dei conservatori e dei democratici liberali. La Big Society del partito conservatore britannico non nasce da un’apposita indagine di sfondo, da un’inchiesta previa tra gli elettori, da una riflessione ampia ed approfondita sulla situazione socio-economica del momento in Gran Bretagna, ma è frutto di elaborazioni a tavolino da parte di specialisti delle campagne elettorali e della comunicazione, con appena qualche contributo di esperti qualificati (qualcuno dei quali – e non certo un protagonista minore: Nat Wei, fondatore di Teach First Charity – ha poi ritenuto opportuno non essere più della partita, vista forse l’impraticabilità della Big Society, dopo i primi tentativi andati a vuoto).
Occorre poi ricordare che il principale ispiratore della Big Society è un teologo e filosofo politico di buona formazione (a Cambridge), ma con scarsa dimestichezza con la sociologia, per quanto è possibile desumere dalle informazioni disponibili. Si chiama Phillip Blond, nativo di Liverpool, quasi cinquantenne, il quale definisce la Big Societycome “una nuova forma di società che si propone di risolvere due grandi problemi: l’eccessiva concentrazione di potere nello stato e lo strapotere del mercato”. La sua agenzia ResPublica è al servizio del partito conservatore.
In secondo luogo occorre aggiungere che quanto proposto da Cameron e dai suoi non sembra avere nemmeno il carattere delle utopie di grande respiro riformatore ed a carattere socio-politico, cioè di quelle prospettive utopiche tanto care all’analisi ed all’attenzione di Karl Mannheim (Ideologia e utopia, il Mulino, Bologna, 1974), che, pur avendo dimorato a lungo in suolo britannico, pare quasi non aver lasciato traccia del suo pensiero, almeno presso una certa parte politica. Insomma non si noterebbe nell’approccio convergente di conservatori e democratici liberali quella spinta utopica che rappresenta una costante dei movimenti di larga partecipazione popolare di massa, i quali hanno costellato tanta parte della storia universale.
E dunque il proposito relativo alla Big Society diventa solo un tentativo iniziale, in assenza di adeguata forza propulsiva, di input ideale, di consapevolezza basata sulla realizzabilità almeno di alcuni obiettivi, se non di tutti.
Un primo segnale di avvertimento è venuto subito dall’Arcivescovo anglicano di Canterbury, del tutto avverso alla progettata Big Society. Non sono mancati altri interventi critici, ormai di largo dominio pubblico attraverso la voce di Wikipedia dedicata appunto al tema della Big Society. Ed Miliband la definisce “cloak for the small state”, Brendan Barber immagina che la società ideale di riferimento per Cameron sia la Somalia, Ben Rogers rimprovera allo stato di non aver investito abbastanza per promuovere nelle persone le capacità adatte allo sviluppo di una società partecipativa, Anna Coote si aspetta una società ancor più in difficoltà e mortificata nelle sue potenzialità di intervento, Ed West predice che non vi sarà mai un decollo del progetto cameroniano, Mary Ridell vede una società che rimane ancora povera, fragile, vecchia, malata, Gerald Warner ritiene che l’espressione Big Society sia piuttosto un epitaffio, Unite the Union opina che si tratti di fumo e specchietti per favorire una privatizzazione a tutto spiano, Dave Prentis considera che il governo si stia lavando le mani di tutte le questioni più problematiche.
La Bigger Society e la fine della Big Society
Nel febbraio 2011 viene pubblicato il documento sulla Bigger Society, che ha come sottotitolo “Growing the Social Investment Market: A vision and strategy”. Nel Ministerial Forword si legge, a pagina 5, della volontà di una società più grande e più forte, in cui comunità e cittadini abbiano maggiore peso e siamo migliorati i servizi pubblici, in modo da trasferire il potere dal centro al governo locale. Anche i poliziotti verranno eletti a livello locale e ci saranno organizzatori comunitari. Gli utenti dei servizi avranno una maggiore scelta ed un maggiore controllo. Si formeranno cooperative. Sarà favorito l’accesso al capitale, grazie al sostegno delle maggiori banche del Regno Unito e della Big Society Bank, in modo da rendere disponibile il capitale privato per gli imprenditori sociali. Il mercato sarà in grado di auto-sostenersi senza alcuna interferenza statale.
A firmare la parte introduttiva del documento sono Francis Maude, Minister for the Cabinet Office and Paymaster General, e Nick Hurd, Minister for Civil Society. In seguito, nell’introduzione e nel “sommario esecutivo”, a pagina 7, si promette di migliorare le vite dei cittadini, di decentralizzare i servizi pubblici, offrire fondi statali, far scegliere alle famiglie ed ai singoli alcuni investimenti sociali come parte del loro fondo pensionistico. Si ipotizza di avviare le operazioni bancarie a partire dall’aprile 2011, raccogliendo 200 milioni di sterline dai conti correnti bancari non attivi.
Poco più di un anno dopo il manifesto sulla Bigger Society, il quotidiano La Stampa del 4 settembre 2012 ha annunciato che “Cameron ripone nel cassetto i sogni della ‘Big Society’. Disoccupazione e recessione: dopo due anni il premier preparaun rimpasto e rivede il suo programma-manifesto. Al via un piano di opere pubbliche da 50 miliardi”. Il giornalista Andrea Malaguti da Londra scrive che “dei quindici miliardi di tasse previste entro il 2015, undici saranno pagati dalle fasce più deboli: le donne e i dipendenti pubblici”. Cameron è “il leader che ha triplicato le tasse universitarie e tagliato i sussidi per la casa ai giovani con meno di 25 anni”. Inoltre “il servizio sanitario nazionale si sta riempiendo di ‘zero-hours contracts’, i contratti tipici dei fast food. Gente che arriva negli ospedali a chiamata. Cardiologi, psichiatri, fisioterapisti. Assunti per un’ora. Due. Quello che serve. Senza certezza sul futuro. Li chiamano le aziende private a cui è stata appaltata parte dei servizi. ‘Rischiamo di avere ospedali senza personale. Oppure personale poco qualificato. O irrintracciabile’, ha spiegato il laburista Andy Burnham. Non era davvero questa la Big Society promessa. Così, per dimostrare a tutti di non essere diventato uno sparviero dalle ali corte, capace solo di volare basso, Cameron si è giocato una seconda carta: il piano sviluppo. Cinquanta miliardi di investimenti. Case e infrastrutture. E una small bank governativa per aiutare le nuove aziende. Il suo asso. ‘Sono un conservatore liberale. Pratico, ragionevole e radicale se necessario’, ha chiarito”.
Insomma ancora una volta il piano previsto non viene implementato e si passa a nuove proposte, il cui destino non è difficile immaginare.
Le difficoltà
I quotidiani britannici da The Independent al Daily Mail non mancano di rilevare le difficoltà di Cameron, della coalizione governativa conservatrice e democratico-liberale e del progetto di Big Society,tanto da parlare di una “drammatica conversione ad U”, in un titolo cubitale di The Independent del 16 agosto 2012 in prima pagina, mentre in seconda pagina si calcola il costo della spesa universitaria, che ogni studente deve affrontare in media, nell’autunno del 2012: più di 50.000 sterline; ma a Londra si superano le 65.000 sterline, mentre solo in Scozia l’incidenza è più contenuta (per così dire) e supera di poco le 23.000 sterline. Il ripensamento-svolta a 180 gradi di Cameron intende limitare a 35.000 sterline per persona il costo annuo totale in termini di social care. Da ciò deriverebbe la necessità da parte dei cittadini di integrare a proprie spese (fino a circa 10.000 sterline) la somma necessaria, ad esempio, per il loro mantenimento in una residenza assistita (pag. 5). Più avanti a pagina 6 si evidenzia che, se anche la disoccupazione diminuisce, i salari invero non sono in grado di tenere dietro agli aumenti del costo della vita; ma soprattutto viene sottolineato il forte incremento quasi solo dei lavori a tempo parziale. In effetti circa 2.000 lavori vengono creati quotidianamente in Gran Bretagna (Daily Mail, 16 agosto 2012, pag. 14) ma della loro qualità e durata occorrerebbe sapere di più. Una forma di lavoro cui si ricorre abbastanza è quella dell’auto-impiego, che si ottiene inventando in proprio alcune formule lavorative ad hoc. Ciò tuttavia non risolve il problema delle lunghe code di attesa, soprattutto dei più giovani (Daily Mail, 16 agosto 2012, “City & Finance”, pag. 75) alla ricerca di un qualsiasi lavoro. Insomma se Londra e le Olimpiadi hanno favorito il buon andamento delle dinamiche occupazionali nondimeno è da segnalare che il fenomeno è circoscritto quasi solo alla capitale e vede una forte trasmigrazione dal lavoro a tempo pieno a quello con impegno orario ridotto. In verità giusto i giochi olimpici hanno visto una larga partecipazione di volontari nei servizi più diversi, ma si ripropone l’interrogativo sollevato ancora da The Independent (pag. 16): “From the Olympic to the Big Society?” In pratica l’esempio del volontariato olimpico può anche “ispirare una generazione”, secondo l’espressione di David Cameron, ma il problema reale è quello del futuro di tanti volontari, dopo l’incanto del fuoco di Olimpia e delle tante (43) e preziose (d’oro) medaglie conquistate dal Regno Unito in varie discipline sportive. Certo resta la buona immagine offerta di una Londra più accogliente e cordiale del solito, nondimeno un tale spirito non è detto che duri a lungo. Ed è ovvio che il volontariato serio richiede un impegno temporale che sia regolare e di lunga durata. In definitiva è legittimo pensare che “il sospetto in merito alla Big Society – come scrive Mar Dejevsky – è che è guidata dal governo e finirà con il riempire i buchi dello Stato”. Detto altrimenti, volontariato e progetto di Big Society servono solo da tappabuchi per le carenze statali.
Oltre quella del destino dei volontari olimpici, un’altra controversia è sorta a proposito dell’invito rivolto dal primo ministro a vendere i beni di proprietà delle amministrazioni locali per ricavarne risorse per la costruzione o l’acquisto di alloggi popolari a favore dei meno abbienti. L’idea è di “vendere le case di valore molto alto per investire nell’edilizia sociale e trovare case per più gente” (Daily Mail, 21 agosto 2012, pag. 8).
A questo proposito, ma anche a motivo di altre situazioni, Boris Johnson, sindaco di Londra, accusa David Cameron di “inerzia istituzionale” (Daily Mail, 16 agosto 2012, pag. 6) e lo invita ad un maggior impegno nel taglio delle tasse e negli investimenti riguardanti le infrastrutture, con particolare riferimento ad un massiccio programma di edilizia sociale, di ponti sui fiumi, di ferrovie, di nuovi aeroporti (specie nel sud-est). Non a caso il primo cittadino londinese è un serio aspirante fra i tories per prendere il posto di Cameron nel prossimo futuro. Intanto Boris rimprovera a David di non aver capitalizzato a sufficienza il successo delle Olimpiadi londinesi, che invece andrebbero meglio sfruttate.
Intanto il debito totale calcolato per ogni cittadino britannico è il più alto fra tutte le maggiori nazioni, eccezion fatta per l’Irlanda ed il Giappone (Daily Mail, 16 agosto 2012, pag. 14). Allo stesso tempo è reputata come “una disgrazia nazionale” il dato di fatto che “tanta gente anziana che ha lavorato duramente per tutta la loro vita sia costretta a vendere la propria casa per pagarsi l’assistenza”. Il medesimo quotidiano londinese ha accertato che nell’anno precedente (2011) siano stati più di 24.500 i soggetti indotti a cedere le proprie abitazioni per pagare i loro conti dell’assistenza a lungo termine (Daily Mail, 16 agosto 2012, pag. 1). Cameron intenderebbe trovare una soluzione mettendo in atto il piano dell’economista Andrew Dilnot, che prescrive un’assicurazione obbligatoria per i lavoratori, onde coprire almeno quanto necessario, fino alla soglia di 35.000 sterline. Detto altrimenti, coloro i quali devono andare in una residenza di cura a lungo termine devono pagare l’intero ammontare necessario se il loro reddito annuo supera la soglia di 23.250 sterline. Qualche ministro, tuttavia, vorrebbe alzare la soglia sino a 35.000 sterline.
Non pare abbia preso consistenza l’idea di fare degli investimenti sociali il terzo pilastro del settore sociale, insieme con le azioni filantropiche e le provvidenze governative. Lo stesso dicasi per i Social Impact Bonds, per l’Investment and Contract Readiness Fund e per Community First (fondo di azione sociale da attivare attraverso gruppi di vicinato, specialmente in contesti sottoposti a forte deprivazione). Pure il programma per gli organizzatori di comunità, che addestra e sostiene 5.000 soggetti, non risulta avviato. Insomma nonostante la sua dichiarazione del 19 luglio 2010, riportata da The Independent del 20 luglio 2010: “my great passion is building the Big Society”, David Cameron non sembra in grado di andare molto al di là di semplici dichiarazioni d’intenti.
La società “post-sociale”
Quasi in contemporanea con la proposta di una Big Society è giunta tra le mani dei sociologi un’accorta presa di posizione di Alain Touraine, sempre attento alle dinamiche ed ai movimenti in atto: si tratta del volume dal titolo Après la crise, edito da Seuil proprio nel 2010 e tradotto in Italia nel 2012 (presso l’editore Armando di Roma). Il taglio dato dal sociologo francese al suo esame puntuale ed approfondito coglie abbastanza nel segno, parlando di un superamento della società industriale, della crisi della società capitalista, della decomposizione della vita sociale, delle logiche del profitto messe in azione contro i diritti: sono altrettanti capitoli del suo testo. La seconda parte è più propositiva e fa intravedere una “società possibile”, “post-sociale”, con la “comparsa di attori non sociali” e la nascita di “nuove istituzioni sociali e politiche”, insomma un vero e proprio “ritorno al sociale”, che sembra fare il verso alla Big Society cameroniana ma procede di fatto lungo un’altra e ben diversa strada. “La nuova società vive una separazione sempre più profonda tra un’economia che si organizza a livello mondiale e istituzioni e forme di organizzazione sociale che sono indebolite nella loro capacità di controllare il sistema economico” (pag. 115). Sta appunto qui la differenza con la Big Society, in cui il sistema economico non è affatto messo in discussione ma si invoca una soluzione appena palliativa, che scagioni il complesso di interessi transnazionali dei potentati finanziari, fonte originaria della crisi. Il fatto nuovo è presto delineato: “per la prima volta nella storia, il mondo della produzione, delle banche e delle tecnologie è separato dal mondo degli attori” (pag.115). Il risultato più significativo di tutto ciò è che “gli attori non possono essere definiti come attori sociali, perché la loro legittimità deriva da piani più elevati” (pag. 116), che ovviamente non sono controllati e controllabili. Ecco dunque che Touraine invoca, con Hannah Arendt, il diritto degli attori sociali di avere il “diritto di avere diritti”.
Ma ancor più perspicace è l’approccio tourainiano nel confronto fra le riforme britanniche e le rivoluzioni francesi. Le prime sono in continuità con l’esistente, le seconde hanno invece un carattere di rottura, di discontinuità. E, soprattutto, appare lucidissima l’analisi dei rischi insiti nelle due diverse realtà: “la continuità permette di distinguere tra ciò che bisogna cancellare e ciò che occorre conservare del passato, ma essa può essere resa possibile solo dall’efficacia di un sistema politico capace di evitare il tutto o niente, sempre troppo costoso. La rottura ha come inconveniente più importante di far facilmente perdere di vista la trasformazione da realizzare. Può anche condurre alla creazione di un potere assoluto che rompe i legami con il passato, ma al prezzo della dittatura esercitata da chi guida questa rottura, si tratti di un individuo o di un partito” (pag. 119).
Evidente è inoltre la contrapposizione, se si vuole, fra Touraine e Cameron, lì dove si legge: “bisogna che dappertutto non si formino solamente dei simpatici gruppi di vicinato o di riunioni familiari in cui i cugini lontani imparano a conoscersi, ma gruppi di protesta e nello stesso tempo di affermazione di principi universali” (pag. 146). Insomma la formula della Big Society non risolve, non allontana la crisi, in quanto occorre un impatto più forte, dirompente nella sua tensione verso “i diritti umani, la giustizia e la libertà” (pag. 147).Sul piano operativo il sociologo francese indica poi due forti leve di cambiamento, la scuola ed il lavoro (pp. 148-150), e rinvia a Robert Putnam di Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community (Simon & Schuster, New York, 2003; ed. or. 2000) e di Better Together: Restoring the American Community (Simon & Schuster, New York, 2003), scritto insieme con Lewis Feldstein e Dan Cohen. Ma si potrebbe anche citare la forte spinta comunitarista che Amitai Etzioni (Law in a New Key: Essays on Law and Society, Quid Pro Books, New Orleans, 2010) va proponendo da più anni, con tante pubblicazioni ed in diversi luoghi. Per concludere, in Touraine, Putnam ed Etzioni la musica è tutt’altra rispetto ai clangori della Big Society ed anche della Bigger Society.
Fondamenti di una teoria della religione diffusa
Fondamenti di una teoria della religione diffusa
di Roberto Cipriani (Università Roma Tre)
- Premessa
La sociologia non può fare a meno di dati empirici o di un contributo teorico per interpretare le informazioni che raccoglie. Si parte solitamente dalla teoria (Abrutyn 2016: 1-15) per poi valutare l’esito del lavoro svolto sul campo. Ma, nel nostro caso, il percorso scelto, non meno arduo e non meno scientifico, si muove nella direzione opposta. Infatti, solo dopo aver raggiunto il culmine del tentativo di delineare una teoria che appare applicabile ai casi specifici esaminati, questa può essere estesa ad altre aree di fenomeni simili a quello della religione diffusa.
- La costruzione di una teoria
L’elaborazione di una teoria, in questo caso sociologica, comporta la preparazione e la definizione di alcune affermazioni come tessuto connettivo, ordito e trama dell’intera proposta teorica (Beckford 2011). Non si può quindi pensare in termini di generalità e nemmeno avvalendosi di espressioni puramente ipotetiche, poiché l’intero impianto teorico richiede basi solide, inequivocabili e chiaramente presentate.
Ciò significa che una teoria dovrebbe mirare principalmente a fornire una particolare illustrazione della realtà. Questo dovrebbe garantire che una teoria sia meglio definita, più omogenea e, quindi, meglio in grado di competere su un piano di parità con altre e diverse proposte teoriche.
La ricerca della compattezza assertiva non può avvenire a scapito del riferimento alla realtà empirica. Il circolo virtuoso tra teoria e dati dovrebbe rimanere sempre in vigore. Occorre, quindi, trovare un insieme di affermazioni di alto livello, che non sono del tutto virtuali, cioè estranee alle situazioni di fatto. Il collegamento a un riferimento fenomenologico è obbligatorio perché è da lì che le nozioni essenziali danno avvio alla teoria.
Per elaborare una prospettiva teorica di base, l’astrattezza è effettivamente necessaria, anche se non del tutto. Essa trae benefici anche se, a volte, solo limitati, da altre condizioni. Richiede, ad esempio, che le affermazioni contenute in una teoria siano anche esplicite, comprensibili, senza riserve, senza arrière pensée, insomma, prive di escamotages che facilitino i cambiamenti di direzione durante il processo teorico-interpretativo.
La struttura di una teoria dovrebbe, quindi, evitare il generico, pur continuando a mantenere un livello di generalità tale da impedire di trasformare ciò che è stato faticosamente prodotto in una serie di fallimenti, dovuti semplicemente, forse, a dettagli eccessivamente minuti, inclusi nel quadro teorico complessivo ma che non riescono a reggere quando applicati a situazioni molto complesse e imprevedibili. La generalità è utile, quindi, se mantiene un livello sufficientemente alto da incorporare, minimizzare e rendere irrilevanti alcuni dettagli minori, di importanza trascurabile rispetto alla formulazione teorica nel suo complesso.
Inoltre, una teoria non deve cedere a formule rapsodiche estemporanee, quelle isolate dalle altre, scollegate e disorganizzate rispetto al quadro complessivo. Una sequenza solida e precisa di postulati (proposizioni che possono essere considerate “ovvie”), che indicano le relazioni che ne derivano ed individuano collegamenti, appare, quindi, del tutto efficace. Una teoria è tale in quanto è ben coordinata internamente, organizzata sulla base di legami precisi, evidenti o opportunamente indicati. Così, il postulato teorico appare come un meccanismo ben funzionante, senza troppi intoppi, ben registrato nel suo complesso e calibrato per quanto riguarda le sue caratteristiche.
Infine, una teoria valida e plausibile potrebbe essere costruita attraverso espressioni astratte che dovrebbero, tuttavia, rimanere intelligibili, orientate secondo uno schema generale, le cui parti siano correlate tra loro a livello logico, in modo da poter fornire le migliori soluzioni possibili a livello metodologico. Si potrebbe anche dire che una teoria è una costellazione contenente una miriade di stelle, ciascuna al proprio posto, in modo tale da costituire una configurazione unica che non può essere confusa con nessuna altra. Tuttavia, ogni stella occupa una posizione ben definita, ad una certa distanza da tutte le circostanti, pur mantenendo una forte relazione con tutte. Lo spostamento (o scomparsa) di una di queste stelle influenzerà necessariamente ciascuna delle altre componenti dell’intera costellazione. Per lunghi periodi di tempo, si può assistere a mutazioni che appaiono minime all’inizio, anche se le conseguenze possono rivelarsi macroscopiche nel lungo periodo. Allo stesso modo, in teoria, le singole affermazioni giocano un ruolo contemporaneamente definitorio e regolativo. Ogni affermazione teorica è plasmata in modo tale da preservare la sua natura organica rispetto al resto dell’intera teoria, per un tempo tendenzialmente lungo.
Una teoria simile sarà in grado di spiegare i fenomeni in virtù della sua fondamentale compattezza.
Va sottolineato che una teoria è tipicamente un insieme in grado di coprire quasi tutte le formulazioni teoriche di tipo generale. Questo è il modo in cui una teoria dovrebbe essere trattata, prestando attenzione ad ogni fase delle diverse fasi della sua costruzione.
Prima di tutto, ci sono i termini da usare; queste sono le vere e proprie cellule di base dell’intera struttura. Data la loro natura preliminare, è essenziale fornire una definizione precisa per ciascuna di esse fin dall’inizio. Poi bisogna usare questi termini, definiti in precedenza, con la massima precisione, per formulare affermazioni che possono avere contenuti diversi. Le affermazioni possono essere ipotetiche (senza, tuttavia, confonderle con le ipotesi di lavoro più classiche) o discriminatorie (dove un elemento è prevalente, un altro apparterrà alla minoranza, o se un certo elemento è marginale un altro sarà invece chiaramente identificato).
Dopo aver chiarito i termini iniziali e stabilito le affermazioni di base, si deve passare ad una serie di argomenti, che coinvolgono una serie di ragionamenti successivi. È forse la fase argomentativa la più delicata di tutti i processi utilizzati per costruire la teoria. Si compone di semplici proposizioni, o di assunzioni o presunzioni, di premesse di tipo introduttivo, ma anche di veri e propri postulati specifici (proposizioni che sono consentite senza dover essere dimostrate), o di assiomi (principi universalmente accettati). Avvalendosi di tutto questo insieme razionalizzante si arriverà, alla fine, alle conseguenze, ai precipitati ultimi, alle derivazioni, alle conclusioni, ai teoremi (proposizioni da provare attraverso l’inferenza), in breve, un insieme di caratteristiche volte a fornire una spiegazione dei fenomeni esaminati sulla base della teoria.
Vi è, tuttavia, un inevitabile corollario: la teoria deve essere sottoposta a condizioni applicative specifiche, cioè ad affermazioni, preferibilmente provvisorie in questo caso, che dovrebbero aiutare a stabilire, appunto, i criteri di usabilità della teoria.
Il nostro sforzo di costruzione della teoria, tuttavia, non finisce qui. Occorre effettuare controlli, per conferire un alto livello di credibilità all’intera teoria. In primo luogo, la teoria non deve contenere contraddizioni, ambivalenze o ambiguità. Dovrebbe coprire una vasta gamma di fenomeni (espungendo, allo stesso tempo, l’eccessiva astrattezza), mantenere una prospettiva piuttosto generale (come la previsione di numerose applicazioni, contesti diversi, prove di stabilità), tendere verso un certo grado di precisione (con riferimento obbligatorio a luoghi e tempi almeno) e infine dovrebbe avvalersi di un grado di condizionalità possibilmente casuale e vago (senza entrare in descrizioni dettagliate). Non è facile contare sulla qualità costantemente elevata e conclusiva di ciascuno dei passi qui elencati, ma occorre custodire con fermezza almeno l’essenziale del difficile compito di costruzione teorica.
- Un approccio iniziale alla teoria della religione diffusa
Dobbiamo determinare quali termini usare per iniziare a costruire la teoria della religione diffusa. Partiamo dal termine religione. Quest’ultimo è così ampio, inclusivo e variegato che implica un trattamento specifico per stabilire confini, significati ed usi. Inoltre, pure la categoria di religiosità ha bisogno di essere trattata in modo analogo, anche se offre il vantaggio di essere più “localizzata”, cioè empiricamente rilevabile sulla base di comportamenti reali. Simmel (1997), che ha messo a confronto questo termine con la religione, ha definito quest’ultima come storicamente costituita in organizzazioni religiose (principalmente la Chiesa istituzionale). Ma la nozione di Simmel ci porterebbe un po’ fuori strada dalla nostra prospettiva fondata empiricamente perché presupporrebbe l’esistenza di una data naturalezza nell’atteggiamento religioso, supposta come presente a livello universale.
Il nostro concetto di religione diffusa è affrontato in un contesto che riguarda i riti, i gesti, la comunicazione, la percezione, l’emozione, i valori di riferimento, l’uso della preghiera, il richiamo ai simboli, le distinzioni tra bene e male, il senso della vita e della morte, le azioni quotidiane, il lavoro e le esperienze familiari. All’interno di questa vasta gamma di orizzonti tematici, la religione diffusa agisce, a volte esplicitamente, a volte implicitamente, come filo conduttore.
Cercheremo, tuttavia, di fornire una definizione iniziale approssimativa, nonostante i limiti che essa comporta. Una teoria basata sui dati, cioè fondata sull’indagine empirica, rischia di essere piuttosto debole per quanto riguarda la durata o l’applicabilità. Sono necessarie più ricerche e, quindi, più operazioni di bilanciamento e calibrazione, per “registrare” ogni dettaglio. Non è quindi inconcepibile che il primo tentativo di costruire una teoria possa non riuscire a raggiungere un quadro teorico immediatamente affidabile e degno di considerazione. Ancora una volta occorre procedere per tentativi ed errori, puntando però ad obiettivi graduali che sono contemporaneamente cumulativi delle conoscenze precedenti.
È quindi con la massima cautela che va intrapresa e completata una prima proposta teorica. Le affermazioni provvisorie relative alle condizioni applicative della teoria iniziale (per così dire) devono essere semplici e poco numerose, in modo da consentire un’ulteriore facile espansione ed anche cambiamenti (pur minimi) durante i passaggi successivi, in particolare nella predisposizione di nuove proposte. In realtà, la costruzione teorica è un’attività scientifica costante, continua e ininterrotta, svolta con i lavori sempre in corso.
Torna opportuno, quindi, non utilizzare chiarimenti dettagliati e accurati sulle condizioni di applicabilità della teoria proposta. È anche utile parlare di condizionalità generale, non di condizioni specifiche. Per questo motivo ci si deve limitare a poche indicazioni.
La costruzione della teoria si basa, in parte, su un insieme di significati già individuati da Robert King Merton (1949) in Teoria sociale e struttura sociale, in particolare per quanto riguarda l’analisi di concetti (o termini) e di interpretazioni post factum (considerate successive a ricerche empiriche), di generalizzazioni empiriche (raggiunte grazie allo studio sul campo), di derivazioni (come risultato di corollari presenti in proposizioni precedentemente formulate e dimostrate), di codificazioni (che attraverso l’induzione dal particolare permettono di enunciare proposizioni di carattere generale) e infine di teoria in senso stretto, costruita su proposizioni che costituiscono qualcosa di sistematico.
Tutto ciò genera conseguenze da confrontare con i dati fattuali, chiudendo così il circolo virtuoso, partito dall’analisi empirica, che ha portato alla teoria e da lì di nuovo ai dati raccolti. Questo è il percorso seguito fino ad oggi per formulare la teoria della religione diffusa, che si differenzia peculiarmente dal paradigma perché non si ferma a livello di linguaggio interamente metaforico ma si rivolge più direttamente alla realtà sociale stessa, fondamento essenziale della teoria, suo punto di partenza, suo fondale, suo scenario.
La religione diffusa è una teoria in senso proprio perché deriva la sua forza propulsiva da un insieme di proposizioni interdipendenti in grado di produrre conseguenze che possono essere confrontate con le informazioni empiriche disponibili. Va sottolineato che non è prevista alcuna ipotesi di lavoro preliminare, ma essa si concretizza durante la costruzione della teoria, facendo ruotare l’analisi e le successive interpretazioni intorno a concetti sensibilizzanti, prospettiva suggerita da Blumer (1954). Tali concetti chiave non dovrebbero essere definiti prima dell’inizio dell’indagine, ma dovrebbero nascere solo alla fine del lavoro sul campo e quindi derivare da sollecitazioni concrete emergenti durante le operazioni che portano all’acquisizione dei dati in questione. Pertanto, le ipotesi non hanno senso, almeno entro certi limiti, mentre le prove empiriche vengono prese in piena considerazione.
Come misura preliminare e provvisoria, si cerca di giungere a conclusioni che appaiono più utili alla costruzione della teoria. Seguendo un excursus il più ampio e approfondito possibile, si può tentare di raggiungere una sintesi teorica di ciò che va sotto il nome di religione diffusa. A questo punto, i dati forniti devono apparire scientificamente affidabili o sufficienti, almeno per corroborare il modello teorico di riferimento.
In primo luogo, vanno identificati gli elementi fondamentali, vale a dire i concetti di base, i termini generali primari, che in questo caso sono, in ordine di priorità, cultura (come appartenenza culturale), religione e, naturalmente, diffusione. Come si sa bene, ci sono molte definizioni di cultura e religione. Tuttavia, sembra più utile in questo caso non scegliere una definizione specifica, per allargare il più possibile la prospettiva empirica. Il concetto di diffusione sarà più chiaro durante la continua discussione sulla teoria della religione diffusa.
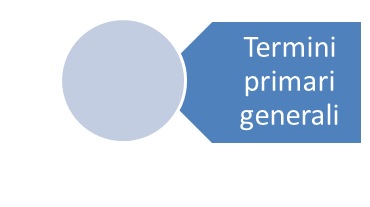
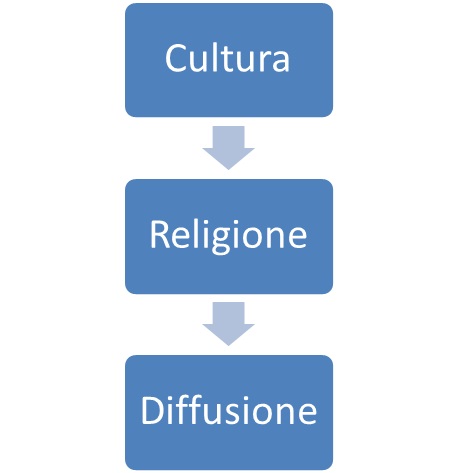
Seguiranno poi i termini particolari primari, identificabili come socializzazione religiosa e inculturazione di valori (transizione/trasmissione di valori). L’inculturazione dei valori culturali nei bambini da parte dei genitori si basa su una rete di etica, tradizioni, principi, valori, idee ed elementi spirituali che, di fatto, gettano le basi di quello che sarà poi l’individuo a contatto con il sistema educativo; in altre parole, viene intenzionalmente indirizzato dai suoi più cari ad inserirsi e sapersi muovere nella società e quindi ad affrontare le sfide della socializzazione interpersonale al di fuori dell’ambiente familiare e più in particolare con i suoi coetanei e con gli adulti che svolgono il ruolo di educatori (a scuola, nel tempo libero, nelle attività religiose e nelle forme di comunicazione sempre più globalizzate).
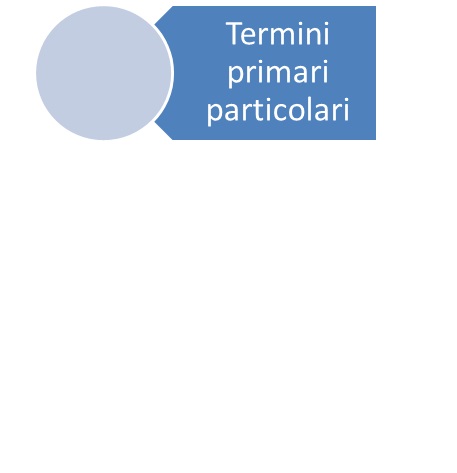

I termini particolari secondari sono credenza e appartenenza o adesione religiosa. La resilienza della credenza religiosa sembra più forte nelle grandi religioni in termini di aderenti. I periodi di crisi di appartenenza permettono anche ad altri gruppi di nascere, svilupparsi e diffondersi. Nelle religioni a diffusione locale si può registrare una crescita cospicua a causa, ad esempio, di alcune contingenze storiche. A volte i mass media favoriscono questo tipo di crescita dell’appartenenza.


Per quanto riguarda i termini propositivi, si può dire che se c’è una religiosità iniziale riguardo alla sensibilità verso il sacro, allora, molto probabilmente, troveremo qualche forma di partecipazione ai riti e che un soggetto che non è orientato alla religione difficilmente presterà attenzione alle celebrazioni religiose. La tendenza principale è quella di una minore rilevanza delle strutture religiose.
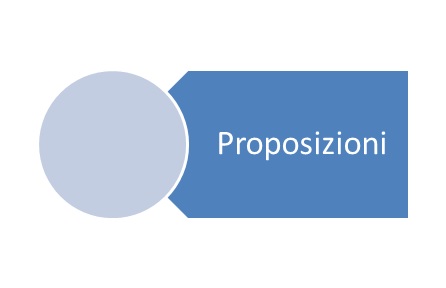
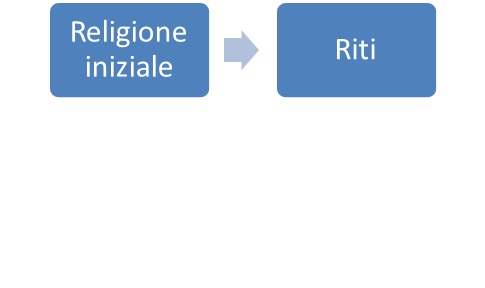
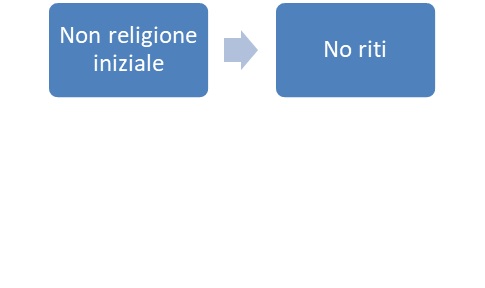

Quindi, la natura di questo tipo di espressione religiosa sembrerebbe essere più individuale che istituzionale, secondo la teoria jamesiana della dicotomia tra religione individuale e istituzionale (James 1961; Royce 1912). Con il passare dei secoli e dei millenni, si trovano nella religione istituzionale non solo segni di indebolimento ma anche di rafforzamento dovuti a particolari situazioni storiche, ma è improbabile che una religione sufficientemente istituzionalizzata possa improvvisamente perdere la sua consistenza o la sua attrattiva.

Infine, ma non meno importante, la religione diffusa può occupare lo spazio lasciato libero a causa di delusioni e disincanto per la perdita di credibilità di precedenti influenze: ideologiche, politiche, lavorative, culturali, economiche, sessuali, sportive e non solo. Così, la religione diffusa assume il ruolo di sostituto funzionale di altri riferimenti attitudinali e comportamentali.
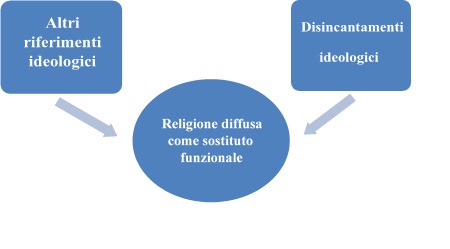
Per quanto riguarda gli argomenti, si può affermare che, nella misura in cui una certa religiosità individuale è all’opera, si nota l’effetto specifico della religione diffusa in termini di credenza, di un significativo tasso di pratica religiosa (in particolare sotto forma di preghiera, privata e/o collettiva a seconda dei casi) e di un maggior grado di impegno sociale e religioso nella vita quotidiana, che differisce a seconda dell’età (l’impegno religioso e sociale è meno pronunciato e meno evidente tra i giovani).
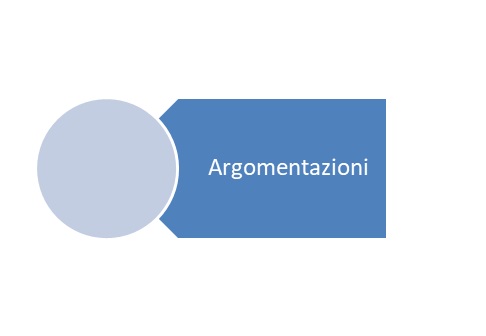
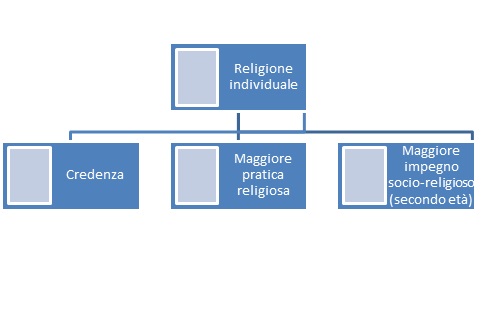
In questo contesto, un ruolo chiave è giocato dalla convinzione ricevuta attraverso la socializzazione e l’inculturazione da parte delle famiglie e delle organizzazioni religiose e/o che si sono sviluppate individualmente. Ma è improbabile che la guida ricevuta attraverso l’insegnamento e l’indottrinamento religioso sia direttamente correlata solo ad atteggiamenti e comportamenti alquanto abituali e consolidati. Le ragioni e le motivazioni utilizzate dagli attori sociali sono solitamente di natura molto complessa e mai generate da un’unica matrice. Per quanto riguarda un maggiore impegno socio-religioso, possono intervenire motivazioni articolate e non facilmente definibili, così come influenze non necessariamente di natura religiosa.
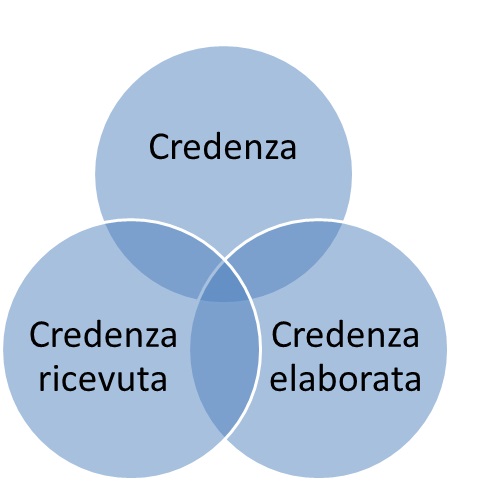

La pratica più diffusa e sviluppata sembra essere la preghiera, molto più che la partecipazione a riti e celebrazioni. Naturalmente, ci sono differenze significative tra la preghiera personale, privata e silenziosa e la preghiera pubblica, collettiva e organizzata.
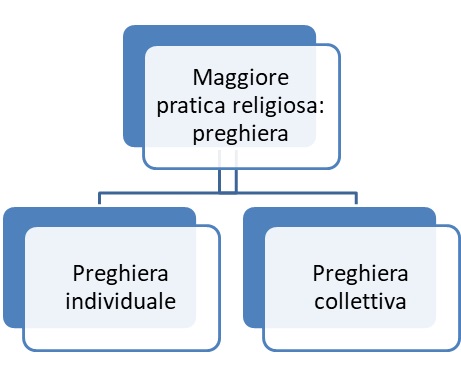
Un altro fenomeno comune è la crescente religiosità, pratica e fede nell’età adulta matura o comunque nei periodi successivi all’età giovanile, confermata dai risultati di molte indagini empiriche. Ma nella maggior parte dei contesti, le differenze a seconda dell’età rimangono le più forti.

Infine, per quanto riguarda l’applicabilità (o le condizioni) della teoria della religione diffusa si associa all’esistenza di un quadro complessivo particolarmente favorevole, attribuibile a ragioni storiche e sociologiche. Di particolare importanza è la presenza di una data religione maggioritaria, prevalente su altre, con un certo effetto di enfatizzazione nazionalistica (di valore identitario simbolico, anche se adattato a situazioni problematiche, che non sono del tutto facilitanti e che possono quindi portare a risultati alquanto differenziati).
Resta evidente che questo tipo di discorso teorico ha un carattere di larga massima e che le eccezioni e le modifiche sono prevedibili e possono essere date per scontate. In altre parole, la casistica delle religioni diffuse dà origine ad un ampio spettro di possibilità empiricamente rilevabili.
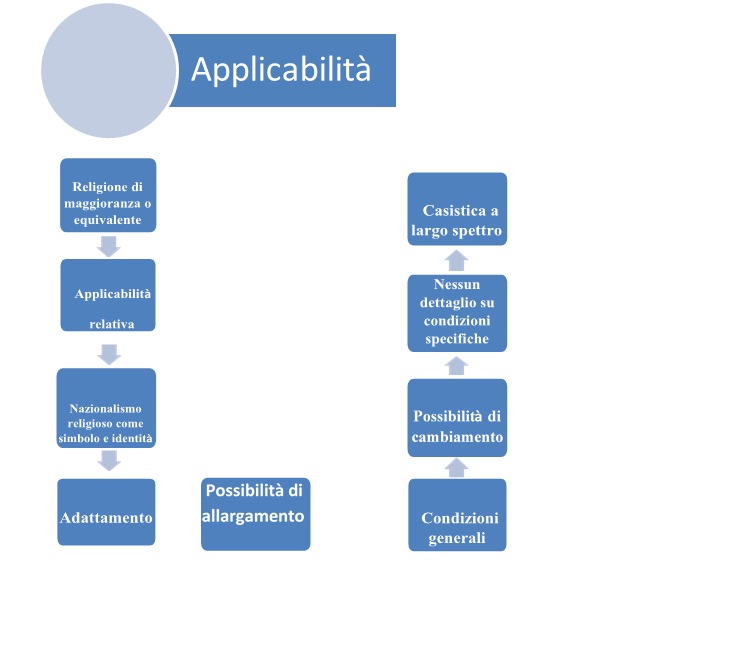
Non si dovrebbe eccedere nel fornire dettagli sulle procedure di verifica, ma lasciare il campo aperto a metodi sia quantitativi che qualitativi e misti (quest’ultima soluzione è la più desiderabile, dato il contenuto problematico delle indagini da condurre). La durata dell’applicabilità della teoria stessa è soggetta a limitazioni e aggiustamenti. Ciò vale anche per le dimensioni quantitative e qualitative che non possono essere definite a priori.
- Conclusione
La formulazione di una teoria sulla religione diffusa ha un carattere molto aperto, in attesa di nuove e stimolanti conoscenze scientifiche, di una cooperazione tra studiosi di fenomenologia religiosa, di ulteriori contributi alla conoscenza della realtà sociale e religiosa, sempre più difficile da leggere, se non si supera la prospettiva tradizionale di un unico ed esclusivo approccio sociologico.
Innanzitutto, i fondamenti della religione diffusa vanno chiariti a partire dalla sua fonte, cioè la socializzazione, e dall’analisi del ruolo chiave dei valori. In seguito, è necessario indagare in modo approfondito e scrupoloso le influenze che le religioni diffuse hanno nel mondo. In un quadro globale, può verificarsi una sovrapposizione tra valori e diritti umani; se presi come tali, i valori possono anche diventare regole normative, una sorta di criteri di validazione.
Una verifica empirica della religione diffusa, analizzando la pratica in diverse religioni del mondo, non è facile. Alcuni tentativi precedenti (Inglehart 1977, 1997; Inglehart, e Norris 2004) sono stati più volte fortemente criticati. Si è quindi scelto un caso emblematico, particolare e specifico: Il cattolicesimo come religione diffusa in Italia, a partire dall’intuizione originaria di qualcosa di rilevante nel rapporto tra religione e politica degli anni ’70 e ’80; i contenuti e le tendenze della situazione italiana possono fornire suggerimenti, linee guida, concetti chiave e prassi consolidate per indagare la religione diffusa anche in altri paesi o aree in cui una religione è dominante. In ogni caso, il focus della religione diffusa è la presenza di valori (e la loro diffusione). In particolare, la teoria della religione diffusa rappresenta una risposta critica alla presunta “religione invisibile” ed all’inevitabilità della secolarizzazione. Per concludere: forse la dimensione più affidabile e non ancora del tutto esplorata della religione diffusa è il continuum della preghiera attraverso i secoli e le religioni, ininterrotto nel tempo e nello spazio, nelle credenze e nelle pratiche.
Bibliografia
Abrutyn 2016: S. Abrutyn (ed.), Handbook of contemporary sociological theory, Cham 2016.
Beckford 2011: J. Beckford, Social theory & religion, Cambridge 2011.
Blumer 1954: H. Blumer, What is wrong with social theory?, “American Sociological Review”19 (1), 1954, pp. 3–10.
Inglehart 1977: R. Inglehart, The silent revolution, Princeton 1977; ed. it., La rivoluzione silenziosa, con una nota metodologica di Renato Mannheimer, Milano 1983.
Inglehart 1997: R. Inglehart, Modernization and post-modernization: Cultural, economic and political change in 43 societies, Princeton 1997; ed. it., La società postmoderna. Mutamento, ideologie e valori in 43 paesi, Roma 1998.
Inlehart, Norris 2004: R. Inglehart, P. Norris, Sacred and secular. Religion and politics worldwide, Cambridge 2004; ed. it., Sacro e secolare. Religione e politica nel mondo globalizzato, Bologna 2007.
James 1961: W. James, A study on human understanding. Varieties of religious experience. New York 1961; ed. it., Le varie forme dell’esperienza religiosa. Uno studio sulla natura umana, Brescia 2009.
Merton 1949: R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, I, II, III. Glencoe, IL 1949; ed. it., Teoria e struttura sociale, Bologna 2000, 3 volumi.
Royce 1912: J. Royce, The sources of religious insight, New York 1912.
Simmel 1997: G. Simmel, Essays on Religion, New Haven, CT 1997; ed. it., Saggi di sociologia della religione, prefazione e cura di R. Cipriani. Roma 1993.
Termini generali primari
Termini
particolari primari
Termini particolari secondari
Proposizioni Argomenti Applicabilità
(condizioni)
Cultura come appar-tenen-za
Socializza-zione religiosa
Credenza Se vi è una religione inziale ci può essere una parteci-pazione ai riti
Dalla religione iniziale derivano credenza, maggiore pratica, maggiore impegno socio-religioso, secondo le età
Religione di maggioranza o equivalente
Religione Inculturazio-
ne dei valori (transizione/trasmissio-ne dei valori)
Apparte-nenza o adesione ad una religione
Se non vi è una religione iniziale non può esserci neancheuna parteci-pazione ai riti
La credenza può essere solo ricevuta o ricevuta e sviluppata o solo sviluppata
Applicabilità relativa
Diffusione Non
rilevanza delle strutture religiose
Nessuna correlazio-ne diretta fra credenza (o non credenza)e atteggia-menti e compor-tamenti
Nazionalismo religioso come simbolo e identità
Terminigenerali primari
Termini primari particolari
Termini secondari particolari
Proposizioni Argomenti Applicabilità
(condizioni)
Religione individuale versus religione istituzionale
La religione diffusa può derivare da una non religione iniziale: come sostituto funzionale di altri riferimenti ideologici
La religione diffusa può derivare da una non religione iniziale: come sostituto funzionale di altri riferimenti ideologici; e può svilupparsi da disincanti ideologici di vario genere
La pratica principale può essere la preghiera indivduale e/o collettiva
Un maggiore impegno socio-religioso, diverso secondo le età, può derivare da motivazioni complesse
Un maggiore impegno socio-religioso, diverso secondo le età, può derivare da influenze non religiose
Adattamento
Possibilità di allargamento
Possibilità di cambiamento
Condizioni generali
Nessun dettaglio su specifiche condizioni
Casistica a largo spettro
From Atheists to Nones: An Updated Perspective

Carnavalet Museum – Paris
On the 8th of June 1794 (the 20th of Prairial according to the calendar of the
French Revolution, Pentecost Sunday by the Roman Catholic liturgical calendar),
at Les Tuileries, in Paris, Maximilien de Robespierre celebrated the
“Festival of the Supreme Being” (symbolized by a tree) condemning atheism,
embodied in a straw effigy and burnt along with others representing Ambition,
Selfishness and False Modesty. At the same time, homage was paid to
an incombustible statue indicating Wisdom. The Hymn to the Supreme Being,
composed by the poet Thédore Desorgues and set to music by François-
Joseph Gossec, was sung. The first article of the new revolutionary catechism,
approved on the 7th of May (18th of Floréal) 1794, recognised “the existence
of the Supreme Being and the immortality of the soul”. Robespierre, on that
occasion, said that “the idea of a Supreme Being and of the immortality of the
soul acts as a constant reminder of justice” (Oeuvres de Maximilien Robespierre,
Société des études robespierristes, Paris, 1961–1967, x, pp. 443–462). The republican
celebrations replaced Catholic feast days, the cult of the Supreme Being
the atheist one of Reason.
It was precisely upon the topic of the immortality of the soul, elicited by
Robespierre, that a few decades later Ludwig Feuerbach dwelt, in a juvenile
text if his dated 1830 Gedanken über Tod und Unsterblichkeit (Thoughts on
Death and Immortality), denying immortality (and, as a result, losing his university
teaching post). Like Auguste Comte, his contemporary, he envisaged
a cult of humanity, that is, a “Religion of Humanity” whereby, due precisely
to atheism, humanity itself became the object of a meta-individual kind of
veneration, leading to the disappearance of Christianity (On Philosophy and
Christianity, 1839), the essence of which (The Essence of Christianity, 1841) was
believed to consist in a simple projection of man upon God. In short, humanism
became a form of atheism.
The topic was resumed quite some time later and involved a series of theological
debates, worthy of considerable attention and which, especially in
Germany, led to fecund exchanges between some theologians/philosophers
(Bultmann, Barth, Moltmann, Ratzinger) and a limited number of sociologists
(Adorno, Horkheimer, Habermas). These discussions are reported, in part,
in an invaluable little volume called Atheismus in der Christenheit (Atheism
in Christianity), Ausaat Verlag, Wuppertal, vol. i, 1960, 1970, by theologianphilosopher-
sociologist Klaus Bockmül. For a more thorough discussion of this
issue, M.J. Buckley’s At the Origins of Modern Atheism, Yale University Press,
New Haven, ct, 1987, is very helpful.
The Catholic Church too, among others, made an effort to address its inadequate
knowledge of atheism. It did so, above all, by setting up a Secretariat
for Non-Believers (later abolished) which, in 1969, organized, in collaboration
with the Giovanni Agnelli Foundation, an international symposium on belief
(in actual fact, on non-belief, as the proceedings testify), which remains a oneoff
episode in the history of the sociology of religion seeing that it managed
to bring together scholars of the calibre of Bellah, Cox, Daniélou, Glock, Luckmann,
Marty, O’ Dea, Parsons, Wilson; the proceedings by R. Caporale and A.
Grumelli (eds.) were published as The Culture of Unbelief, by the University
of California Press, Berkeley, 1971. A certain degree of continuity consisted in
a symposium held at the Pontificia Università Urbaniana (Potifical Urbanian
University) on the 13th and 14th October 1978, the papers of which were published
in Diagnosi dell’ateismo contemporaneo (Diagnoses of Contemporary
Atheism), Urbaniana University Press-Roma, Paideia Editrice-Brescia, 1980.
It was precisely in 1980 that the Istituto Superiore per lo Studio dell’Ateismo
(Higher Institute for Studies of Atheism), a section of the Urbanian University,
organized another international congress; in this case, too, the participants
were illustrious: Cottier, Frossard, Ferrarotti, Kuhlmann, Miccoli, Moltmann,
Rahner, among others: the volume containing the proceedings consists in 786
pages: Evangelizzazione e ateismo (Evangelization and Atheism), Pontificia
Universitas Urbaniana-Roma, Paideia Editrice-Brescia, 1981.
Meanwhile, sociological analysis appeared to be wanting. Proof of this
lies in the fact that in the complete bibliography covering the period up
to the mid-1980s, by A.J. Blasi, M.W. Cuneo, Issues in the Sociology of Religion.
A Bibliography, Garland Publishing, New York-London, 1986, of the
3582 titles listed, only 34 (less than 1%) were classified under the heading
atheism, including the – belated – leading, seminal text by Glenn Vernon
entitled “The Religious Nones: A Neglected Category”, Journal for the Scientific
Study of Religion, 7, 1968, 219–229. Furthermore, the publication of the
book by Christian Chabanis, Dieu existe-t-il? Non, répondent…, Fayard, Paris,
1973, was greeted practically as a major event, presenting the results of a
qualitative research-project investigating atheism in France. Twenty subjects,
divided into four categories, were interviewed: scientific atheists (including
Lévi-Strauss and Morin, who believed atheists to be “whoever realizes that
religion is not found only in what we call religion but exists everywhere”,
p. 90), political atheists (including Aron and Duclos), “sociological” atheists
(a sort of mini-sample of French society, that is, a mother, a farmer, a clerk, a
student, a couple) and humanistic atheists (Ionesco and Garaudy, as well as
other celebrities). The article by Rodney Stark, “Atheism, Faith, and the Social
Scientific Study of Religion” in Journal of Contemporary Religion, 14/1, 1999,
pp. 41–62, appeared many years later.
There remains the above-mentioned initiative of the Catholic Church,
which, after a decade of attention to the issue, was brought to an end at the
beginning of the 1980’s, when the Church decided to abandon its analysis of
atheism, non-belief and indifference: the Secretariat for Non-Believers, established
in 1965, became the Pontifical Council for Dialogue with Non-Believers
in 1988, to be finally merged, in 1993, with the Pontifical Council for Culture. Of
the former interest in cognisance of atheism very little remained.
However, the phenomenon began to assume significant sociological and
statistical proportions. More than ever before, the question of relations with
the world of science emerged and was addressed thanks to the courageous endeavours
of Achille Ardigò and Franco Garelli in Italy in 1989, documented in
the book Valori, scienza e trascendenza. Una ricerca empirica sulla dimensione
etica e religiosa fra gli scienziati italiani (Values, Science, and Transcendence.
An Empirical Research on Ethical and Religious Dimension of Italian Scientists),
Edizioni della Fondazione Agnelli, Turin, 1989, in particular pp. 47–219.
The survey, with 350 scientists interviewed, and availing of sophisticated statistical
techniques, highlighted the fact that almost half of the sample’s interviewees
(46.7%) held atheistic-agnostic views.
It is to Robert C. Fuller that we owe the diffusion of the Spiritual, But Not
Religious idea, drawn from the book by the same name, whose subtitle was
Understanding Unchurched America, published by the Oxford University Press,
New York, in 2001 and later circulated on the web in 2003 on the Oxford Scholarship
Online platform.
As to scientists themselves, the case that created the greatest stir was Four
Horsemen of New Atheism, whose most renowned representative was Richard
Dawkins, author of The God Delusion, Houghton Mifflin, Boston, 2006, and
sponsor of various critical analyses against religion, based on a perspective declared
to be exclusively scientific but considered “controversial” and, in turn,
subjected to a number of different objections, voiced by even by some atheistic
scientists. In 2008, Dawkins backed a publicity campaign posted on publictransport
vehicles in London, bearing the following slogan: “THERE’S PROBABLY
NO GOD. NOW STOP WORRYING AND ENJOY YOUR LIFE”. The Christian
Democrat Party, availing of the same tools, retorted: “THERE DEFINITELY IS A
GOD. SO JOIN THE CHRISTIAN PARTY AND ENJOY YOUR LIFE”. Again, this
time in 2011, during the census, the British Humanist Association published
the following: “IF YOU ARE NOT RELIGIOUS FOR GOD’S SAKE SAY SO. IN THE
2011 CENSUS TICK ‘NO RELIGION’”.
But this is no place to reopen and enlarge a dispute that has been going on
for a decade and has already witnessed pretty clear stances. On the other hand,
the option to prefer in this case too, is that suggested by Peter Berger who, in
The Sacred Canopy, Doubleday, Garden City, n.y., 1967, referred to “methodological
atheism”, that is, to the opportunity social scientists have of refraining
from discussing issues such as the existence of God, the immortality of the
soul, the afterlife and other issues typical of religion.
Perhaps it was due to Dawkins’s treatment of the issue that a series of publications
on the topic appeared, beginning with a special number of Approaching
Religion, 2/1, 2011, edited by T. Taira, and R. Illman and entitled “The New
Visibility of Atheism in Europe”, featuring articles by Davie and Zuckerman;
another special on “Non-religion and Secularity” appeared in the Journal of
Contemporary Religion, 27, 1, 2012, with essays by Bullivant, Voas, Cragun and
many others. In 2012, an Open Access journal called Secularism & Nonreligion
appeared thanks to fruitful and qualified cross-Atlantic inter-disciplinary
collaboration.
The literature dealing with atheism has been enriched above all by interventions
by philosophers (K. Walters, Atheism: A Guide for the Perplexed, Continuum,
New York-London, 2010) and theologians (J.A. Corlett, The Errors of
Atheism, Continuum, New York-London, 2010; I.S. Markham, Against Atheism:
Why Dawkins, Hitchens, and Harris are Fundamentally Wrong, Wiley-Blackwell,
Oxford-Malden, 2010; these references to Markham also recall Sam Harris and
the book The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, Norton &
Co., New York, 2004, and Christopher Hitchens, the author of God is not Great:
How Religion Poisons Everything, Emblem, Toronto, 2007). It is also important
to remember reference-points like Daniel C. Dennett, an author whose position
is not distant from that of Harris, as can be evinced from his Breaking the
Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin, New York, 2006.
Close in the wake of these passionate discussions regarding science and religion,
we find a set of three articles featuring debates between Stephen LeDrew
and Jesse M. Smith, entitled “Discovering Atheism”, published in Sociology of
Religion, 74, 4, 2013, pp. 431–470. In the “No religion” section of the same journal
we can read a reprint of an article by Sarah Wilkins-Laflamme (“Toward Religious
Polarization? Time Effects on Religious Commitment in u.s., uk, and
Canadian Regions”, Sociology of Religion, 75, 2, 2014, pp. 284–308, in particular
pp. 293–298): denial of religion has been increasing nearly always between
1985 and 2009 in the areas she examined, with the sole exception of Northern
Ireland; this increase favours a dichotomic trend towards a “secular/religious
divide”.
P. Zuckerman (ed.), Atheism and Secularity, Praeger, Santa Barbara, ca, 2
vols., 2010, marks a veritable turning point in this particular area of sociological
literature, with a significant contribution towards the matter of atheists in
the United States, provided by D.A. Williamson and G. Yancey (There is no God:
Atheists in America, Rowman & Litllefield Publishers, Lanhan, md, 2013). This
study is based on a sample of almost 1,500 self-proclaimed atheists (belonging
to organizations opposed to the “Christian Right” movement), on analyses of
the contents of a variety of documents (newspapers and emails) and on 51
interviews within both religious and irreligious ambits. The outcome is that
this set of atheists does not consider religion an enemy but sees it rather as
a waste of time and a hindrance to progress: their aim is the defeat of the
Christian fundamentalist and traditionalist counterpart. It should be added,
however, that the sample examined does not include less militant, more moderate
atheists.
Another very important contribution to sociological knowledge of atheism
has been provided lately by S. Bullivant and M. Ruse, who edited The
Oxford Handbook of Atheism, Oxford University Press, New York, 2013, a work
that is predominantly philosophical in character, especially in the first half.
In the second part, inter-disciplinary in approach, the essay by A. Keysar and
J. Navarro-Rivera, “A World of Atheism: Global Demographics”, pp. 553–586, is
particularly worthy of mention. Before that, there were volumes like T. Flynn
(ed.), The New Encyclopedia of Unbelief, Prometheus, Amherst, ny, 2007 and
M. Martin (ed.), The Cambridge Companion to Atheism, Cambridge University
Press, Cambridge, 2007.
The year 2013 also saw the publication of the seminal volume by Colin
Campbell, Toward a Sociology of Irreligion, Macmillan, London and Basingstoke,
1971; Herder and Herder, New York, 1972; Writers Printshop, London,
revised edition, 2013 (introduction by Lois Lee, and a new bibliography by
Lois Lee with Stephen Bullivant and Christopher R. Cotter); Alcuin Academics,
London, 2013. Campbell’s book cites 150 quotations for the year of the first
edition, 1971, practically forgotten later, with only an average of a sole citation
every seven years for the period between 1972 and 2006, while between that
year and 2012 they increase to about 14 per annum. The Non-Religion and Secularity
Research Network (nsrn) has grown up around Campbell, and promotes
several scholarly initiatives, above all conventions. Furthermore, the
above-mentioned Lois Lee, is the promoter of a number of editorial initiatives
including the book by E. Arweck, S. Bullivant, L. Lee (eds.), entitled Secularity
and Non-Religion, Routledge, London, 2014, and L. Lee’s “Secular or Nonreligious?
Investigating and Interpreting Generic ‘Not Religious’ Categories and
Populations”, Religion, 44, 3, 2014, pp. 466–482. The same author, L. Lee, has
recently issued Recognizing the Non-Religious. Reimagining the Secular, Oxford
University Press, Oxford, 2015. Further confirmation of interest in the topic is
the recent qualitative-quantitative work by J. Stoltz, M. Schneuwly Purdie, T.
Englberger, J. Könemann, M. Krüggeler, (Un-)Believing in Modern Society, Ashgate,
Farnham, 2016, which examines the situation in Switzerland, suggesting a
new way of being religious or secular.
The issue of atheism has witnessed, throughout the course of history, some
rather contradictory dynamics, like the case of the Dominican monk and natural
philosopher, Tommaso Campanella (1568–1639), revolutionary in his attitude
towards the political-military strength of Spain and the religious-moral
power of the Roman Church. Accused of heresy and imprisoned for 27 years,
between 1599 and 1626, he was the author of Atheismus Triumphatus. Seu reductio
ad religionem per scientiarum veritates. Contra Antrichristianismum Achitophellisticum,
Apud Haeredem Bartholomaei Zannetti, Romae, 1631; Apud
Tussanum Dubray, Parisiis, 1636. This work, after a first Roman and a second
Parisian edition, was republished as Atheismus triumphatus Seu reductio ad religionem
per scientiarum veritates – a reprint of the 1631 Roman edition – for
Germana Ernst, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, in 2013. The fact is that this
Latin version seems to be something of an apologetic of religion, unlike the
Italian-language version, written between 1605 and 1607, but not printed at the
time: L’ateismo trionfato overo riconoscimento filosofico della religione universale
contra l’antichristianesimo macchiavellesco; the manuscript was brought to
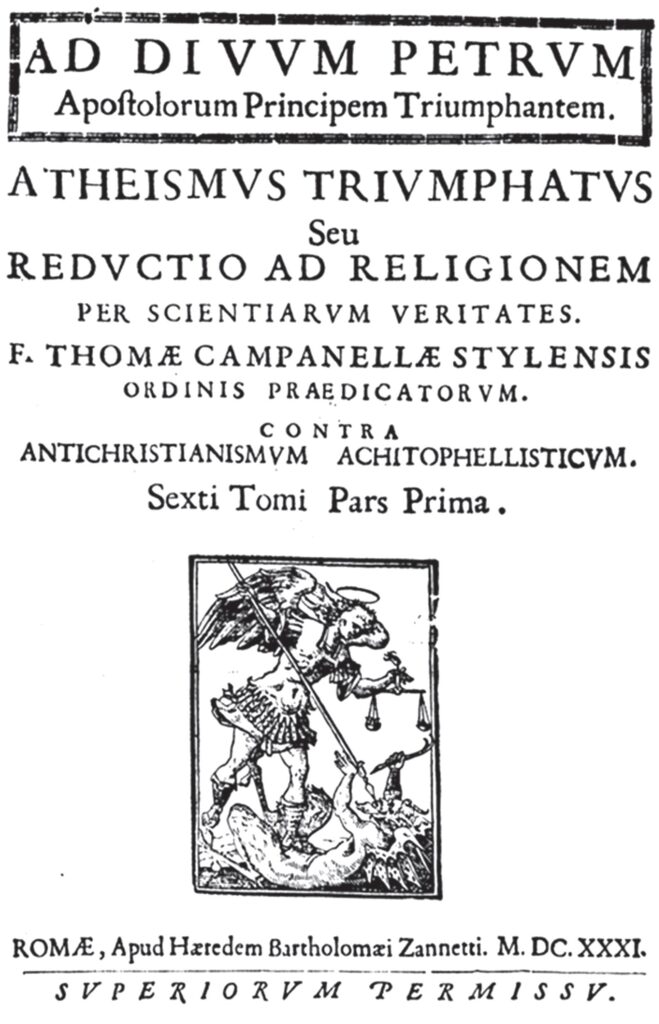
light again by Germana Ernst, who edited it in two volumes for Edizioni della
Normale, Pisa, in 2004. This initial version contains evident differences compared
to the later Latin translation, where quite a few of the important considerations
and assessments made by the Calabrian philosopher earlier, appear to
have been modified. Some scholars speak of the author’s subsequent conversion,
others of the intervention and censorship of the ecclesiastical court and
the Inquisition or even of a kind of “concealment” implemented by Campanella
himself. In any case, the “triumph of atheism” remains confirmed though
from a number of different perspectives.
If Robespierre planted trees to represent the Supreme Being in 1794, today,
it is American Atheists who have chosen to erect granite monuments on which
to sculpt phrases in favour of separation between Church and State.
So, it seems that atheism (seen as denial of any form of the divine, invisible
or visible), non-belief (as a life choice devoid of reflection concerning the
existence of God), agnosticism (as indifference towards the problem of God’s
existence or non-existence), non-belonging (as a refusal of any kind of institutional
link), irreligion (as intended by Campbell, as active rejection of given
religions and religious traditions) and Nones (atheists or agnostics or the nonaffiliated
who embrace no particular church or those who are indifferent to
religion or with no leanings either towards or against religion) are the new
frontiers of sociology’s approach to religion.
From a numerical point of view this universe should not be discounted in
any way. Current figures estimate that numbers for real atheists stand at around
138 million, agnostics at about 684 million, non-religionists at approximately
822 million and non-affiliated religionists at roughly 321 million. The reliability
of these figures is, of course, questionable, but, in theory, their true import
does not appear to be very far from the figures provided here. The field is vast
indeed and still largely in need of exploration by the sociologists of religion.
